Intervista di Angelo Maugeri
Quando inizio queste conversazioni con Mario Radice è l’ultimo scorcio dell’estate del 1984. Ci si incontra a Como, nella sua casa di via Francesco Crispi: una villetta a tre piani, oltre al pianterreno, fatta costruire una sessantina d’anni fa dal padre dell’artista. Vi si accede attraverso un cancelletto di ferro che dalla strada immette in un piccolo giardino ricco di piante e fiori. I nostri incontri avvengono di sera, sul tardi, dalle ventuno in poi, e in genere si protrarranno fino alla mezzanotte, talvolta anche oltre. Le nostre conversazioni hanno luogo quasi sempre al pianterreno, nel soggiorno che si trova a destra, subito dopo il salotto d’ingresso colmo di piante d’appartamento verdi e curatissime. Quand’è il caso di verificare un particolare, o di osservare un’opera, o di esaminare qualche aspetto tecnico del suo lavoro, ci spostiamo nello studio al primo piano, un locale ampio e illuminato a giorno, pieno di libri, riviste, disegni, documenti, fogli, tele, colori, matite, pastelli, pennelli.

È sempre presente, discretissima ma attenta, e pronta a intervenire per precisare una data, ricordare un nome, chiarire un dubbio, la signora Rosetta Martini, da lunghi anni sposa amorevolissima e vigile dell’artista. 87 anni lui, 86 lei. Un udito finissimo in lei, una tarda ipoacusia in lui ora corretta da un apparecchio acustico che ci costringe a parlare a voce alta e chiara. Una volta avviata la conversazione, che ho cura di registrare con un registratore magnetico a cassette, si stabilisce una precisa corrente di simpatia comunicativa. Il primo incontro è del 12 settembre 1984, l’ultimo è del 30 giugno 1985. Rivedrò Radice ancora dopo, per sottoporgli il testo definitivo delle nostre conversazioni, alle quali egli apporterà talvolta qualche correzione e qualche aggiunta.
Per cominciare dico a Mario Radice che da queste conversazioni vorrei far emergere la sua figura di artista nella sua dimensione più umana, intima. Intendo far apparire il suo mondo di oggi e quello di ieri, la sua famiglia d’origine e quella che lui si è poi formata, i suoi ambienti di vita, la sua città, i luoghi che ha visitato, gli amici e i compagni, insomma l’aspetto privato di un’esistenza interamente dedicata all’arte, e certo ricca di ideali e propositi, di giudizi e osservazioni, di gioie e dispiaceri, e interessi, e gusti, e umori personali. Un profilo biografico e un ritratto psicologico oltre che artistico, dunque, e il desiderio di attribuire allo svolgimento temporale della sua arte il compito di animare anche il suo paesaggio umano. Perciò gli chiedo se vuole iniziare ricordando la sua infanzia e la famiglia d’origine, partendo magari dai primi anni di vita e precisando la sua data di nascita, dato che ho notato qualche discordanza sull’anno effettivo della sua venuta al mondo così come appare da cataloghi, riviste e pubblicazioni che lo riguardano.
1898 o 1900?
Sono nato il 1° di agosto del 1898.

Quasi sempre, invece, appare scritto 1900. Come mai questo errore?
Esiste questo errore da sessant’anni. Sono andato sotto le armi con la classe 1900 a causa di una serie di rinvii precedenti. Ho sempre considerato miei coetanei tutti quelli del 1900. C’è però un altro motivo occasionale, ed è questo: una mostra alla quale volevo partecipare aveva fissato il limite d’età a venticinque anni; io ne avevo venti sette, e così mi sono accorciato la vita di due anni.
È lei stesso dunque il responsabile di questo equivoco cronologico?
Sì, ed è capitata la medesima storia a un mucchio di artisti.
A chi?
A Casorati, per esempio. Casorati dichiarava cinque o sei anni in meno di quelli che aveva veramente. Io ero molto amico di Casorati. Ci davamo del tu, benché lui fosse maggiore di me di almeno dieci anni.
Vi toglievate gli anni per poter partecipare alle mostre.
Tutti quanti per motivi analoghi.
Lei è nato a Como. Come era la Como della sua infanzia?
Era senza pericoli. Si poteva camminare per strada. I bambini potevano uscire di casa e attraversare la strada tranquillamente. Certo la città è irriconoscibile oggi nei confronti di allora. Non si può più andare a piedi. Le strade di tutte le città del mondo oggi non sono fatte per poterci andare a piedi, ma sono percorse da automobili che vanno a sessanta chilometri all’ora come minimo. Pensi che due miei colleghi, due artisti di prim’ordine, sono morti in seguito a incidenti automobilistici. Uno era Baldassarre Longoni: è morto quasi istantaneamente sotto un’auto. L’altro era Betto Lotti: è morto pochi anni fa. Era finito sotto un’automobile, ha sofferto per due anni e poi è morto. D’altra parte, una volta c’era più onestà in tutti. C’era meno odio. C’era più ingenuità, che forse è più un male che un bene.
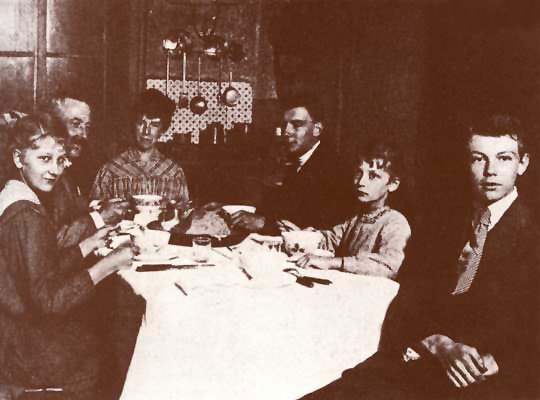
Dove abitava allora la sua famiglia?
In via Adamo Del Pero quand’ero bambino; e poi in via Serafino Balestra: mio padre vi aveva traslocato che io avevo due o tre anni. La mia famiglia era composta dai genitori e da mio fratello maggiore, Pietro. Poi sono nate due sorelle, Felicita detta Licia e Rita. Eravamo quattro figli in tutto. Mio fratello era maggiore di me di un anno e mezzo, le sorelle erano minori di me: una di quattro anni, l’altra di sette.
E i genitori, come si chiamavano?
Mio padre si chiamava Carlo, e mia madre Elvira Vitali.
Erano entrambi di Como?
Entrambi di Como, sì, ma non solo: erano primi cugini e per sposarsi hanno avuto il permesso del vescovo.

Lei conserva i loro ritratti, le loro fotografie? – Certo. – Del fratello e delle sorelle poi che ne è stato?
Pietro è morto a trent’anni, nel ’27, tra le mie braccia. Era un grande invalido di guerra. Aveva contratto la tisi durante la prima guerra mondiale. Delle mie sorelle, Licia è vissuta, vedova, a Rovereto, dove è poi morta, già coniugata Scanagatta; Rita, anche lei vedova, già coniugata Lorusso, vive qui a Como, in questa stessa casa, agli ultimi due piani.
Il papà e la mamma come si comportavano con voi figli? Erano severi, affettuosi?
Non so come qualificare i miei genitori: erano normali nel senso che erano di buona famiglia e non pensavano che al bene dei figli, insomma. Non c’era niente di straordinario in loro. Mia madre era casalinga, mio padre era impiegato presso la Banca Popolare di Como, nella quale è rimasto quarantacinque anni. Gli ultimi quindici anni della sua vita li passò da direttore generale della medesima Banca. Aveva cominciato come cassiere, poi è diventato capoufficio, poi vicedirettore, infine direttore.
Una bella carriera.
Sì, è stato lì tutta la vita. La Banca Popolare di Como dodici anni dopo la morte del mio papà è stata assorbita dalla Banca Popolare di Novara.
Quando è morto il suo papà?
Era del 1870, è morto a ottantuno anni nel ’51.
E la mamma?
Era coetanea del papà, è scomparsa quattro anni prima, nel ’47.
Ricorda qualche particolare per Lei significativo di quegli anni?
Sì, ricordo che quando io avevo sei o sette anni, mio padre guadagnava mille lire all’anno.

Era un buono stipendio?
Oggi sarebbe l’equivalente di circa diciotto milioni all’anno. Erano circa novanta lire al mese. Mia madre doveva fare un’economia di carattere eccezionale per allevare quattro figli.
Quindi una vita abbastanza contenuta.
Sì, non era una vita povera, ma certamente modesta. Però le famiglie cosiddette borghesi in quel tempo non avevano pretese. Il mondo è cambiato completamente e non è neanche paragonabile a quello di allora.
Lei cosa pensa del mondo di oggi rispetto a quello di allora?
Il mondo di oggi è tutto postbellico. Io non ho visto altro che guerre. E non si fa che parlare ancora di guerra. È quello il guaio, specie ora. Siamo tutti quanti un po’ ossessionati dall’idea della guerra nucleare.
Allora, invece, quest’idea del mondo come “mondo perennemente post-bellico”, Lei non l’avvertiva?
No, affatto.

Non l’avvertiva perché era ragazzo e non si poneva il problema?
Allora non c’erano guerre mondiali, erano guerre locali, si parlava della guerra d’Eritrea, poi di quella russo-giapponese e dello sbarco giapponese in Russia, della sconfitta russa in quella guerra e del progresso che aveva fatto il Giappone in quel tempo.
Tutto questo, quando Lei era bambino.
Sì, certamente.
E che idea si faceva del mondo, allora?
Nessuna idea. Ero molto ingenuo. Sono cresciuto lentamente. Non ero affatto precoce. A dieci anni pensavo come adesso un bambino di sei.
Ma immagino che allora tutti i bambini rispetto a quelli di oggi.
Voglio dire che io mi sono sviluppato sempre con qualche anno di ritardo rispetto ai coetanei.
Da che cosa lo avvertiva?
I miei compagni facevano cose che io ancora non avevo fatto. Solo nel disegno io ero più avanti. Prima dei dieci anni già disegnavo, come tutti i bambini, delle cose ridicole; però disegnavo meglio di tanti miei coetanei compagni di scuola. I miei genitori osservavano questi disegni ma non mi hanno mai incoraggiato, anche se per il resto mi seguivano con molta attenzione.
Come Le è venuta questa passione per il disegno?
Ho cominciato a disegnare non so perché. Fin da bambino. Non ricordo bene l’età. Forse a quattro o cinque anni.
Lei pensa che l’ambiente abbia un’importanza notevole per la formazione di un artista?
Non solo di un artista, ma di chiunque svolga qualsiasi professione. Un medico che cresca in una famiglia di medici, è più avvantaggiato di altri, e così via. Pensi ai figli dell’arte. Ce ne sono tanti. Pensi a un fenomeno come Raffaello, che era figlio di Giovanni Santi, un pittore bravo, bravissimo, la cui fama è stata offuscata solo dal fatto di avere un figlio come Raffaello. Ma io ho visto dei quadri di Giovanni Santi e Le posso dire che sono molto belli. Ho visto questi quadri uno a Milano, uno a Urbino e un altro a Fano, sono dei quadri del Quattrocento che si confondono con quelli di Paolo Uccello addirittura. Io mi raffiguro quale doveva essere la vita del piccolo Raffaello. Viveva in una famiglia povera. Quando comincia a fare qualcosa ogni bambino non fa altro che imitare la madre e il padre. Allora non c’erano le case di dieci locali; una casa normale era magari di tre locali grandi così, e lì dormivano, mangiavano, lavoravano. Il bambino vedeva tutto, vedeva il padre che dipingeva, per lui questa era la cosa più naturale del mondo, oltre al mangiare, al bere e al dormire. Una mia pronipote di quattro anni viene qui ogni tanto con le sue matite colorate: “Faccio come il nonno” dice. Quando viene a trovarmi vuol vedere i miei disegni, come li faccio, e mi porta i suoi da vedere.
Magari diventerà una gran pittrice.
È una cosa naturalissima.

Lei però nella sua famiglia non ha avuto dei pittori.
Avevo due zii che dipingevano abbastanza bene: uno era Lucio Vitali, il fratello di mia madre, che si occupava anche di fotografia; l’altro era un loro fratellastro, e si chiamava Antonio Casartelli: aveva un altro cognome perché mia nonna, rimasta vedova, si era sposata ancora. io da ragazzo non pensavo ad altro che a disegnare. I miei libri di testo erano tutti disegnati ai margini. Erano ritratti somigliantissimi dei compagni e degli insegnanti. Non erano caricature: non ne ho mai fatte perché le detesto, sono deformazioni quasi sempre maligne. Disegnavo volti ma anche fiori. Ho cominciato alle elementari. Poi naturalmente prendevo scapaccioni dalla mia mamma perché rovinavo tutti i libri.
E le giornate come le trascorreva?
Ero sempre un po’ bambino, ero inclinato alla solitudine.
Giocava poco?
Sì, poco. La mattina e il pomeriggio, a scuola. Andavo alla Scuola poco lontana di via Perti, che c’è ancora, tale e quale. Le vacanze invece le passavo a Carbonate, un piccolo paese in provincia di Como, insieme con i nonni paterni. Il nonno, Pietro, ospitava me e mio fratello per un mese e mezzo all’anno – allora c’erano tre mesi di vacanza -; l’altro mese e mezzo ospitava le mie due sorelle. Qualche volta si rimaneva a Carbonate un po’ di più, qualche volta un po’ di meno. E poi ci andavamo anche una settimana a Pasqua e una a Natale, tutti gli anni.

Com’era Carbonate?
Era un paese di cinquecento abitanti. Li conoscevo tutti, naturalmente. Mio nonno era vicesindaco, e il proprietario di tutto il paese era sindaco. Questo era milanese, ufficiale di cavalleria da giovane; poi aveva abbandonato la carriera militare e probabilmente era ricco, come tutti gli ufficiali di cavalleria di quel tempo aveva investito gran parte del suo capitale in un’impresa di tram a cavalli. Lui, di cavalli, era pratico, naturalmente. E ha guadagnato un mucchio di soldi. Quando si è ritirato dall’azienda tranviaria, ha acquistato praticamente tutte le terre di Carbonate, tutto il paese, escluse due o tre casette con due o tre famiglie con il loro terreno. Tutto il paese di Carbonate era di sua proprietà: più di mille ettari di terreno, un patrimonio che oggi si aggirerebbe intorno ad alcuni miliardi di lire. Mio nonno era il fattore di questo ricco possidente; ma è morto povero: mia nonna non aveva i soldi per il funerale e ha dovuto chiederli al mio papà. Mio padre ha dovuto pagare il funerale di suo padre perché il nonno non aveva lasciato neanche un soldo d’eredità, cosa piuttosto rara per un fattore di un patrimonio simile. Questo l’ho detto perché io mi vanto di questa onestà, della quale mio padre non ha mai parlato – però tutto era sottinteso.
Lei ha una visione cristiana della vita e dell’aldilà?
Certo: dovrei forse avere una visione pagana come duemila anni fa? Mi pare impossibile che con la morte finisca tutto. La vita è così complicata! Se uno muore e poi sparisce tutto, allora siamo pari agli insetti. Invece noi sappiamo fare mille cose che gli insetti non faranno mai.
Lei non ha mai avuto dubbi sulla sua fede, magari in gioventù?
Non ho mai avuto nessun dubbio. Quand’ero giovane, però, a giudicare da quello che sono adesso, non capivo nulla della vita, non pensavo né all’immortalità, né allo spirito, tantomeno alla religione.
Non si poneva il problema?
No, niente. Ho pensato a queste cose quando sono venuti i dispiaceri grossi della vita. Prima mi è morto il fratello; vent’anni dopo è morta anche mia madre, davanti a me, salutandomi, ed ero io solo lì, davanti al letto di morte. Mio padre dormiva in quel momento, perché l’aveva vegliata tutta notte. Era stanco, io gli avevo detto: “Dormi un po'”. Si era addormentato subito, tutto vestito. Dopo un paio d’ore la mia mamma è morta. Allora l’ho svegliato, cosa dovevo fare?

È stato il dolore a porLa di fronte a questo problema.
L’esser posto di fronte alla morte. E poi tanti altri dispiaceri che ho avuto. Rischi, anche. Allora ho cominciato a capire; ma il mio risveglio religioso è venuto tardi. Quando ero ragazzo, sì, anche allora ero religioso, verso i quindici, diciotto anni. Le dicevo dei miei soggiorni estivi a Carbonate, presso i nonni paterni. Mio nonno era ben visto da tutti, perché quando un contadino non poteva pagare l’affitto oppure restava indietro per qualche debito. Ecco, il padrone veniva a Carbonate quattro, cinque volte l’anno e si fermava due giorni, guardava i conti, si accorgeva dei crediti e diceva a mio nonno: “Perché non l’ha mandato via, questo?”, e mio nonno rispondeva: “Perché pagherà”. “Come pagherà? È indietro di tre anni!” “Ci penserò io.” Il padrone si fidava. Poi capitava l’anno buono per i bachi da seta e i contadini pagavano tutti i debiti arretrati. Tutti gli portavano gran rispetto. Mio nonno lo chiamavano “sciür Peder”, perché tutti parlavano in dialetto. “Sciür Carlo” era mio padre. Io ero “el Mario”. Perché Le dico questo? I contadini erano tutti analfabeti. Ma sapientissimi. Per quale motivo? Perché sapevano il Vangelo. Ho fatto un calcolo. Uno andava a messa tutte le domeniche, tutte le feste, mettiamo cinquanta feste all’anno; arrivava a cinquant’anni che aveva sentito duemila e cinquecento prediche. E il curato cosa predicava? Predicava, forse, “Dovete rubare, dovete ammazzare?”, predicava il contrario, predicava il far bene. È per questo che i contadini erano molto più sapienti di adesso. E conoscevano tutti i personaggi del Vangelo. “Non fare come questo. Sembri quello.”, e nominavano i personaggi del Vangelo, tanto gli uomini che le donne, perché andavano tutti a messa. Quando uno non ci andava: “Dove ta se’ staa, ta se’ staa in Francia?”, cioè qualcuno emigrava in Francia e quando tornava, per fare “il di più”, non andava a messa per cinque o sei anni, poi quando si sposava, tornava ad andarci. Ecco perché la gente si domandava: “Ma perché non viene a messa quello lì?”, e la risposta era: “Perché l’è staa in Francia”.
Ma cosa era andato a fare in Francia?
Era andato a Strasburgo, per lo più, a fare il contadino, il muratore. Tornava con le idee cambiate.
Torniamo al discorso sulla sua religiosità, ricuperata verso i quarant’anni.
Voglio ricordare com’è avvenuto di fatto questo mio ritorno alla religione. Una domenica mattina incontro il mio amico Terragni, l’architetto Giuseppe Terragni. “Dove vai così di corsa?” faccio io. E lui: “A messa”. Parlava così, quasi a monosillabi. Poi aggiunge: “Be’, che fai, vieni anche tu?” E io ci sono andato. Così ho ripreso i miei contatti con il Padreterno. Terragni era un cattolico praticante. Da allora, si andava sempre insieme a messa nella basilica del Crocifisso in viale Varese.
Lei ravvisa nelle sue opere un certo riflesso di questa ricuperata religiosità?
Non ho mai pensato a una cosa simile, perché non sono mai stato ateo, quindi un conto è ritornare a essere praticante più o meno regolarmente e un conto è essere ateo.
Ma Lei non trova nella sua opera qualche nota di misticismo, di interiorità religiosa, qualcosa del senso religioso che Lei sente nella natura, nell’universo?
Non lo so, io non so dirlo. Spero di sì.
Lei, dal punto di vista della pittura figurativa, ha trattato prevalentemente soggetti religiosi, no?
Sì.
Come lo spiega?
Perché il tema religioso è in testa a tutti gli altri. L’uomo è per sua natura religioso. Supponiamo che nel nostro mondo ci siano una cinquantina di religioni, tanto per dire un numero qualunque: possibile che siano tutte false? Probabilmente sono tutte incrinate perché nessun uomo è perfetto, ed è facile sbagliare. Tutti quanti siamo pieni di errori. Ma tutte queste religioni sono alla portata di ciascuno, secondo il luogo dove è nato e cresciuto. Sì, ci sono gli atei; ma secondo me anche l’ateismo è una forma di religione. Ora voglio dire: la religione, qualunque essa sia, chi è che la insegna a ciascuno di noi? Tizio? Caio? Uno straniero mai visto? No, la insegna la mamma.
Quindi Lei attribuisce un compito molto importante alla mamma nell’educazione dei figli?
Altro che! La mamma insegna tutte le cose più importanti del mondo, le cose più elementari e fondamentali, quelle che non si imparano a scuola. Le cose più importanti si imparano dalla mamma. Anche dal papà. Ma soprattutto dalla mamma.
Lei poco fa diceva che i contadini, tante volte, saldavano i debiti arretrati quando veniva l’annata buona per i bachi da seta.
Sì, perché l’allevamento del baco da seta è un rischio, sempre. I bachi nascono in maggio e finiscono in giugno quando hanno fatto il bozzolo e vi si sono rinchiusi. Allora per ogni contadino andava bene se aveva foglie di gelso a sufficienza. Se non aveva abbastanza gelso, doveva comprarlo altrove, e allora era un disastro perché veniva a costare il triplo. Il contadino doveva comprarlo e pagarlo subito. Poi la cura del baco richiedeva una temperatura costante tra i quindici, sedici gradi centigradi, non doveva andare mai sotto i quattordici e non superare i diciotto. Il baco, che era la specialità di quella zona – al confine con la provincia che attualmente appartiene a Varese -, è delicatissimo e risente delle variazioni di temperatura. Se per esempio il contadino si dimenticava di chiudere le finestre, o di aprirle, quando andava a guardare i bachi, metà erano morti. E siccome non poteva ormai ricominciare daccapo, metà del raccolto se ne andava. Ed era un disastro perché vi lavoravano per quaranta giorni tutti quanti, a raccogliere le foglie di gelso e a portarle lì, a pulire continuamente perché i bachi se non sono puliti non fanno la seta. La temperatura andava tenuta con le stufe sempre accese, e allora ci doveva essere in ogni locale il termometro. Per quaranta giorni si trattava di un rigore quasi militare, e lavorava tutta la famiglia, dai vecchi di cento anni ai bambini di sette, otto. Quando andava bene, andava bene per tutti; male, male per tutti. A quei tempi, quel periodo di maggio e giugno era terribile, io me lo ricorderò sempre.
È stata molto importante per Lei l’esperienza delle vacanze a Carbonate.
Quando ripartivo per Como perché si riaprivano le scuole, mio nonno mi dava uno scudo d’argento da cinque lire – pari a circa novantamila lire di oggi, non meno, forse più – e mi diceva: “Rispetta i superiür”, e poi mi voltava le spalle e se ne andava. Era un uomo di pochissime parole. Il mondo vive su questo rispetto verso i superiori, a pensarci adesso. Ma allora non capivo niente e mi domandavo: “Chissà perché mi dice queste parole?”. Lui è morto a ottant’anni, io l’ho sempre rispettato. Al funerale era presente tutto il paese.
E la nonna?
Era come il nonno.
Questi i nonni paterni. E i nonni materni?
Il nonno materno è morto a cinquant’anni, io non ero ancora nato. La nonna materna era sorella della nonna paterna (Le ho detto che i miei genitori erano cugini primi): l’ho conosciuta ed era molto sensibile. Ha cominciato a studiare inglese sui sessant’anni. Io mi stupivo: “Come, perché?” “Magari, appena posso, vado in Inghilterra, è meglio saper l’inglese.” Studiava l’inglese con serietà.
Ammirevole veramente.
Vuol dire che aveva la mania di studiare, come mio fratello e me. Anch’io ho sempre studiato, ma solo quello che mi ha interessato. Se non ci fosse stata la mia mamma a sorvegliarmi, sarei stato fresco a scuola. La mia mamma era intelligentissima e per sua fortuna aveva una memoria di ferro. Mio fratello aveva l’abitudine di studiare ad alta voce, la mia mamma lo sentiva e dopo un mese o due gli faceva delle domande su quello che aveva studiato, ed io restavo esterrefatto. Poi anche le mie due sorelle hanno cominciato a imitare il fratello e studiavano ad alta voce, così la mia mamma provava le lezioni a tutti senza aver mai avuto un libro in mano, magari mentre faceva da mangiare.

La sua mamma aveva fatto degli studi superiori?
No, aveva fatto solo qualche anno delle scuole magistrali, poi aveva interrotto.
Lei ricorda qualche suo insegnante in particolare?
Non ricordo più nessuno. Ricordo solo che nel disegno geometrico prendevo zero, mentre prendevo nove e dieci nel disegno della copia dal vero. A un certo momento la pittura mi è diventata una specie di fissazione. Adesso è diventata un’abitudine; allora era una fissazione, perché bisognava anche lottare contro tanti ostacoli. Ma dipingevo tutto con naturalezza, facevo teste, qualunque cosa, copiavo. Mi immergevo totalmente nel mio lavoro e non mi accorgevo di quanto mi succedeva intorno. Per esempio quand’era l’ora di mangiare, bisognava che venissero a prendermi per portarmi a tavola.
Dopo le elementari che scuole ha fatto?
Tre anni di scuole tecniche – così si chiamavano – e poi l’Istituto Tecnico Commerciale “Caio Plinio Secondo”. Mi sono diplomato, poi mi sono iscritto all’Università di Milano in veterinaria. Ho frequentato saltuariamente per due anni questa facoltà, ma poi non son potuto andare più avanti.
Perché?
Come Le ho detto, mio fratello era un grande invalido di guerra. Eravamo nel ’22. Io frequentavo pochissimo o niente del tutto, però insomma mi interessavo di veterinaria perché amavo gli animali. Il mio papà non ha potuto aiutarmi economicamente perché doveva far curare mio fratello, che allora era affidato al massimo tisiologo del mondo. Mio fratello era al fronte durante la prima guerra mondiale, ha avuto quattro volte la polmonite, la pleurite, malattie dei polmoni insomma, ed era in prima linea, era alpino sulle Tofane, a circa tremila metri sul livello del mare. Era sottotenente; ma allora quelli come lui li chiamavano aspiranti cadaveri, perché comandavano un plotone della prima linea. All’ospedale da campo migliorava, e subito dopo tornava in prima linea. Questo è successo tre, quattro volte. Poi è andato in un ospedale più arretrato. Sei mesi di questa tragedia, finché hanno dato a mio fratello sei mesi di licenza per convalescenza. Allora il mio papà lo ha fatto visitare, e il medico ha detto: “Qui non è questione di polmonite o di pleurite, questa è fior di tisi”. Trascurando le malattie ai polmoni, allora quasi tutti diventavano tisici. A quel tempo questa malattia era invincibile, mentre oggi non fa più paura. Fatto sta che mio padre, parlando con qualche medico, ha saputo che l’unico in Italia che poteva curare il figlio era il professar Forlanini, l’inventore del pneumotorace. E Forlanini ha detto: “Un polmone è perduto, ma l’altro è soltanto intaccato. Se salvo questo polmone, può campare fino alla tarda età”. Insomma mio fratello ha girato per tre, quattro anni sanatori a pagamento, sempre in cura da Forlanini. Naturalmente anche Forlanini costava, e mio padre ha dovuto consumare tutti i suoi depositi, perché nella Banca Popolare di Como – dove appunto lui ha lavorato tutta la vita – la pensione consisteva in un versamento obbligatorio ma anche volontario, cioè uno poteva aumentare quello che versava alla banca, e quando si ritirava, riceveva un capitale, non una pensione distribuita nel tempo. Dunque mio padre spese per mio fratello il capitale pensionistico. Inizialmente con tutte quelle cure mio fratello era guarito completamente. Forlanini gli aveva detto: “Adesso basta con le cure, Lei però non deve fare strapazzi e non deve ammalarsi né di bronchiti né di polmoniti, stia attento a quello che fa; basta, può campare anche cento anni, le ferite sono cicatrizzate”. Mio fratello durante quel periodo aveva studiato e si stava laureando in scienze agrarie, gli mancava solo qualche esame per finire. Improvvisamente prese un’influenza che è diventata bronchite, poi polmonite, poi pleurite e poi tubercolosi ancora. È quello che capitava al novantacinque per cento dei guariti dalla tisi, perché stavano così bene che non ci pensavano più, e si trascuravano. Invece bisognava vivere non come un giovane di trent’anni, ma come un anziano di sessanta che cerca di curarsi ogni più piccolo raffreddore, e magari si riguarda più che può, soprattutto quando fa freddo o ci sono sbalzi di temperatura. Insomma, se fosse stato più attento. Il risultato è stato che abbiamo perso il fratello, e mio padre non ha potuto più aiutare né me, né le mie sorelle. Io ho dovuto interrompere gli studi.
In ogni modo Lei aveva avuto la possibilità di andare a scuola di pittura e scultura?
Sì, mio padre mi ha mandato a prender lezioni dal miglior pittore di Como di allora, si chiamava Achille Zambelli. Poi anche da uno scultore, Pietro Clerici.
Il suo papà si convinse subito?
Mandava le sorelle a lezione di pianoforte e mandava me a lezione di pittura.
Come era Zambelli?
Veniva da Brera, era giovane, entusiasta insomma. Era un pittore bravo. Poverissimo, guadagnava molto poco; era onesto. C’è ancora qualche suo quadro in giro, presso qualche collezionista di Como.
E Clerici?
Anche Clerici ha fatto delle belle statue. Io poi andavo anche alle scuole serali d’arte, due o tre volte la settimana, e a una scuola domenicale tutta la mattina dalle otto alle dodici. E questo dai quindici ai diciannove anni. Ho frequentato i corsi serali di pittura e scultura, sempre con Zambelli e Clerici, presso l’Istituto “Pro Cultura Popolare”, e la domenica mattina, invece, i corsi di un’associazione fra imbianchini e decoratori.

L’Istituto “Pro Cultura Popolare” dove si trovava?
È l’Istituto “G. Carducci” di via Cavallotti. Questo Istituto, lo aveva fondato l’ingegner Enrico Musa. Enrico Musa è stato uno dei personaggi più importanti di Como, proprio perché ha fondato l’Istituto “Carducci”, che è un istituto di scuole serali in cui si insegnano quasi tutte le discipline; oggi vi si fanno soprattutto corsi di lingue, e non si fa pagare quasi niente agli allievi. L’ingegner Musa ha progettato e fatto costruire esclusivamente a sue spese lo stabile. La mia ammirazione per lui è questa: ha sacrificato probabilmente i due terzi del suo patrimonio per realizzare quest’opera, che è forse unica in tutta Italia. Lui era di famiglia ricca, era un setaiolo; ma per far questo Istituto ha dato fondo praticamente a tutte le sue risorse. I suoi colleghi industriali, qui a Como, lo ritenevano un matto. Un giorno – molti anni dopo, naturalmente – mia moglie è andata da lui per comprare un taglio di seta. L’ingegner Musa mi conosceva perché io ero amico e quasi coetaneo di uno dei suoi figli, Mario, insieme al quale ero andato sotto le armi nella prima guerra; però non conosceva ancora mia moglie, non l’aveva mai vista. Quando le ha domandato chi fosse, lei gli ha detto: “Sono la moglie di Mario Radice”. “Mario Radice, il pittore?” “Si” risponde lei. “Bene,” le ha detto lui in dialetto “che la se regorda che a Com mì e il so’ marì sem semper pasà per matt!” E mia moglie, questa frase, non se l’è più dimenticata. È stato l’unico industriale qui a Como a fare una scuola per operai, per povera gente. È importante. Anche un famoso industriale, grande dieci volte più di Enrico Musa, che si chiamava Francesco Somaini, ed era il nonno dello scultore Somaini, ha fatto costruire qualcosa per la città: il Tempio Voltiano, che ha pressappoco lo stesso valore di spesa dell’Istituto “Pro Cultura Popolare”. Però questo Somaini non ha dato fondo al suo patrimonio come il Musa, appunto perché era molto più ricco, e allora la sua azienda era fiorente. Il figlio di Enrico Musa, Mario, una volta, commentando l’impresa paterna, mi ha detto: “Mi resti büff!”, insomma “Io resto al verde!” voleva dire.
Quindi la sera Lei frequentava i corsi di pittura e scultura organizzati all’Istituto “Pro Cultura Popolare” dai maestri Zambelli e Clerici, presso i quali andava anche a prendere lezioni private. La domenica mattina, invece, andava a frequentare i corsi di un’associazione di imbianchini e decoratori.
I maestri erano sempre Zambelli e Clerici. Insomma, per seguire questi due e imparare di più, frequentavo anche i corsi che venivano organizzati qua e là a Como.
Diceva di questa associazione di imbianchini e decoratori.
Allora il disegno si insegnava anche a chi voleva intraprendere il mestiere di imbianchino e decoratore. Adesso non si fanno più le decorazioni che si facevano una volta sui soffitti e sulle pareti delle stanze. Ancor oggi, se Lei visita certe case padronali qui a Como, rimane meravigliato dei lavori di decorazione che vi hanno fatto. E ce ne sono tante, più di quanto s’immagini. A Como c’è sempre stato un certo gusto per l’abitazione, soprattutto nelle persone che possono permettersi di spendere delle cifre alte.
Questo suo essersi accostato all’arte anche attraverso la decorazione ha influito nella sua decisione di dedicarsi all’arte astratta?
Non mi sono mai dedicato unicamente all’astrattismo e non ho mai abbandonato la pittura figurativa. Ho sempre pensato che la pittura è una sola. Il tema ha poca importanza.
Quindi l’arte decorativa non c’entra?
No, no. Non c’è nessuna relazione, neanche in minima parte, perché in quella scuola insegnavano a copiare dal vero e basta. E anche un imbianchino doveva imparare a copiare dal vero. Mentre un imbianchino copiava una gamba, un braccio, io copiavo un modello, un nudo, o una testa.

Davvero un bell’impegno! C’erano, dunque, queste scuole di disegno, pittura, scultura, a Como?
In tutte le città civili c’erano queste scuole. Si insegnavano le varie tecniche ma soprattutto la copia dal vero. Io ero un ritrattista, ho fatto anche paesaggi, ma ero più ritrattista. Ho imparato a disegnare come si insegnava una volta. Adesso non si insegna più. È per questo forse che Argan ha scritto che la pittura oggi è morta. Ma non è vero che sia morta, anche se è morto De Chirico che, secondo me, è il più grande pittore di questo secolo in tutta Europa. De Chirico è superiore anche a Picasso. Io preferisco De Chirico perché è più profondo. Però lo splendore di De Chirico è durato dodici, quindici anni al massimo, fino ai suoi quarantacinque, cinquanta anni, poi è decaduto un po’. È sempre stato a un alto livello, però non è stato più quello della cosiddetta pittura metafisica. Questa definizione – pittura metafisica -, l’aveva data Bontempelli, che è nato a Como, ed è abbastanza indovinata. I dipinti cosiddetti metafisici sono ancora di uno splendore straordinario. Era De Chirico un vero pittore appassionato, aveva un carattere molto diverso da quello di Carrà, che in Italia viene subito dopo di lui. In assoluto, dopo De Chirico viene Picasso, poi Matisse, poi Carrà e tanti altri come Sironi, Casorati. Erano quasi tutti miei amici. Ho imparato molto di più da queste persone che ho nominato che da Zambelli. Da quest’ultimo ho imparato la tecnica, cioè il mestiere; e ciò che riguarda il mondo spirituale dell’artista, l’ho imparato da De Chirico, da Casorati, da Carrà, da Sironi e soprattutto dal Bernasconi di Cantù..Bernasconi, lo vedevo sovente. Non che come pittore fosse migliore degli altri, forse è un po’ inferiore a Carrà, ma ha fatto anche lui dei bellissimi quadri che non sono conosciuti come meriterebbero. È un nome da rivalutare perché i suoi quadri migliori sono di prim’ordine, al livello di Casorati e Sironi. Solo che mentre Sironi, poniamo, ne ha fatti cinquanta e Carrà venti, lui ne ha fatti dieci.
Come mai?
È vissuto a lungo ma è vissuto lottando contro la miseria per tutta la vita. Aveva molti figli a cui provvedere. Aveva fatto tre anni all’Università di Pavia, alla facoltà di matematica. Non aveva una grande salute. Poi non se la sentì più di continuare. Suo padre lo aveva aiutato un po’. Poi lui è andato a vivere per un certo tempo a Parigi. L’unico figlio maschio gli era morto nella prima guerra. Lui viveva di traduzioni, traduceva parecchio dal francese.
Torniamo a Lei. La sua formazione è poco conosciuta. Quando era ragazzo, al di là di quei primi insegnanti Zambelli e Clerici e al di là, più tardi, di quei supermaestri come De Chirico, Carrà, Casorati, Sironi, quali influenze ha subito?
Le influenze furono tante, però nessuna preponderante. Direi che la più importante è stata quella di mio fratello. Come Le ho già detto, mio fratello era malato e passava quattro o cinque mesi all’anno nei sanatori e studiava. Anche lui aveva fatto l’istituto tecnico, poi si è messo a studiare latino, greco e filosofia. I suoi amici laureati in lettere gli dicevano: “Come fai a conoscere il latino e il greco?” Rispondeva: “Ho studiato”. E qualche amico gli suggeriva di leggere i testi fondamentali. L’aiuto di mio fratello è stato determinante per i suoi consigli preziosi, come pure determinanti sono state a lungo andare le risposte dei più importanti pittori italiani alle mie domande. Mio fratello ed io studiavamo sui libri il modo di fare una raccolta di fiori e piante campestri, e seguivamo alla lettera tutte le istruzioni con entusiasmo. Poi abbiamo fatto una bella collezione di farfalle che purtroppo è andata distrutta quando noi siamo partiti per la guerra e il nostro papà si è dimenticato di curarla. Mio fratello, ripeto, ha avuto un’influenza enorme sulla mia formazione. Lui aveva proprio lo spirito del naturalista. Poi era impegnato anche politicamente, era uno dei tre o quattro capi del socialismo italiano a Como, insieme con Virginio Bertinelli, che poi è diventato parlamentare, dopo la guerra. È morto anche Bertinelli, purtroppo; era un brav’uomo, ero molto amico anche di lui. Nella nostra famiglia non c’erano tradizioni socialiste. Mio fratello non era proprio un marxista, perchè criticava Marx con molto rigore. Certo, Marx in tante cose aveva ragione, perchè lo sfruttamento dell’operaio è vero che c’è stato, non era un’invenzione di Marx, ma adesso è quasi sparito, speriamo che sparisca del tutto. Ma lo sfruttamento vergognoso dei poveri c’è ancora, specialmente in tante zone d’Italia, nelle zone più povere.

E dal punto di vista artistico, chi o che cosa ha esercitato maggiore influenza su di Lei?
Dal punto di vista artistico, i musei. Quand’ero ragazzo, mio zio, un fratello della mia mamma, mi ospitava tutti gli anni a Milano per una decina di giorni, e un giorno si e uno no, e sovente tutti i giorni, io me ne andavo a Brera a vedere sempre gli stessi quadri. Andavo anche al Castello o al Poldi Pezzoli. Più frequentemente guardavo i quadri degli autori precedenti il Rinascimento e poi da Raffaello in avanti. Saltavo il Barocco perché mi stufava un po’, Io amo anche il Barocco, ma amo di più tutti i periodi precedenti. Però ci sono degli uomini di genio anche nel Barocco, come il Caravaggio che è un colosso; ma il suo colore è un po’ deficiente, non è bello come il colore del Trecento, del Quattrocento. Quando stavo da questo mio zio, che mi voleva tanto bene, andavo anche alle mostre di arte moderna. A Brera, come Le ho detto, ci andavo quasi tutti i giorni. Conosco a memoria tutti i quadri di Brera, ancora adesso. Di tutte le città che ho visitato, spesso appositamente, conosco tutti i musei. Musei e chiese. Le chiese erano sempre al buio e allora dovevo lottare con il sagrestano, con il prete. Per vedere un quadro andavo in piedi anche sull’altare!
La scacciavano dalla chiesa?
Eh, si! Quasi tutte le chiese sono buie. Prendevo una sedia, la mettevo sull’altare, ci salivo sopra levandomi prima le scarpe, naturalmente. Poi arrivava sempre qualcuno che avrebbe voluto denunciarmi alla forza pubblica; e non una volta sola, ma molte volte. Una volta sono rimasto chiuso in Santa Maria Novella, a Firenze, perché pensavano fossi andato via e invece ero ancora dentro. Sono rimasto li da mezzogiorno alle quattro e mezzo del pomeriggio, senza neanche poter mangiare qualcosa. Avevo trent’anni, forse meno. In questa chiesa un pittore stava ripassando degli affreschi di Giotto, intorno alle figure faceva un contorno scuro, nero. Io gli domando: “Cosa sta facendo?”, e lui: “Non lo vede? Sto restaurando”. “Ma perché fa quel contorno?” “Una volta c’era.” “Ma se non c’è più perché lo rifà?” “È andato via.” “Chi è che l’ha levato?” “È andato via per conto suo.” “Ma il nero non impallidisce mai! Come fa a dirlo? Insomma, cose da pazzi! Di quello che in Italia è successo in fatto di restauro è meglio non parlare! Quel pittore era su un palco, allora io ho scosso il palco con le mani, così, quello s’è impaurito, è sceso precipitosamente, la chiesa era vuota, lui non poteva chiamare nessuno, perciò se n’è andato, e non l’ho più rivisto. Uscito il pittore, il sagrestano ha chiuso le porte pensando che non ci fosse più nessuno ed io sono rimasto dentro. Dopo, sono salito io sul palco e ho visto che per fortuna quello lì usava una pittura a tempera, che con l’acqua si poteva lavare. Ho perfino scritto una lettera al Ministero dei Beni Culturali, ma non ne ho più saputo niente.
Che pensa del restauro in generale?
C’è una scuola a Roma e un’altra a Firenze. Quest’ultima è forse migliore. Io penso che non si debbano ricostruire le parti mancanti. Se si deve fare la ricostruzione, bisogna affidarla a un colosso dell’arte, cosa che non capita mai. Per esempio, se quel Giotto fosse stato ritoccato da De Chirico, magari ci sarebbero voluti tre anni invece di una settimana, ma alla fine il risultato sarebbe stato più plausibile. Certo, chissà quanto sarebbe venuto a costare! Piuttosto che affidare il restauro a degli inesperti, converrebbe lasciare le opere così come stanno.
Dopo aver interrotto gli studi universitari a causa della malattia del fratello, come ha risolto il problema dell’occupazione?
Mi ha aiutato un mio zio, Antonio Casartelli, che era ragioniere capo alla Prefettura di Como e mi ha trovato un posto, appunto, in Prefettura. Lavoravo mezza giornata e guadagnavo qualcosa, tanto per rimborsare il mio papà che mi manteneva. Poi un altro mio zio, che si chiamava Guido Vitali ed era il direttore generale del gruppo delle cartiere di Fabriano, mi ha suggerito di partecipare a un concorso come impiegato in una società elettrico-tranviaria di Camerino, nelle Marche. Ho concorso, ho vinto quel concorso, forse con la raccomandazione dello zio, e sono rimasto a Camerino quasi due anni. Da Camerino sono tornato a Como perché mio padre mi aveva avvertito che cercavano un impiegato per la società che gestiva i battelli del lago. Era una società privata, allora, e sono stato assunto subito lì.
L’esperienza di Camerino Le è servita?
Mi piacevano le Marche. Stando a Camerino parlavo quasi marchigiano, con l’accento di lì. La zona in cui abitavo mi piaceva molto. Poi c’è da dire che da Camerino a Fabriano c’è un’ora di autobus, quindi andavo tutte le settimane a Fabriano a passare una giornata in fabbrica con mio zio, per veder funzionare le macchine e per imparare qualcosa di nuovo. Fatto sta che, usando il sistema delle domande scritte su un taccuino, facevo un mucchio di domande a mio zio su cose che riguardavano la fabbricazione della carta. Mio zio era uno dei più noti tecnici italiani dell’epoca in materia di industria cartaria: aveva apportato delle modifiche importanti negli stabilimenti che aveva diretto, sia a Fabriano che a Pioraco, in provincia di Macerata: perché un gruppo di cartiere era a Fabriano e un altro a Pioraco. Pioraco è un paese che dista cinquecento metri circa da Camerino, come Brunate da Como, una mezz’ora di strada a piedi. A Pioraco c’erano tre cartierette artigianali: grazie a mio zio si sono ingrandite e messe insieme al punto da diventare un’unica grande cartiera con macchine modernissime. Così non pensavo più all’università e dipingevo. Posso dire che per almeno un paio d’ore al giorno ho sempre dipinto, anche con tutti quegli spostamenti. Questa era la cosa più importante, perché ci tenevo a trovare il modo di dipingere e di non fare altro. Stando vicino a mio zio, ho imparato molto dal punto di vista della tecnica cartaria. A quel tempo viveva ancora mio fratello, io ero tornato a Como, come Le ho detto, e lavoravo come impiegato presso la società lariana dei battelli.

Un giorno mio padre conobbe un cartaio di Lecco con il quale doveva avere dei rapporti di lavoro. Parlando con lui, il mio papà gli disse: “Non avrà bisogno nella sua cartiera di un tecnico bravo, che sia anche onesto etc.?” “Sì, forse mi servirebbe, perché sto modificando una delle mie tre cartiere.” E allora mi ha chiamato e io sono andato a lavorare in una cartiera vicino a Lecco, una cartiera interessante. Sono stato preso come tecnico, cioè facevo l’orario di una squadra di operai, dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22, o dalle 22 alle 6 del mattino. Facevo uno dei tre turni e sono rimasto lì sette o otto mesi. Mentre ero impiegato in quella cartiera ho saputo che la Cartiera Vonwiller di Romagnano Sesia, in Piemonte, cercava dei tecnici specializzati. La Vonwiller era una delle maggiori cartiere d’Europa, era forse la più importante d’Italia, e fabbricava tutti i tipi di carta, anche quelli più fini. Ho concorso e sono stato assunto.

Quindi da Lecco è andato a Romagnano Sesia, in provincia di Novara.
Dove sono rimasto un anno e mezzo quasi, facendo quello stesso orario che Le ho detto: uno dei tre turni. Questo mi dava la possibilità di avere a disposizione un certo numero di ore consecutive per dedicarmi alla pittura. Dopo otto mesi, mi hanno messo fisso di giorno in un reparto che andava giorno e notte, ma io ne ero responsabile tutte le ventiquattr’ore. Il reparto era affidato a me: avevano capito che mi davo da fare, e così mi è andata bene. Durante la mia permanenza a Romagnano Sesia ho conosciuto mia moglie, che era insegnante di matematica nella scuola media di quel comune. Ho sempre continuato a dipingere anche a Romagnano Sesia: dipingevo più allora che adesso, molto di più.

Vorrei approfondire il discorso del suo matrimonio con la signora Rosetta.
Mia moglie si chiama Rosetta Martini. Allora era appena laureata e insegnava a Romagnano Sesia. L’anno prima aveva insegnato in Riviera ad Albenga, poi s’era resa libera una cattedra a Romagnano ed era venuta lì insieme con una amica, anche lei insegnante.
Vi siete conosciuti subito?
Romagnano è un paese piccolo, si fa in fretta a conoscersi. Abbiamo fatto amicizia e ci frequentavamo, andavamo al teatro insieme o facevamo la passeggiata fino alla stazione ferroviaria, che era la passeggiata del paese. Ci incontravamo quasi tutti i giorni, mangiavamo allo stesso ristorante e io per farmi ben volere da lei facevo delle mattane simpatiche.
Mattane?
Sì, per esempio mi mettevo a mangiare al ristorante con l’ombrello aperto: cose così, per ridere, eravamo giovani, si capisce, molto spensierati. Lei aveva ventiquattro anni, io venticinque, a quell’età si è svelti a far nascere le simpatie. Un giorno io le ho detto: “Guarda che a Cantù, vicino a Como, c’è un concorso per una cattedra di matematica in una scuola”. “Be’, potrei farlo” mi ha risposto lei. Ha fatto il concorso ed è riuscita la prima, e quindi ha avuto la cattedra. A Romagnano invece aveva solo il posto di supplente. Così abbiamo continuato a frequentarci. Un giorno ci siamo incontrati in treno, in una carrozza di terza classe, perché viaggiavamo sempre in terza sia io che lei. Ci siamo messi a chiacchierare e a un certo punto le ho detto queste precise parole: “Be’, io mi sono reso conto che non posso perderti, quindi non mi resta che sposarti!” Proprio così. Tiro fuori un calendario dalla tasca, glielo do in mano e dico: “Cerca il giorno che ti va bene: per me van bene tutti”. Lei è venuta letteralmente giù dalla luna, perché, pur provando molta simpatia per me, mai e poi mai pensava al matrimonio. Non aveva mai avuto la smania di sposarsi , forse anche per questo mi ci ero affezionato. Così pure non ha mai avuto la smania dei soldi, perché il mio papà era proprio al verde in quel periodo: se lei pensava ai soldi, io potevo star fresco. Insomma lei è rimasta un po’ interdetta, perché ci si gioca la vita sposandosi, non è uno scherzo. Allora mi ha risposto: “Guarda che io non sono sola al mondo, ho un papà e una mamma, dovrò pure consultarmi con loro, non ti pare?” Io ho trovato che era giusto e ho detto: “Verrò a farmi vedere dai tuoi”. Difatti sono andato a casa sua e mi sono fermato una giornata intera. Sono andato ancora altre volte finché lei non ha detto al suo papà: “Che te ne pare?” E il suo papà ha risposto, molto semplicemente: “Io capisco che tu sia innamorata di lui, perché è un ragazzo simpatico; però non è il partito migliore fra tutti quelli che ti sono capitati finora!” Lei si è sentita cadere le braccia, però il suo papà, da uomo intelligente, le ha anche detto: “È la tua vita, te la devi vivere tu; io non ti obbligherò mai a sposare un uomo che non ti piace”. E questa era una cosa ben detta. Lei ci ha pensato su e poi mi ha sposato.
Quando vi siete sposati?
Ci siamo sposati il 16 di gennaio del 1928 a Ivrea, perché era la sua città. La mattina del matrimonio, il suo papà è voluto andare fino in fondo nel suo compito, perciò l’ha chiamata in disparte e le ha detto: “Sei ancora in tempo, pensaci: puoi rifiutarti di sposarlo, nessuno si offenderà, perché in fondo ti giochi la vita. Pensaci ancora un po'”. E l’ha chiusa a chiave nel suo studio, l’ha lasciata lì un paio d’ore, poi è tornato indietro e le ha domandato: “Che cosa hai deciso?” “Che lo sposo” lei gli ha risposto. E così è stato.

Vuol parlare dei suoi suoceri?
Il papà di mia moglie insegnava fisica nei licei, ed era di famiglia molto buona. Mia suocera invece era figlia di una contessa Bonacossa, che possedeva molte terre, quasi tutte risaie: le ha poi ereditate quasi tutte il figlio maschio, mentre le quattro femmine, fra cui mia suocera, non hanno avuto niente. Una dote, sì, ce l’aveva, ma nient’altro. Insomma i miei suoceri vivevano bene, ma praticamente del solo stipendio da professore guadagnato dal capofamiglia. Hanno avuto tre figlie, le hanno allevate ed educate bene. Mia moglie, l’avevano fatta laureare in matematica. Il suo papà, quando le hanno dato la laurea, le ha detto: “Nella tua vita, se avrai bisogno, l’adopererai”, e difatti l’ha adoperata. Mia moglie ha insegnato per tanti anni. Ha dovuto interrompere durante il periodo in cui siamo stati in Argentina, come Le racconterò, ma ha poi ripreso al nostro ritorno in Italia e ha insegnato per altri quindici anni al liceo classico e all’istituto magistrale di Como, sempre matematica: sotto di lei sono passate diverse generazioni di alunni che ora sono medici, avvocati, ingegneri, architetti comaschi che ancor oggi la ricordano perché era un’insegnante dal polso fermo e dal carattere molto cordiale, e quando la incontrano le fanno festa. Lei ha dovuto lasciare l’insegnamento quando è nata la nostra secondogenita, Maria Barbara, in piena guerra, nel ’43. Questa bambina si rifiutava di mangiare, e per poterla curare meglio mia moglie ha dovuto dedicarsi a lei ventiquattr’ore su ventiquattro.

Mentre la primogenita.
La primogenita, Francesca, era nata a Zarate nel ’29, in Argentina, a cento chilometri da Buenos Aires. Ha compiuto un anno in piroscafo, mentre tornavamo in Italia. È arrivata qui, non parlava ancora, diceva solo qualche parola. “Come ti chiami?” le domandavano. E lei: “Nena”, che in spagnolo vuoi dire “Bambina”. E così le è rimasto il nome Nena. Ci sono quasi quindici anni di differenza fra le due figlie. Dopo la nascita della figlia Maria Barbara, mia moglie è dunque rimasta a casa, e ha lavorato dando lezioni private. Io davo lezioni private di disegno e di pittura, lei di matematica: ci siamo dati da fare in questo modo.
E subito dopo sposati dove siete andati ad abitare?
A Bergamo.
A Bergamo? Come mai?
Avevo progettato una piccola fabbrica di carta speciale, e per i capitali mi hanno aiutato parenti e amici. A Bergamo avevo trovato un posto adatto ai margini di una importante roggia di acqua pulita e la forza idraulica sufficiente per muovere gran parte del piccolo stabilimento. La fabbrica ha funzionato perfettamente per quattro mesi. Poi ho deciso di chiudere – come del resto era previsto – perché il consorzio italiano che produceva quel tipo di carta era pronto a trattare per comperare la mia cartiera.
Di che carta si trattava?
Era la carta che si usava allora per incartare il burro. Veniva impermeabilizzata in un bagno di acido solforico. Così impermeabilizzata, si chiamava pergamena vegetale. Adesso si usano altri sistemi, ma il risultato è lo stesso. Dunque ho accettato la proposta del consorzio e ho chiuso il mio stabilimento. Mentre mi trovavo a dover decidere che cosa fare per potermi dedicare unicamente alla pittura, mi è arrivata un’offerta di lavoro da parte della più grande cartiera del Sud-America: volevano impiantare anche lì una fabbrica di pergamena vegetale. Si trattava della Papelera Argentina. Allora l’Argentina esportava una quantità notevole di burro in tutto il mondo. Il burro argentino era uno dei migliori, perché era quello che aveva più percentuale di grasso in rapporto al peso. Prima compravano la carta da burro dall’Inghilterra o dall’Italia; a un certo punto hanno deciso di fabbricarsela da se, la pergamena vegetale. La cartiera sorgeva a Zarate: possedeva due enormi fabbriche, ognuna con mille, mille cinquecento operai.
E Lei ha accettato di recarsi in Argentina.
Ho chiesto una certa cifra, hanno accettato quello che ho chiesto, e così mi sono preparato a partire insieme con mia moglie, naturalmente.

Mario Radice a Zàrate (Argentina) nell’agosto del 1929.
In Argentina come ve la passavate?
Benissimo. Ci siamo fermati quasi venti mesi in tutto. Io ho fatto quello che dovevo fare, ho anche apportato delle piccole modifiche nel processo di fabbricazione della carta pergamena; modifiche che consentivano una riduzione delle spese di produzione. Lavorando ho guadagnato un bel mucchio di quattrini.
Al ritorno in Italia ha perciò potuto dedicarsi interamente alla tanto amata pittura.
In parte sì e in parte no. Le dico il perché. Io ero stato pagato in dollari; ma proprio quell’anno, nel ’29, c’è stato il crollo della Borsa di New York, e come Lei sa il dollaro è colato a picco. Insomma ho perso i due terzi di quanto avevo guadagnato. Coi pochi denari rimasti ho potuto comprare una casa in via Milano, qui a Como, che ho rivenduto alcuni anni fa. Quindi ho detto: “Adesso dipingo e basta!” Ho fatto circolare la voce fra gli amici, ho trovato uno studio in città in via Cinque Giornate, e mi sono dedicato esclusivamente alla pittura. Un paio di volte alla settimana, in ogni modo, come Le ho detto già, mia moglie ed io davamo delle lezioni private. Insomma, si vivacchiava.
E avete abitato sempre qui, nella casa paterna?
No. Dapprima abbiamo affittato un appartamento in via Giovio, e ci siamo stati per circa un anno; poi ci siamo trasferiti qui, dove siamo ancora adesso, col permesso di mio padre.
Tutto questo è successo negli anni in cui Lei era sulla trentina.
Fra i ventotto e i trentacinque anni.
Quindi un’età decisiva, fondamentale per il resto della sua vita.
Ho cercato di poter vivere senza pensare ad altro che alla pittura. A partire da allora ho avuto solo la pittura, non avevo più superiori a cui sottostare, tranne il Padre Eterno.

E lo studio lo ha sempre avuto qui, a Como?
No, anche a Milano. Nel ’35 mi sono trasferito, per circa tre anni, in una casa di via G. Pepe. Questa casa era stata progettata da Terragni e Lingeri, che avevano previsto un seminterrato adibito a studi per artisti. Gli studi erano molto luminosi e furono occupati uno da Lucio Fontana, uno da Aligi Sassu e uno da me.
Avevate dei buoni rapporti?
Avevo più amicizia con Fontana. Sassu, non lo vedevo spesso; lo vedevo, poniamo, una volta al mese perché ci si incontrava per le scale. I locali, come ho detto, erano al seminterrato: invece di andare in sù, andavamo in giù, dal piano terreno si scendeva una decina di gradini.
Quindi non avete avuto modo di scambiare qualche idea sull’arte, lei e Sassu
No. Quando ci incontravamo, ci salutavamo educatamente. Eravamo giovani, e ognuno pensava principalmente a lavorare. Io, in ogni modo, avevo e ho una grande stima di Sassu.
Dopo questo periodo, ha di nuovo avuto lo studio a Como?
Sì, in via Rovelli, al n. 3, dove ho lavorato per circa dieci anni. Infine, ho preferito adibire a studio un locale del mio appartamento per non perdere troppo tempo in andirivieni. D’altra parte, ormai le figlie vivevano altrove, sposate, e in casa c’era più spazio.
Vorrei approfondire il discorso dei suoi rapporti con le figlie, chiedendo di coinvolgere magari anche sua moglie, Rosetta.
Mia moglie ha fatto tutto quello che ha potuto per le figlie, intanto per dare il buon esempio e poi per ottenere da loro tutto quello che poteva. Non ci hanno mai dato dei grandi dispiaceri, quindi a qualche cosa la buona educazione è servita. Certo si vorrebbe sempre ottenere di più. Ancora adesso, però, bisogna dire che, qualsiasi cosa vogliano fare, vengono a consigliarsi con noi, come noi facciamo con loro d’altronde.
C’è un bel dialogo?
Sì, questo si. Siamo stati sempre molto uniti. Abbiamo tenuto sempre molto a questa unione. Difatti figlie, generi e nipoti, ma anche pronipoti adesso, continuano a venire da noi quasi tutte le domeniche e le altre feste, per trascorrere insieme la giornata. Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto due figlie sane; non ci è mai venuto in mente che potessero non esserlo. Tra di loro vanno d’accordo, e anche questa è una bella cosa; e noi cerchiamo di dirglielo il più possibile, di rimanere così unite anche quando noi non ci saremo più, perché nella vita si può aver bisogno di tutti ma in particolare di una persona che ti vuole bene. Io non ho mai voluto insegnare niente a loro, perché è solo l’esempio che conta.
Quando è nata la maggiore delle figlie, la Nena, lei che cosa ha provato, nel suo nuovo stato di padre?
Ho avuto una gran paura perché mia moglie ed io eravamo soli, in Argentina, lontanissimi dall’Italia. Ci trovavamo a Zàrate, una cittadina che oggi avrà quaranta, cinquantamila abitanti e che è a nord di Buenos Aires, sul Paranà de Las Palmas, un fiume che è largo come il lago di Como, anzi di più, ed è lungo migliaia di chilometri. In questa zona, in mezzo alla prateria argentina che è grande quattordici volte l’Italia, c’è una piccola collina, con sù una città, Mendoza, dove allora – non so più oggi – si faceva il vino Barbera, il Bardolino, tutti vini piemontesi, ma non buoni come i nostri perché troppo forti, troppo alcolici e senza il profumo del vero Barbera, del vero Bardolino, del vero Barbaresco, del vero Barolo. A Mendoza sono quasi tutti piemontesi e parlano in dialetto piemontese. È una collina alta centocinquanta o duecento metri sul livello del mare, come il monte che c’è a Montevideo e dà il nome a quella città: più che un monte, una collinetta. Il resto è piatto, uniforme e piatto come un mare.
La famosa pampa argentina.
Precisamente; ed è un serbatoio di ricchezza naturale incalcolabile.
Ci sono grandi allevamenti di bestiame.
Non ci sono allevamenti. Gli argentini non allevano niente. I bovini vivono allo stato brado. Fra un terreno e l’altro il confine viene delimitato da pali di legno come quelli della corrente elettrica piantati a terra all’altezza di un metro, un metro e venti: le bestie non li attraversano mai perché dovrebbero far fatica, tanto c’è l’erba anche là dove non occorre scavalcare nessun ostacolo. Si vede sempre l’orizzonte come in mezzo al mare, in mezzo all’oceano. Il cielo si confonde con la terra.
Com’era l’Argentina allora?
Aveva una popolazione di dieci o dodici milioni di abitanti. Lì nessuno conta gli abitanti; adesso dicono che sono ventiquattro, venticinque milioni, ma non è vero perché non si possono fare censimenti: non tutti rispondono al censimento, pochi hanno fiducia nello Stato, solo la metà della popolazione.
Parlavamo della nascita della sua primogenita.
La Nena è nata alla mattina presto, in casa nostra. Io ero li in piedi e avevo messo una rivoltella sul mio letto, a portata di mano. La levatrice mi domandava spesso: “A cosa serve questa rivoltella?” Io, a buon conto, l’avevo messa li per impaurire proprio lei, la levatrice, perché degli amici mi avevano avvertito: “Guarda che quella li finge delle complicazioni per guadagnare di più!” Era bravissima come ostetrica, ma avida: lei aveva capito subito che cosa voleva dire quella rivoltella sul letto.
Ma una rivoltella messa li sul letto del parto mi pare una cosa eccessiva!
No, non era sul letto del parto; era sull’altro letto. Avevamo due letti perchè noi non abbiamo mai dormito in un letto matrimoniale, mai; ognuno ha il suo letto. Mia moglie ha sempre caldo e io sempre freddo, e quindi uno dei due non dorme stando insieme nello stesso letto. Per la verità abbiamo dormito insieme nello stesso letto solo una volta, precisamente quando siamo arrivati a Buenos Aires. Quella volta lì, stanchi come eravamo, sono venuti a prenderci al piroscafo. Era notte, erano le 11 o giù di li, e il presidente della società dove dovevo lavorare è venuto a prenderci e ci ha accompagnato in un bell’albergo di Buenos Aires, dove ci hanno dato naturalmente una camera matrimoniale con un letto alla francese, per di più, di quelli piccoli che sono di una piazza e mezzo. Insomma abbiamo passato la notte lei a scoprirsi e io a coprirmi. Alla mattina, mia moglie, furibonda, è andata giù al bureau dell’albergo e ha detto: “Per amor del Cielo, dateci piuttosto due camere, se non avete una camera con due letti!” “Ma non siete marito e moglie?” “Sì, ma questo che vuol dire? Una può anche desiderare di dormire: non di dormire da sola, ma di dormire e basta!” È stata quella l’unica volta che abbiamo dormito in un letto matrimoniale.
Quindi è una notte storica!
Storica anche perchè eravamo così stanchi, dopo venti o venticinque giorni di navigazione, quanti erano, che arrivati lì ci pareva ancora di sentire il pavimento che rullava.
Non avevate fatto un buon viaggio?
Per il viaggio avevamo scelto, per consiglio di amici pratici di crociere, un bastimento che faceva un maggior numero di fermate, così abbiamo potuto vedere dieci città, quasi una ogni due giorni. La sola traversata dell’Atlantico è durata cinque o sei giorni. Siamo passati da quella famosa terra di deportazione francese, La Cayenne, perché è sulla traiettoria della nave. Si va da Dakar a Rio, e si passa da La Cayenne. Poi siamo arrivati a Rio e dopo Rio abbiamo visitato San Paolo e Santos. Dopo ci siamo fermati a Buenos Aires. “È andato tutto regolare, tutto liscio” ho detto.
Dicevamo della nascita della Nena e delle sue emozioni di padre.
Ricordo tutto come un’esperienza molto buona, positiva, perché con la nascita è una vita nuova che si presenta alla faccia del mondo, e poi questa novità riguarda non solo la popolazione della Terra, ma tutto il resto dell’Universo, dell’Universo infinito.

E quando è nata la secondogenita, Maria Barbara, invece eravate già qui a Como?
È nata, sì, qui a Como, alla Villa Aurora, vicino a Monte Olimpino, sulla via Bellinzona. Ma io non ho assistito al parto, questa volta. Però ho provato le medesime emozioni della prima volta. È sempre come fosse la prima volta.
Nei rapporti con le figlie è stato sempre buono? O brusco, severo?
L’unica cosa che conta è il buon esempio, il resto sono tutte storie inutili.
Ma quando queste figlie erano piccole, Lei aiutava la madre a curarle, le cullava, ci giocava? Insomma dedicava qualcosa del suo tempo alle sue figliole?
Mia moglie dice sovente che se io ero di buon umore, lasciavo correre qualunque cosa; se ero di cattivo umore non andava bene niente.
Le impedivano di lavorare? Come conciliava la sua paternità con l’attività artistica?
Avevo lo studio fuori casa, lavoravo li.
Ricorda qualche particolare difficoltà che ha dovuto affrontare nella vita con le figlie?
Durante la guerra, la bambina più piccola ci ha fatto diventare matti per allevarla perché non voleva mangiare niente, a nessun costo. È stato necessario allevarla artificialmente. Ma il latte non si trovava facilmente, allora facevo il giro dei farmacisti di Como per avere il latte in polvere adatto alla bambina, e loro me lo davano. Spesso dovevo comperarlo alla borsa nera.
Le figlie, da parte loro, come vi hanno mutuato, per quel che Le risulta?
Siccome sono molto distanti l’una dall’altra per età, è come se avessimo avuto due figlie uniche: non potevano fare comunella tra loro come fanno i ragazzi coetanei. Sono state insieme in casa solo sei anni, poi la maggiore si è sposata e praticamente è stato come averne di nuovo una sola, finché anche la minore si è sposata ed è andata via. Ci hanno sempre rispettato, ci hanno sempre voluto bene.
E nei confronti del papà artista, che atteggiamento avevano?
Hanno sempre rispettato anche il mio lavoro. Però mi giudicano e mi dicono sempre quello che pensano. Con molta chiarezza. Evidentemente hanno l’abitudine a vedere i miei lavori. Sono cresciute in mezzo a queste cose.
Lei non si rimprovera niente nei confronti delle figlie?
No, no, non posso dir niente. Ognuno è pieno di difetti, non esiste la persona perfetta.
Ora vi vedete con le figlie nei giorni di festa. C’è qualche particolare ricorrenza che festeggiate con maggior solennità?
Le feste del compleanno e dell’onomastico, e poi Pasqua, Natale e i Re Magi. Soprattutto Natale. Pasqua è più importante di Natale; ma non so per quanti secoli si è ritenuta più importante l’Epifania, più dello stesso Natale: ed è giusto che sia così perché “epifania” vuoi dire “manifestazione”, vuoi dire che Gesù si manifesta ai Re Magi. I miei genitori festeggiavano l’Epifania in questo modo: i Re Magi portavano il regalo con una letterina, quando eravamo bambini naturalmente. Questa consuetudine non era un’invenzione dei miei genitori: tutta Como faceva così, si usava così qui a Como allora. Si festeggiavano i Re Magi quasi come il Natale. A quei tempi i bambini ricevevano regali, giocattoli, dolci, caramelle, eccetera, per questa festa, e quindi aspettavano i Re Magi con molta attenzione. E c’era la lettera dei Re Magi che li richiamava a ubbidire ai genitori, che li richiamava a studiare.
E Lei ha continuato questa tradizione con le sue figlie?
Sì, da quando hanno imparato a leggere io ho scritto loro queste lettere, ogni anno diverse.
Ancora adesso che sono fuori di casa?
Certamente.
E che cosa scrive ogni volta?
Sono una ventina di righe di carattere religioso.
Ne ha qualcuna conservata, qualcuna da leggere?
Ho la copia di quella che ho scritto per ultima. Adesso gliela faccio vedere. Ma non è niente di speciale.
Magari ci dà l’opportunità di lumeggiare ancor più la sua personalità.
Se ci tiene. Comunque, eccola. Gliela leggo io: “Carissima (qui segue il nome della figlia, perché le due lettere sono uguali sia per l’una che per l’altra). Gli usignoli, forse da che mondo è mondo, cantano meravigliosamente e i ‘motivi’ musicali del loro canto stupendo sono sempre i medesimi, circa quaranta o quarantacinque. I motivi musicali dell’uomo sono incalcolabili, oppure lo sono con il vocabolo ‘infiniti’. Siamo certi che un ‘primate’, ben educato e istruito e cresciuto in una famiglia civile, possa imparare a guidare bene un’automobile. Siamo altrettanto certi che un primate non potrà mai giocare a scacchi e, tanto meno, credere nella ‘vita eterna’ e credere in Dio. I pigmei dell’Africa centromeridionale, che vivono vestiti unicamente con una cintura di corteccia, sono in grado di imparare a giocare a scacchi e credere in Dio. Crediamo pure che possano imparare ciò che occorre sapere per vincere onestamente un concorso di insegnante universitario. In altre parole la distanza fra il primate e il pigmeo è ‘infinita’. La distanza fra l’uomo e Dio non è più infinita: dal giorno in cui Dio si è fatto uomo: millenovecentoottantacinque anni fa. Amen. Jesus ha detto di amare il prossimo come se stessi e di amare Lui più dei genitori, dei figli, dei fratelli e delle sorelle. Jesus è vero uomo e vero Dio: non può essere altro. Abbiamo trascritto soltanto alcune parole che si devono segnalare unicamente a persone preparate a riceverle: perché quelle parole travolgono le dighe del tempo. Amen. Dio ti protegga, ti proteggerà. Anche noi ti benediciamo. I RE MAGI Gaspare Melchiorre Baldassarre Epifania 1985 A.D.”
Torniamo al suo iter artistico. Lei, pur avendo preso in gioventù regolari lezioni anche dallo scultore Clerici, non ha coltivato la scultura quanto la pittura, la quale invece è stata preponderante.
In tutta la mia vita ho fatto poche sculture. La pittura, è vero, è stata preponderante. Ma per fare scultura ci vogliono molti mezzi, e non sempre si hanno a disposizione. Due delle sculture che ho fatto erano i bassorilievi – uno lungo sette metri e alto tre e mezzo, l’altro tre e mezzo per tre e mezzo – collocati all’interno della Casa del Fascio – oggi Palazzo Terragni – a Como, e sono andati interamente distrutti. Le altre sculture sono rimaste tutte, e fanno parte di collezioni private (Lorenzelli di Bergamo, per esempio, o l’architetto Silvio Longhi di Como). Alcuni bassorilievi, li ho eseguiti in legno. Non ricordo il numero preciso di tutte le sculture che ho fatto.

Vorrei rammentarle anche il progetto per la costruzione della Fontana di Camerlata, firmato da Lei e da Cesare Cattaneo.
La Fontana di Camerlata è una grande scultura astratta. Fin dall’inizio doveva sorgere al centro della grande piazza che c’è a Camerlata. L’opera, però, dapprima è stata costruita al centro del Parco Sempione di Milano, in occasione della VI Triennale di architettura e arti decorative.
Nel 1936.
E vi è rimasta fino all’ultimo anno della seconda guerra mondiale, quando venne distrutta da un bombardamento aereo. Chissà cosa pensarono che fosse, probabilmente una postazione antiaerea. Nel 1960 il progetto venne ripreso, a Como, su proposta del papà di Cesare Cattaneo, e la Fontana è stata nuovamente realizzata nel piazzale per il quale era stata originariamente ideata.
 Come vi eravate divisi il lavoro di progettazione, Lei e Cattaneo?
Come vi eravate divisi il lavoro di progettazione, Lei e Cattaneo?
Non ce lo siamo diviso affatto. Eravamo giovani, lui aveva quattordici anni meno di me, ma era molto maturo; si disegnava e si lavorava spesso insieme. Lui discuteva i miei quadri, io discutevo i suoi progetti di case. È stato Cattaneo a propormi di progettare insieme la fontana. Per me era una cosa naturalissima collaborare con gli altri amici. Contemporaneamente, per esempio, lavoravo con Luigi Zuccoli alla progettazione di alcune tombe monumentali e di alcuni negozi, oppure davo una mano a Giuseppe Terragni quando lui doveva presentare il progetto di qualche edificio per qualche concorso, e i tempi erano stretti. Terragni poi magari all’ultimo momento cambiava qualche particolare e bisognava rifare tutti i disegni. Quando il podestà di Como – l’ingegner Attilio Terragni, che era il fratello di Giuseppe – commissionò a Cattaneo questa fontana per Camerlata, cominciammo a discuterne insieme. A un certo punto ognuno aveva idee proprie ma non tanto diverse, anzi molto vicine. Potrei farLe vedere centinaia di disegni sia miei che suoi. Cattaneo un giorno dice: “Facciamola insieme, perché vedo che al punto in cui siamo è quasi pronta, ed è di tutt’e due”. “Allora” gli rispondo “devi dirlo al podestà che c’entro anch’io”. Cattaneo è andato dal podestà, che ha accettato subito la proposta.
Con Cattaneo ha progettato qualcosa d’altro?
Delle chiese. Poi ancora delle fontane.
È stato realizzato qualche progetto in particolare?
No, perché Cattaneo è morto. Prima della Fontana di Camerlata abbiamo disegnato i progetti di almeno venti fontane, tre delle quali erano destinate alla Stazione Centrale di Como.
Quindi una fontana a Camerlata e tre a Como S. Giovanni?
Si, quelle della Stazione sarebbero state tre piccole fontane, piccole ma legate fra loro, collocate nel giardinetto che c’è in basso, prima della gradinata d’ingresso.
E non sono state realizzate perché Cattaneo nel frattempo è morto?
Sì. Cattaneo è morto qualche settimana dopo Terragni, pensi un po’ che disastro per me che lavoravo con l’uno e con l’altro. Sono rimasto solo al mondo in un certo senso.
Diceva che poi, nel ’60, la Fontana è stata ricostruita su proposta del padre di Cesare Cattaneo.
Sì, il padre di Cesare era un notaio molto conosciuto a Como. Un giorno l’ho incontrato e ci siamo messi a parlare anche di questa Fontana. “Bisognerebbe farla ricostruire,” ho detto io “bisognerebbe interessare il sindaco di Como. Io non posso farlo perché sono uno dei progettisti; ma Lei, che è il papà di Cesare, potrebbe essere ascoltato”. Fatto sta che dopo qualche tempo lui e il sindaco si sono incontrati, e il sindaco gli dice: “Se Lei partecipa alla spesa, io posso guardare il bilancio comunale”. E così è avvenuto. Il sindaco ha dato in mano una certa cifra al papà dì Cattaneo, che l’ha integrata di suo. Per costruire la Fontana di Camerlata si è rivolto alla stessa ditta che aveva fatto la prima a Milano, cioè la Montandon.
Il sodalizio con Cesare Cattaneo è breve ma intenso. Lei e Cattaneo a un certo punto, all’inizio degli anni Quaranta, avete cominciato a progettare anche delle chiese.
Prima abbiamo progettato una chiesa per cinquecento anime. Poi c’è un progetto rimasto a metà strada per una chiesa più grande, ed un terzo progetto, rimasto anch’esso incompiuto, per una cattedrale.
Avevate ricevuto qualche commissione, dovevate partecipare a qualche concorso?
Dovevamo scrivere un libro sull’arte sacra e allora, parlando continuamente di questo argomento, abbiamo cominciato a buttar giù queste proposte.
Il libro non è mai stato fatto?
No. Cattaneo è morto a trentun anni, improvvisamente: era malato di tubercolosi, che allora non si vinceva. Abbiamo lavorato insieme senza problemi. Il libro è rimasto incompleto e non è mai stato più pubblicato nemmeno in parte. Comunque quando Cattaneo è morto, nel ’43, il libro era già pronto per due terzi. Quando il mio amico è morto, è stato tale il colpo, per me, che non ne ho più voluto sapere. E dire che Cattaneo sembrava guarito completamente. Poi gli è capitato un lavoro importante – una casa da progettare, che poi non è stata costruita, tra l’altro – ma si è subito ammalato di nuovo, ed è morto. Si era strapazzato troppo: cercava un aiutante e non l’aveva trovato, e ha dovuto passare una decina di giorni lavorando a pieno ritmo, senza neppure poter andare a letto, a riposarsi. Andava a dormire alle quattro del mattino e alle nove era di nuovo in piedi. Un malato com’era stato lui.
Eravate molto legati?
Sì, molto. Eravamo giovani, nessuno era sospettoso o geloso dell’altro.
Lavoravate nello studio dell’architetto Terragni?
No, lavoravamo nel mio studio, qualche volta anche nel suo, però quasi sempre da me, qui a Como.
Vuole illustrare, in qualche modo, qualcuno dei progetti per chiese fatti con Cattaneo?
Posso parlare di un progetto completo e ancor oggi realizzabile perché è corredato dei calcoli eseguiti per noi da un famoso calcolista di quell’epoca, il Partenio di Milano. La chiesa è stata progettata completamente prima che Cattaneo morisse. Prima di tutto abbiamo proposto il prete rivolto al pubblico dei fedeli.
Parecchio in anticipo sui tempi. Oggi questa è una disposizione diffusa. Mi pare che l’altare rivolto verso i fedeli abbia subito una generalizzazione a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II.
Sì, è così; ma non è una novità assoluta, e Le dirò perché. Un giorno ci trovavamo, Cattaneo ed io, a Castiglione Olona, nella chiesa in cui ci sono gli affreschi di Masolino da Panicale. E lì abbiamo assistito a una messa detta su un altare rivolto al pubblico. Ci siamo incuriositi e, appena finita la cerimonia, siamo andati in sagrestia a chiederne la ragione al prete. Ci disse che si trattava di un permesso dato direttamente dal papa in chissà quale secolo e che altre chiese in Italia avevano altari egualmente disposti. L’idea ci piacque e anzi la trovammo molto giusta.
Avete pensato ad altre innovazioni?
La cosa più importante non è quella del prete rivolto verso i fedeli. Più importante abbiamo ritenuto l’illuminazione, cioè la presenza di una luce diffusa in modo uguale, con mezzi che già allora era possibile adottare. Già negli anni Trenta era possibile impiantare in un locale grande, adatto, con poca spesa tra l’altro, un sistema di illuminazione che mantenesse la luce sempre omogenea e costante. E allora abbiamo progettato una chiesa con due luci: una per quando non c’era la messa, e un’altra per quando si celebravano particolari riti oltre alla messa. Allora non c’era l’altoparlante così diffuso come oggi, quindi pensavamo che il sacerdote potesse predicare da un pulpito al centro della chiesa stessa, mentre adesso da qualunque punto egli parli, si sente perfettamente con gli altoparlanti. In ogni modo abbiamo pensato agli altoparlanti anche noi, per la migliore diffusione dei suoni. Poi un’altra cosa importantissima: è sbagliato tenere i fedeli lontani dall’altare. Questa scoperta non è merito nostro, è merito di un prete nostro amico – che era il direttore del quotidiano cattolico di Como L’Ordine – oggi scomparso: si chiamava Giuseppe Brusadelli. E questo prete ci diceva: “Quando dico messa chiedo a tutti i fedeli che vengano il più vicino possibile a me, in modo che io non sia obbligato a gridare oppure a parlare con un altoparlante quando posso parlare benissimo a una quarantina di persone senza bisogno di niente, purché stiano vicino all’altare”. E perché le chiese sono state costruite con l’altare lontano dal pubblico? Come mai è nata questa distanza tra i fedeli e il sacerdote? Ecco il punto gravissimo da considerare, perchè questa distanza c’è ancora in
quasi tutte le chiese del mondo. Il motivo più importante è questo: il sacerdote, mettendosi lontano dai fedeli, doveva per forza sprigionare una certa autorità dalla sua persona, capisce? Doveva dimostrare una maggiore autorità anche dal punto di vista spaziale. Ecco perchè abbiamo pensato di mettere in mezzo e il più vicino possibile ai fedeli il sacerdote che dice messa e predica. Per ottenere i migliori effetti sia dal punto di vista dell’illuminazione sia dal punto di vista della disposizione dell’altare e dei fedeli, abbiamo pensato a una pianta simile a un settore di cerchio: per noi era la più funzionale sia per l’udito che per la vista.
L’accenno poc’anzi fatto alla partenza per il servizio militare, mi spinge a chiederLe qualche particolare su quella sua esperienza.
Io ero in ritardo di quasi due anni. Sono stato fatto rivedibile quando sono stati chiamati quelli del ’98; dopo sette mesi sono stati chiamati quelli del ’99; e dopo nove mesi ancora quelli del 1900. Sono andato sotto le armi a Torino nell’ottobre del 1917. Nel ’17 sono stato un mese e mezzo in un reggimento di artiglieria. Eravamo in tempo di guerra e bisognava denunciare i propri titoli di studio, e così diventai ufficiale. Mi hanno mandato all’Accademia di Torino per un corso acceleratissimo: quattro, cinque mesi di disciplina esagerata. Ne ho viste delle belle. Se uno cambiava, per esempio, posizione, o rispondeva senza alzarsi in piedi immediatamente, veniva punito. Io ero quasi sempre consegnato. Arrivavo sempre tra gli ultimi. Ero consegnato in permanenza.
Finito il corso?
Sono diventato sottotenente di artiglieria.
E fu mandato al fronte?
No, quando finì il corso era già finita la guerra. Sono stato mandato prima a Bergamo, il mio reggimento era il 3° artiglieria da montagna, artiglieria alpina. Dopo qualche settimana a Bergamo, mi hanno mandato a Lubiana e poi a Vienna: facevo parte della missione militare italiana a Vienna.

Era una rappresentanza dell’esercito dei paesi vincitori. Noi rappresentavamo l’Italia, naturalmente. Eravamo tutti ufficiali giovani o giovanissimi come me. Io avevo vent’anni. Mangiavamo alla mensa del più importante albergo di Vienna, nello stesso albergo abitavamo una ventina, forse una trentina di persone. Il colonnello era il principe Borghese. La disciplina era ferrea. Si trattava di rappresentare degnamente l’Italia.
Conosceva la lingua tedesca?
Il tedesco lo capivo abbastanza bene e lo parlavo anche discretamente. L’avevo imparato a scuola. Allora le lingue, a scuola, si imparavano. Un po’ l’ho imparato anche per conto mio. Il francese, va bene quello, figurarsi; ma il tedesco è più complesso. Quel mese trascorso a Vienna mi ha rinfrancato molto. Ogni giorno imparavo dieci vocaboli nuovi, li segnavo su un bloc-notes e la sera li ripassavo. Insomma con la lingua mi arrangiavo.
Durante il servizio militare ha mai trascurato il disegno, la pittura?
No, mai. Ho sempre fatto il ritratto dei miei colleghi e dei miei superiori. Facevo posare qualcuno e magari copiavo un braccio, una mano, così, proprio, mi esercitavo. Il mio maestro, Zambelli, mi aveva insegnato che bisogna tenersi in esercizio e fare le cose senza più pensarci.
Ha avuto qualche artista come commilitone?
No, nessuno.
Come trascorrevate le giornate a Vienna?
Non facevamo praticamente niente. Dovevamo andare a tavola a talora, trovarci davanti al colonnello a tal altra, il colonnello faceva di sì con la testa, c’era il nostro comandante che era un maggiore, attenti, riposo, tutte quelle cose lì, diceva due o tre parole, e poi ci comunicava se dovevamo fare rappresentanza in un certo posto, trovatevi tutti lì, eccetera, eccetera.
Vienna era in una situazione sicuramente drammatica.
Hanno sbagliato a rovinare quell’impero lì. La sua distruzione è stata voluta dalla Francia e dall’Inghilterra. Era un grande impero, comprendeva la Bosnia e la Slovacchia, poi c’era a sud l’Ungheria, e andava dal confine turco fino al confine tedesco. Era tutto uno Stato, era l’amministrazione più importante dell’Europa, che tutto il mondo copiava. Noi dobbiamo moltissimo all’amministrazione austriaca del Lombardo-Veneto. E dobbiamo moltissimo in senso inverso all’amministrazione di Roma, in senso esattamente opposto, purtroppo.
A Vienna è rimasto un mese, e poi?
Sono stato mandato a Varsavia, dove mi sono fermato dieci, dodici giorni. Dopo Varsavia, a Potsdam sul confine della Prussia Orientale, e lì sono stato tre o quattro mesi.
Sempre in missione militare? Cosa faceva?
Traducevo in francese o in tedesco, secondo le disposizioni degli ufficiali, le norme per l’uso dei cannoni che in quel tempo abbiamo venduto alla Polonia. Erano cannoni dell’artiglieria di montagna, al cui corpo appartenevo io. Venivano smontati e trasportati in montagna a dorso di mulo. Un’arma da fuoco del genere veniva trasportata da sei o sette muli.
E da Potsdam?
Sono tornato in Italia; ma subito dopo mi hanno fatto partire per l’Albania. In Albania sono rimasto sei mesi. Poi sono ritornato definitivamente in Italia e congedato dal servizio militare.
Di salute è stato sempre bene
Sono sempre stato bene, finchè anch’io mi sono ammalato di spagnola nel ’18. È successo prima di andare al corso per allievi ufficiali. Sono stato a letto dieci giorni in un ospedale di Como, che in realtà era una scuola. Delle brande in una scuola. Io finii nella stanza dei morti!
Come mai?
Perché i malati morivano lì. Erano su una branda, in divisa. Non li spogliavano neanche. Io mi trovavo li perché avevo la febbre al massimo.
La davano per spacciato.
Sì, invece è andata bene. La distanza fra un letto e l’altro era minima, si passava a stento. Di fianco a me, a destra, avevo un morto; a sinistra, c’era uno nelle mie stesse condizioni. Ogni tanto portavano via qualcuno e io non capivo niente, avevo la febbre altissima. Talvolta mi alzavo e andavo a guardare da una balconata che dava nel cortile della scuola, allora venivo preso per le braccia da una suora e portato nel mio posto. Dopo sono guarito. Pensi, il primo giorno ero di fianco a un morto, vedo che lo portano via, era in divisa, poi dopo un po’ ne portano un altro in divisa ma vivo. Il giorno dopo era morto anche lui, ma io non pensavo di dover morire perché, non è che delirassi, ma non ero affatto lucido, non mi rendevo conto della situazione. Però il quarto o quinto giorno che ero lì, passa un medico che per combinazione era amico di mio padre e mi dice: “Ho parlato col tuo papà”. “Ah! Come sta?” “Sta benissimo, lui non ha fatto la Grippe; invece tu stai guarendo.” Quindi dettava, a uno che scriveva, le mie condizioni: bronchi migliorati, febbre diminuita, ecc. Poi mi salutava, passava a un altro, e via. Il mio papà tutti i giorni andava a trovarlo, per chiedergli mie notizie. Allora non avevo la testa di oggi. Oggi mi sarei disperato a vedermi lì in mezzo a un morto e a un moribondo, e poi senza neanche coperte, tutto vestito. Uno stava lì, stava tre ore e si muoveva, e dopo un po’ non si muoveva più, era morto e lo portavano via. I morti li mettevano sui camion di notte, uno sull’altro come fascine di legna, uno strato di morti per così e un altro per così, incrociati e accatastati. Quando erano sei strati di morti, il camion partiva. I morti erano tutti in divisa. Io andavo sul balcone nel cortile a vedere questo bello spettacolo e pensavo a tutto meno che a morire. Ero proprio senza testa.
La morte, l’eternità. In che rapporto metterebbe l’opera d’arte creata da un artista come Lei e la sua durata al di là della durata terrena di chi l’ha fatta?
L’artista fa il suo dovere perché è un uomo come gli altri, e il suo dovere è di fare del bene al prossimo. Questo è il dovere di tutti, di qualunque mestiere o professione. Io credo che l’opera di poesia, di musica, di pittura, scultura, architettura, sia rivolta al bene del prossimo, non al male.
Come un’opera d’arte può fare del bene al prossimo?
Nasce solo per quello, sennò che scopo avrebbe?

Io dico, per esempio: il medico fa del bene al prossimo curandolo; ma l’ artista?
Se vedo un’opera d’arte che mi impressiona positivamente, io mi miglioro; capisco che mi fa del bene, mi consola in quanto mi distrae da tutti i dispiaceri che ho, e poi mi fa sperare in tutte le cose più belle. Un’opera d’arte degna di questo nome mi dà la certezza che tutto quello che è rivolto al bene è vero e non è falso. Se l’arte non è rivolta al bene, non è arte, è anti-arte. Il bene proprio dell’artista è evidente. Se l’artista fa del male è un assassino, un delinquente, è una catastrofe vivente insomma. Se invece, com’è suo dovere, fa del bene, anche se fa un quadro mediocre, questo quadro mediocre, ad esempio, non piacerà a tanti competenti o ai massimi artisti, ai geni, però a un certo strato della popolazione che non capisce i quadri degli artisti celebri o li capisce solo eccezionalmente, potrà piacere. Non si può pretendere che un uomo che ha fatto, ad esempio, solo la quinta elementare, si metta a leggere Dante e lo capisca in tutto. E così gran parte della popolazione di un paese lavora la terra, e cosa ne sa di Petrarca, di Leopardi? Se legge L’infinito di Leopardi, non capisce niente, tanto per dire. Allora Leopardi scrive per chi potrà comprenderlo, scrive per dire qualcosa a qualcuno che potrà capire.
Vuol dire che non c’è arte senza comunicazione?
Se no, a che cosa serve scrivere poesie o fare dei quadri o comporre della musica? L’arte è rivolta al bene del prossimo, anche quando è mediocre. Diversamente non è arte.
Dunque, anche se un artista è mediocre, per Lei va bene? Che differenza ci sarebbe fra un artista degno di questo nome e un dilettante
L’artista mediocre è in ogni modo un artista, mentre il dilettante non lo prendo in considerazione perché non conosce il “mestieraccio” e poi perché di sè lascia quasi niente o niente del tutto. Il dilettante è un falso artista. Bisogna pensare a questo: adesso una persona qualunque guarda un quadro moderno, gli salta in testa di dipingere e fa: “Quel quadro li son capace anch’io di farlo!” E si mette all’opera. Immagini che ne vien fuori! Gli artisti mediocri invece sono importanti. La scoperta forse più importante della mia vita è la seguente. Premetto che le vere o autentiche opere di poesia, pittura, musica, scultura, ecc., insomma tutte le opere d’arte, sono quelle rivolte unicamente al bene del prossimo, alla consolazione del fruitore: non mi stancherò di ripetere questo, che per me è un assioma indiscutibile. Premesso questo, occorre riconoscere che non soltanto le opere d’arte di eccezionale importanza, ossia quelle supreme, trasmettono un bene al prossimo, ma anche quelle meno importanti e perfino quelle che crediamo mediocri. Ciò che veramente importa è sicuramente il bene del prossimo, non altro. Non possiamo pretendere che tre quarti della popolazione capisca, per esempio, le musiche di Bach o di Vivaldi o le pitture di Giotto o di Raffaello.
In che modo o in che senso gli artisti mediocri possono fare del bene al prossimo, come Lei dice?
Anche l’opera di un artista mediocre può essere consolatoria, soprattutto per chi non è in grado di capire le opere supreme. Una canzonetta può dare delle emozioni allo stesso modo di una sinfonia di Beethoven: dipende da chi l’ascolta, dalla sua educazione musicale, dalle sue conoscenze specifiche. L’attuale libertà di stampa cosiddetta democratica è un inganno vergognoso. Non si ride più, e nemmeno si sorride. Si leggono sui giornali unicamente notizie nere, di assassini, di furti, di sciagure. In Italia comandano soltanto uomini o donne che non sanno sorridere, che sono perfino peggio degli stessi fascisti di cinquant’anni fa. È necessario fondare di nuovo non uno ma almeno cinque settimanali umoristici, a Milano e a Torino, a Venezia e a Firenze, infine a Roma, dove dovrebbero rinascere riviste come ce n’erano una volta, tipo Il Travaso delle Idee, Il Guerin Meschino, Il Becco Giallo, ecc. I caricaturisti e gli artisti mediocri ci sono ancora oggi, ed è ora – se io non sono impazzito – che siano utili al pubblico con motivi e disegni umoristici. I disegnatori di vignette umoristiche esistono ancora e sono quasi tutti disoccupati.
Ma disegnatori umoristici in Italia ce ne sono diversi, penso a un Forattini, a un Pericoli, a uno Staino, a un Altan, a un Chiappori, e l’elenco potrebbe continuare a lungo.
Si, ma disegnano solo per dei quotidiani seri, non umoristici, o per delle riviste d’opinione che solo qua e là si lasciano andare a qualche vignetta. Non dubito che vi sia anche qualche rivista completamente umoristica, ma si tratta di casi isolati. Io ritengo che noi oggi in Italia viviamo in un cimitero: un cimitero più nero e triste dello stesso fascismo, il quale permetteva, almeno nei primi otto o dieci anni del triste ventennio, anche i settimanali umoristici antifascisti. Prima della penultima guerra mondiale Il Guerin Meschino, ogni settimana, pubblicava nella prima pagina una “Lettera” del papa, in dialetto veneziano un po’ italianizzato: il papa era Pio X, veneto. Nessuna “Lettera” era offensiva; era benevola e sorridente anche se talvolta disapprovava qualche discorso realmente fatto dal sommo pontefice. I grandi umoristi sono solitamente artisti mediocri, ma sono precisamente gli artisti mediocri che procurano maggior bene al prossimo, perché gli artisti mediocri sono immediatamente capiti dal pubblico, tutti quanti. Voglio insistere: gli artisti non eccelsi, quelli quasi mediocri e gli stessi mediocri sono altrettanto importanti degli artisti supremi. Questi ultimi capitano sulla Terra tre o quattro volte in un secolo: normalmente diventano popolari qualche secolo dopo la loro morte. Gli artisti quasi mediocri, quelli mediocri o di scarso valore sono altrettanto importanti di quelli supremi perché il pubblico medio impara a capire i pittori, i musicisti, gli scultori, i poeti, ecc. non dagli uomini inavvicinabili e rarissimi, ma dagli artisti cosiddetti minori e soprattutto, lo ripeto, dagli artisti mediocri.
Però l’arte, anche per una persona che si diletti di farla senza ambizioni, ne piccole ne grandi, svolgerà pure qualche funzione.
Serve a far passare il tempo, il che è una cosa molto importante.
E magari a elevare il proprio spirito.
Ah, non credo! Solo per ammazzare il tempo. È importante ammazzare il tempo. Aveva ragione Leopardi a dire l’importanza del gioco delle carte: fa passare il tempo senza che si commetta niente di male. Le par poco?
Ma un dilettante da che cosa si ravvisa?
Qualunque opera rivela un mestiere x di grado y. Quindi il livello tecnico, il livello formale, viene a galla. Per esempio, un brano di musica che ripeta dei motivi già sentiti o li ripeta malamente, è opera di un dilettante. Così è pure per la pittura. lo chiamo dilettante il pittore che non sa fare un nudo o un ritratto somigliante al vero. È inutile che egli dica che sa disegnare, che sa fare un paesaggio: non c’entra niente, il paesaggio lo fa anche un bambino, una pianta così, delle righe così. Il vero pittore deve saper fare un ritratto somigliante, e poi decente, presentabile. Il ritratto non lo sa fare? Ecco, tutto lì: non ha studiato, è un dilettante. Per fare un nudo maschile o femminile in grandezza naturale, e farlo decentemente, bisogna imparare il mestiere.
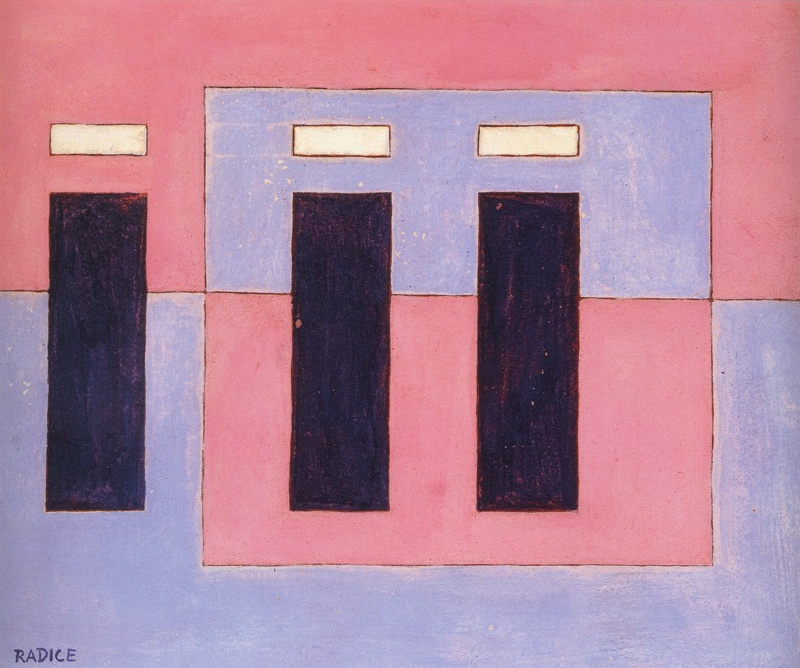
Quindi bisogna pensare che per diventare dei veri pittori, dei bravi artisti è giocoforza passare attraverso il figurativo. Non si può arrivare direttamente all’astratto?
No, non si può per questo motivo semplicissimo: noi chiamiamo armonia una certa cosa che è nella natura, non nella testa degli uomini. Al vertice di tutto ciò che conosciamo c’è il corpo umano: al vertice di qualsiasi altro esempio di armonia. Supponiamo di raccogliere poi tanti fiori e di fare una gerarchia fra trecento fiori diversi l’uno dall’altro; e scopriamo che la rosa di oggi (quella di cento anni fa era tutta diversa, e quella di trecento anni fa era ancora quella selvatica a cinque petali distesi) è stata per così dire fabbricata dall’uomo, perchè è frutto di selezioni e di incroci. Questa rosa che oltretutto ha un profumo meraviglioso, forse insuperabile, insieme a pochi altri fiori, è al vertice della bellezza di tutti i fiori che conosciamo. I fiori del Brasile, per esempio, sono meravigliosi, ma mancano di profumo completamente; sono più vistosi, ma mancano di gentilezza; sono stupefacenti, ma stancano; in un certo senso non sono delicati. Se Lei vede una rosa come si sviluppa, che prima è ancora un germoglio, poi adagio adagio si apre, è una cosa stupenda; è una cosa meravigliosa questa lenta apertura. Adesso, per esempio, mentre siamo in ottobre, io ho delle rose che ancora sbocciano: in due o tre piante ogni tanto nasce una rosa. Mentre in luglio quella stessa rosa nasceva alla mattina, si apriva a mezzogiorno e il giorno dopo era già appassita, perdeva i petali, adesso la stessa pianta fa delle rose altrettanto profumate, ma che durano due giorni perchè la potenza del sole non le distrugge.
Lei ha sempre amato i fiori nella sua vita?
Sempre.
Immagino che abbia amato regalare fiori anche alla sua signora; che cosa le portava? Mazzolini di campo? O fiori comprati, costosi?
No, costosi no perché non potevo, non avevo i quattrini, però le portavo fiori comperati e no, tutto quello che capitava. Poi raccoglievo per lei anche dei quadrifogli, dei portafortuna.
Ma sono così frequenti i quadrifogli
Bisogna saperli cercare.
Vuole insegnarmelo?
Prima di tutto i quadrifogli non ci sono in tutte le stagioni. Trovare un quadrifoglio in autunno è quasi impossibile, c’è qualche caso, ma è rarissimo. Ci sono i campi di trifoglio: nel campo di trifoglio alto quaranta centimetri, molto rigoglioso, ogni due o tre metri quadrati c’è sempre un quadrifoglio, ma c’è specialmente quando il trifoglio ha la massima capacità riproduttiva, cioè a primavera: è allora che lo si vede più facilmente, cioè nel tempo immediatamente precedente la fioritura, se no, non si riesce a vederlo più. E poi di quadrifogli ci sono diversi tipi, a seconda del tipo del trifoglio naturalmente. C’è quello che cresce nella ghiaia, sotto i piedi: questo è quello che dà più quadrifogli.
E perché?
Chi lo sa? Il quadrifoglio è il risultato di una deviazione genetica del trifoglio. Nel mio giardino c’è un gruppo di trifogli che noi calpestiamo senza accorgercene, poi in primavera, nel mese di marzo, andiamo lì e c’è un quadrifoglio, e magari lo trova mia moglie, o mia figlia Nena, che trova tutti i quadrifogli che ci sono in giro. Se una pianta di trifoglio fa dei quadrifogli, li fa sempre; un’altra magari non li fa mai. Insomma anche per andare a quadrifogli bisogna conoscere un po’ il mestiere! Quando nel mio giardino c’è un quadrifoglio, io ne sono felice.
Torniamo al discorso sulla pittura: dicevamo che occorre copiare dal vero la figura umana perché il corpo umano è al vertice dell’armonia che regna nella natura.
Certo, cosa vuoi copiare? Per insegnare alla mano e all’occhio a muoversi e a capire, bisogna copiare qualche cosa, e cosa vuoi copiare? Un albero? Qualunque direzione il pittore gli dia, qualunque ramo dipinga, va sempre bene, più o meno. Ma se fa un ritratto, un decimo di millimetro di errore si vede, perché c’è da confrontare il modello col disegno che si sta facendo magari con un carboncino qualunque: lo sta facendo, e qui è sbagliato, qui sporge troppo, là è.

Mi diceva, prima, che Lei non ha mai smesso di fare il figurativo accanto all’ astratto?
Il figurativo l’ho fatto da sempre e non l’ho mai interrotto del tutto. Fino a due secoli fa, in Europa, l’arte era per il novantanove per cento arte sacra. I pittori cosa dipingevano, gli scultori cosa scolpivano? Pittura sacra e scultura sacra. Solo in minima parte si facevano i ritratti per ricordo del tale o del tal altro. E poi, da che mondo è mondo l’uomo ha disegnato delle figure. L’uomo delle caverne prendeva un sasso appuntito o un tizzone annerito, si metteva a incidere o a disegnare per terra o su una parete, e che cosa faceva? Faceva un animale: un cane, un gatto, un cervo, un bue. Lo faceva male dapprima, ma poi a poco a poco imparava a farlo meglio. Poco dopo ha incominciato a disegnare un figlio, la moglie, un fratello: mai più pensava all’astrattismo e a tutte queste storie.
Lei ritiene sia più importante il suo lavoro astratto o quello figurativo?
Come faccio a rispondere a questa domanda? Non lo so nemmeno io.
Ma rimane ugualmente soddisfatto sia quando ha finito un’opera astratta che quando ha finito un’opera figurativa?
In nessun caso rimango soddisfatto, mai.
Quindi Lei non salverebbe nessun quadro, nessun disegno dei suoi?
No, ma io pressappoco so di essere un pittore di classe media.
Magari gli storici dell’arte ritengono che Lei sia un pittore di prima classe.
Io non lo so, non si può sapere, si potrà sapere fra cento anni a che classe appartengo, adesso non si può; tanto meno posso dirlo io, gli altri neanche, ma io per primo.
Le è sufficiente la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro.
No, mi basta la coscienza di aver fatto il mio dovere, non un buon lavoro; non so se i miei quadri siano molto peggio di quel che penso io, di quel che li giudico io; o se siano molto meglio, non so; non posso dare un giudizio sul mio lavoro, sulle mie opere. Il pittore fa quello che può: supponiamo che, tanto per fare un bel numero, ci siano cinque categorie di osservatori: le prime due categorie ammirano i quadri dei dilettanti, non capiscono nient’altro e disprezzano le opere dei grandi; le altre tre categorie, ognuna con un grado sempre più elevato, apprezzano i quadri dei professionisti, dei pittori veri. Mettiamo al culmine dell’arte contemporanea De Chirico, Picasso, Carrà, Matisse, Braque, Morandi, Sironi o Casorati: chi arriva a capire i quadri metafisici di De Chirico o di Carrà oppure qualche quadro strano di Sironi che riproduce i suburbi di Milano con quegli stabilimenti, con tutto quel disordine? Ecco, quelli lì capiscono Sironi e sono già al vertice. Chi non capisce invece dice: “Ma uno deve fare quelle cose lì, così brutte?” Ma la periferia di Milano è brutta, e quando Sironi faceva quei quadri si attribuiva una grande importanza alla periferia delle città, appunto perché era il luogo dove sorgevano gli opifici, dove si lavorava; la periferia dava appunto l’idea dell’operosità, dell’industriosità. Ma la periferia è triste, nessuno può negarlo. I quadri di Sironi sono quasi tutti tristi; invece i migliori quadri di De Chirico sono misteriosi: quelle piazze d’Italia con quelle ombre strane. E allora bisogna ricordarsi sempre di queste cinque categorie sia di pubblico che di pittori, perché anche i pittori si possono dividere in tante categorie.
Diciamo allora che quando Lei fa un quadro astratto si rivolge alla categoria numero cinque, mentre quando fa un quadro figurativo si rivolge alla categoria, che so, numero quattro?
No, no, non penso di rivolgermi a nessuno quando dipingo; è istintivo per me fare una certa cosa; la faccio e basta.
Lei parte da una scelta personalissima, Le piace fare una certa cosa, la fa e basta?
Ah certo! Questo qui piace magari a un analfabeta e quest’altro invece a uno già pratico.
Quindi non c’è l’esigenza, in Lei, quando fa il figurativo, di rivolgersi a una persona che possa capire meglio?
No, per l’amor di Dio! È il tema che guida l’occhio e la mano dell’artista. Tutto il resto non c’entra. Ogni altra preoccupazione è estranea all’arte. Il pittore fa quello che sente e basta, non si rivolge al tale o al tal altro, a questa o a quella categoria. Adesso parliamo di categorie, ma in fondo quelli che apprezzano l’arte ai sommi vertici sono sempre quattro gatti. È sempre stato così da che mondo è mondo.
Che cosa interviene maggiormente nel gioco dell’arte?
Tre questioni importantissime: la capacità artigianale, la capacità misteriosa dell’arte che non si sa come chiamare e poi la capacità di farsi capire. È per questo che io non so se i quadri astratti abbiano un valore superiore o inferiore a quelli figurativi.
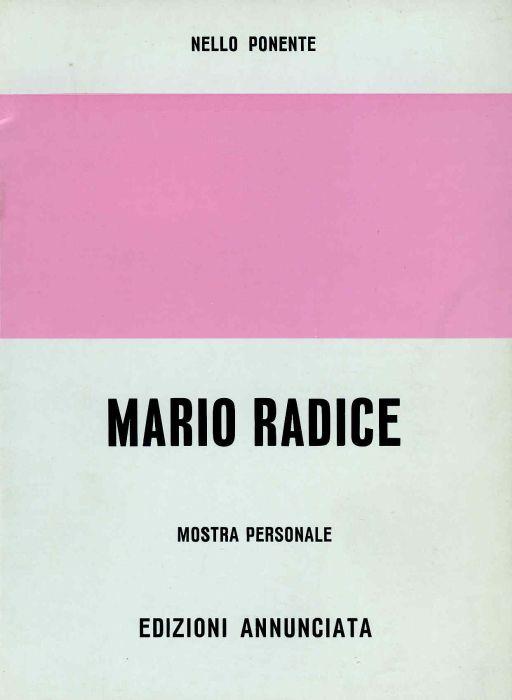
Nelle mostre Lei come si regola, espone astratto e figurativo insieme
Io non ho mai esposto quadri astratti insieme ai figurativi se non due volte: una a Como e l’altra a Lugano, nel 1981 e nel 1982: a Lugano ho esposto due terzi di quadri astratti e un terzo di figurativi. La critica svizzera non ha parlato male dei quadri figurativi, ha parlato bene di tutto: quelli figurativi non li ha nominati in modo specifico, ha parlato delle mie opere in generale come se il figurativo e l’astratto fossero di pari valore. Questo è successo forse anche perché il presentatore della mostra nel catalogo, quando c’è stata l’inaugurazione a Villa Malpensata, durante il discorso ha detto che considerava la pittura figurativa dello stesso valore della pittura astratta. Io ho sempre sostenuto che in pittura il tema ha un’importanza relativa e sostengo ancora che un paesaggio può essere meraviglioso e una Crocifissione tutto il contrario. Quindi il tema non è che determini il valore dell’opera. Il tema invece di essere figurativo può essere astratto. E cosa vuol dire tema astratto? Vuol dire che non ha racconto, non ha descrizione, non ha niente; è solo una musica fatta con le forme e con i colori, prima di tutto con le forme e poi con i colori; se poi il tema è monocromo, lo si fa con le forme sole. Qualche volta il tema è monocromo: quando la composizione si sente che è ben riuscita, io la riduco a un solo colore, affinché la composizione non venga disturbata da un’altra armonia a se stante come quella dei colori. Insomma se Lei vedesse una rosa dai petali rosa e poi ne vede uno solo rosso, si domanda: “Cosa ci fa quel petalo lì, cosa c’entra quello lì?” Stona, non Le pare? Infatti una rosa simile in natura non esiste, io non l’ho mai vista. Così Lei fa un quadro nel quale la composizione sembra mica male, è buona, allora è inutile mettere quei pochi colori che creano un canto al di sopra dell’altro, confondono le idee al prossimo e rovinano tutto. E così qualche volta devo correggere dei quadri e renderli non dico monocromi ma quasi, in modo che i colori non disturbino la composizione e la composizione non disturbi i colori. Se invece mi riesce il colore, la composizione non ha più tanto valore: non possono valere insieme colore e composizione, cioè non possono prevalere tutt’e due.
Una cosa deve cedere il posto all’altra?
Proprio. E così non succede solo nella pittura, succede anche nella musica.
Non esistono quadri in cui composizione e colore siano dello stesso livello
Sì, esistono, ma sono rari, rarissimi: sono rarissimi i quadri in cui ci sia una buona composizione e anche un colore equilibrato. In genere o prevale l’una o prevale l’altro. Qualche volta, sì, si equilibrano, come in genere nei quadri di Raffaello e nei quadri di pochi altri grandissimi pittori. La composizione in Raffaello non è mai complessa, è una composizione ben fatta, fatta con le regole del Quattrocento, cioè secondo le regole della sezione aurea, perché Raffaello conosceva perfettamente la sezione aurea. La composizione di Raffaello è semplice, non ha in se valore di armonia ma di impianto, sul quale spesso prevale il colore. Anche in Raffaello, nei quadri in cui la composizione è più complessa, il colore si sente meno.
L’esempio di Raffaello per Lei è fondamentale.
Ammiro molto Raffaello, ma ammiro molto anche Piero della Francesca, Paolo Uccello, Masaccio, Giotto: bisogna studiarli a fondo, questo è importante.
Lei si ritiene più bravo nella composizione o nel colore?
Ah non lo so. Probabilmente nella composizione: ma come faccio a saperlo?
E quali colori predilige?
Li uso tutti. I colori sono come le note musicali: come si fa a dire preferisco il do al si al la? Ogni nota è necessaria. Quello che mi preme di contestare è la cosiddetta mano, cioè il mettere in vista la propria mano, il che è abbastanza facile. Un mio amico carissimo, che è un disegnatore eccezionale, quando sta tre mesi senza fare disegni o senza fare quadri o sculture, chiama una modella e per un mese la copia col carboncino, ma sempre a grandezza naturale. Tiene la modella quindici, venti giorni, o anche un mese, e non fa altro. Compra cento chili di carta da impacco, poi col carboncino o con la matita copia la modella in tutte le posizioni possibili e immaginabili. Quella sua mano è così esercitata. L’artista è come il nuotatore che, se è privo di allenamento e riprende, deve tornare da capo ad allenarsi, altrimenti non raggiunge più i risultati di prima. È così anche un corridore, un ciclista.
Lei per ora è abbastanza allenato?
Per adesso lo sono poco, ma ricomincio a fare dei ritratti: recentemente ho fatto per diverse volte di seguito una testa, un braccio o l’intera figura umana.
Lei quindi sente il bisogno di esercitare la mano.
Certo, con il ritratto si esercita la mano. Perché sento il bisogno di farlo? Perché da due mesi faccio solo pittura astratta nella quale la mano conta poco.
Come si potrebbe definire questa mano
Ah, non so, si chiama mano e basta.
Forse è lo stile personale?
No. Lo stile comprende la mano ma non si ferma alla mano. Ci sono dei pittori che, quando non sanno far altro, tirano fuori la storia della mano per rendere più interessante il loro lavoro. C’è qualche pittore che ha solo una bella mano, ma per il resto è zero.
Forse è il segno
Sì, possiamo dire che la mano è il segno, e si ha quando il pittore padroneggia bene il segno, magari fa delle cose mediocri ma si vede bene che il segno è bello, ecco che allora piace. Nei grandi pittori il segno è abilmente dissimulato: appare solo nei loro disegni, perché nei disegni è inevitabile che appaia la mano dell’autore.
Anche in Raffaello?
Anche in Raffaello, ma pochissimo perfino nei disegni. Io dico che Raffaello è un fenomeno incomprensibile, perché la sua mano non si vede mai, salvo che in qualche disegno. Per esempio in quel disegno che c’è all’Ambrosiana di Milano, si vede un po’ la mano ma pochissimo, ed è un disegno in bianco e nero, son tre o quattro fogli di carta messi lì vicino, uniti con la colla, tutto lì, perché il disegno è lungo alcuni metri, non so, forse cinque o sei, ed è un disegno stupendo di un affresco fatto a Roma. Un disegno poi finito alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano chissà come.
È il disegno per un affresco fatto dai suoi allievi, che Raffaello poi ha ripreso.
Tutti gli affreschi di Raffaello nel Vaticano sono stati fatti in genere dai suoi allievi. A un certo punto ne aveva trenta. Anche Rubens ha fatto un numero enorme di quadri che non avrebbe potuto fare senza molti allievi. Il pittore faceva il progetto a carbone o a matita, in bianco e nero insomma, e poi gli allievi davano i colori. Un pittore di cui non ricordo il nome diceva ai suoi allievi: “Fate tutto, meno le mani”, e le mani le faceva solo lui; oppure: “Fate tutto, meno le mani e le teste”. Capirà, in un quadro per esempio di tre metri quadrati ci sarebbe voluto un mese di lavoro, invece in quella maniera il maestro faceva qualche mano e qualche testa e il quadro era bell’e finito.
Però si vedeva in tutto il quadro il carattere del maestro.
Certamente, perché il bianco e nero l’aveva fatto lui.
E la durata fisica di un’opera?
Ha un’importanza enorme perché si spera sempre che un’opera, se riuscita, trasmetta qualche cosa. Però è sbagliato sperare, perché durare mille, duemila, diecimila anni, tanto per dire, o solo tre mesi, è lo stesso, perché tre mesi e diecimila anni in confronto all’eternità sono uguali, cioè niente.

Comunque, la durata fisica di un’opera d’arte richiede onestà di esecuzione.
Io ho imparato dal mio maestro Zambelli che mi ripeteva: “Non comprare colori qualunque”. D’altra parte, ho studiato chimica a Milano quando frequentavo la facoltà di veterinaria. Adesso, come tutte le cose che si studiano da giovani, molte nozioni le ho dimenticate, però i fondamenti della chimica non lì ho dimenticati. Ci sono colori che “chimicamente” non vanno d’accordo con altri colori. Nessuno dice queste cose perché a scrivere i libri sono dei pittori che ignorano completamente i principi fondamentali della chimica. E allora è per questo che io mi son messo a scrivere non un libro, per carità, ma un manualetto per gli studiosi di pittura. Io ho fatto le prove per conto mio, cioè tutti i colori che adopero li stendo su una tela e poi metà li lascio fuori al sole per cinque o sei giorni e metà li copro con un cartone nero o con un pezzo di legno. La striscia di colore lì diventa bianca al sole, qui invece resiste perfettamente. Almeno trenta o quaranta colori, quelli che adopero io, sono quelli che resistono. Questo è il mio dovere, perché se vendo un quadro che costa magari mille lire, son mille lire rubate se fra tre anni il colore non c’è più. È evidente, no? Il novanta per cento dei miei colleghi non si occupa di queste cose. Pensi che io ho scritto a due case, una francese e una inglese, perché mi suggerissero i colori che resistono. Mi hanno risposto entrambe. Ebbene, sono gli stessi colori che io già sapevo, non mi hanno detto niente di nuovo.
Può fare qualche esempio?
Per esempio, i sali di cobalto resistono tutti, anche i sali di cadmio resistono, quindi c’è già una gamma importantissima; poi tutti i colori terrosi, che sono sassi polverizzati – le cosiddette “terre” -. Un sasso è rosso, un altro è verde, un altro ancora è giallo. Resistono perché sono stati al sole forse parecchi millenni, non hanno più niente da perdere. Dunque: le terre, i sali di cadmio, i sali di cobalto, ma anche il biossido di titanio che resiste molto bene con tutti i colori e, infine, il nero di vite. In fondo i colori sono pochi, il resto è tutto da eliminare perché non resiste. Il manualetto che sto scrivendo parla di queste cose.
Ha già finito di scriverlo?
No, no. L’ho appena cominciato; se non facessi altro, in un mese sarebbe finito. Non so se farò in tempo, cioè se non morirò prima. È importante per me, perché almeno qualche cosa rimane, e non so ancora nemmeno come intitolarlo. “Manuale.” di che cosa? Di estetica?
Tecnica dei colori, forse.
Si, qualcosa del genere, ma in realtà è un manuale di estetica. Però la parola “estetica” non mi piace, è un po’ troppo importante. Il libro comincia con la definizione della parola “estetica”. Ne ho trovate sette o otto, di definizioni; ognuno ha la sua, tutte diverse l’una dall’altra.
Lei non ha una definizione tutta sua, personale, di estetica?
L’estetica, come tutti sanno, è la scienza che ricerca e studia nelle opere della natura e nelle opere d’arte il bello, è anche l’espressione stessa del bello. Cos’è il bello? Ecco, se io parlo con un critico d’arte e gli domando cos’è il bello, si offende, perché la parola “bello” non esiste per nessun critico d’arte. Se mi porta un critico d’arte che dice: “Quel quadro lì è bello, quella statua lì è bella”, io Le do – anche se non posso darglielo – un miliardo di lire, ma insomma Le do tutto quello che vuole. La parola “bello” è abolita dai critici attuali tanto in Italia che all’estero. È una cosa vergognosa ma è così. Cos’è il bello? È lo splendore del vero. Questa definizione, che tutti conoscono, ha circa duemila e cinquecento anni e mi pare superfluo segnalarne l’autore. Lei lo sa?
È una definizione attribuita a Platone
Per l’appunto. Le tre arti visive – pittura, scultura e architettura – si manifestano nello spazio. Lo spazio, invece, è poco importante per la musica, esattamente come il tempo è poco importante nella pittura, nella scultura e nell’architettura. Il ritmo per il pittore è ciò che pone ordine nella successione delle forme nello spazio deciso dall’autore. Lo spazio che l’autore ha scelto è il punto di partenza dell’opera. L’ordine è armonia di parti diverse. La carta quadrettata non dà l’idea di ordine, ma di uniformità. Cos’è l’armonia? L’armonia è l’accordo fra due o più forme diverse fra loro. L’accordo rimane inspiegabile e quasi misterioso, perché è difficile da capire. Perché è difficile da capire? Perché non nasce dal cervello, bensì dal cuore. L’accordo è estraneo alla logica, alla filosofia e alla matematica; il vocabolo “accordo” deriva dal latino cor, cordis, che vuol dire “cuore”. Ciò che nasce dal cuore non è mai spiegabile, nel senso del cervello, per questo motivo: è impossibile dimostrare matematicamente se un’opera d’arte è ottima, bella, mediocre o pessima. Più è bella un’opera d’arte, più difficile è capirla, oppure occorre più tempo. Questo è ciò che vorrei mettere come prefazione a quel manualetto che Le ho detto.
Visto che siamo nel discorso, per Lei l’opera d’arte che cos’è?
L’opera d’arte per me, quando è arte vera, è l’unica cosa che dà consolazione per parecchie ore, e poi quando ci ripenso, magari dopo un mese, dà consolazione ancora. Voglio dire: nessuno è estraneo a qualsiasi dispiacere; è impossibile eliminare il dolore, il disturbo psichico o anche quello fisico; tutti abbiamo bisogno di consolazione. Ma cosa c’è che dà consolazione? L’arte: la pittura, la musica, la scultura, la poesia. Mancando queste cose che ci resta? Le scienze non consolano affatto, perché è dalla scienza che nascono le armi nucleari. Dalla scienza viene non solo il bene ma anche il male: altrettanto bene e altrettanto male. Dovremmo, quindi, ringraziare la scienza e dire: “Grazie, signora scienza, che hai inventato il modo di distruggere tutti gli uomini della madreterra in cinque minuti”? Io non sono affatto esaltato nei riguardi della scienza, niente affatto.

Lei, accanto al lavoro artistico, ha anche fatto delle riflessioni sull’arte; queste riflessioni, questi pensieri, quando ha cominciato a farli in maniera matura?
Direi che ho cominciato a trent’anni a capire che cos’è l’arte, anzi la “poesia” , perché tutta l’arte è poesia, è “canto”. Io quando sono giù di morale, leggo una poesia che mi piace, oppure me la ridico a memoria, magari una poesia di Leopardi, che sembra deprimente; invece Leopardi non mi deprime affatto; anche il canto che sembra più pessimistico per me è una consolazione, perché vedo un uomo che riesce a combinare delle cose così perfette dal punto di vista poetico. Si resta colpiti, si respira a pieni polmoni anche se Leopardi dice che la vita è un male, benché non lo dica sovente. Leggo anche Dante, Petrarca. Sono i soliti brani che ho studiato a scuola e che mi ricordo meglio. È sempre una gran consolazione ripassarli. Se non leggo poesia, canto mentalmente un pezzo di musica. È utilissimo imparare a cantare mentalmente.
Lei sa cantare
No, solo mentalmente.
Cioè
Bisogna imparare. È un esercizio utilissimo che nessuno mi ha insegnato. Siccome ho studiato anche un po’ di pianoforte, ho appreso i principi della musica. Adesso non saprei più suonare il piano, intendiamoci, sono anni che ho smesso di esercitarmi. Tuttavia i principi della musica li conosco come quelli della pittura, le due arti si rassomigliano. Difatti musicisti e pittori ci rubiamo le stesse parole: il tono, per esempio, c’è in pittura e c’è in musica, il colore della pittura è la nota della musica, solo che una si manifesta nel tempo e l’altra nello spazio, ma per tutto il resto sono equivalenti.
Anche il ritmo.
Sì, giustissimo, perché senza ordine non c’è mai ritmo; se c’è disordine manca il ritmo, completamente.
Il ritmo, in pittura, dove si manifesta? Nel tempo di esecuzione o nello spazio della tela?
Nello spazio.
Quindi in musica il ritmo si manifesta tutto nel tempo, mentre in pittura nello spazio?
Anche in musica importa lo spazio, ma solo durante l’ascolto di una grande orchestra: il miglior posto è al centro. Naturalmente questo è un fatto secondario. In pittura potremmo dire qualcosa di equivalente. Se la pittura non è illuminata bene, anzi nel modo migliore, il risultato è negativo.
La luce influisce anche durante l’esecuzione di un’opera di pittura
Certamente. Nel mio studio ho messo in opera un tipo d’illuminazione che ricrea notte e giorno la luce solare. Senza luce si è ciechi.
In ordine ai pensieri sull’arte che Lei ha cominciato a elaborare a partire dai trenta anni, ricorda qualche incontro con opere di autori che l’hanno particolarmente colpito?
Autori antichi o moderni?
Di qualsiasi epoca. Cioè: quegli autori che L’hanno guidato verso una certa scelta pittorica anzi che verso un’altra.
Gli incontri importanti sono stati Duccio e Giotto, e poi Masaccio, Raffaello, Michelangelo e Leonardo. Ma prima di Raffaello, Piero della Francesca. Le dirò, Michelangelo impressiona, invece Raffaello è quasi, come dire?, quasi incomprensibile, cioè non si riesce a capire bene come mai abbia potuto raggiungere una perfezione quasi assoluta in tutte le opere, mentre in Michelangelo c’è sempre qualcosa di meno stupefacente. Oltretutto, posso dire questo perché, nell’aprile del 1984, sono andato a vedere la mostra di Raffaello organizzata a Firenze a Palazzo Pitti. È stata un’esperienza unica vedere quasi tutto Raffaello raccolto lì contemporaneamente. Insomma ho riguardato i suoi quadri cento volte, tutti quanti: li conoscevo, meno uno che non avevo mai visto, una Madonna senza il Bambino, non ricordo più da dove venisse.
Vedere le opere dal vivo è sempre un’emozione.
Le riproduzioni non servono a niente. Questo bisogna dirlo a proposito dello studio della storia dell’arte. Non serve a niente studiare la storia dell’arte sui libri, con una serie di date, di autori e di opere. È tempo perso. In genere le riproduzioni sono in bianco e nero, e tutte piccole così. Cosa vedono i ragazzi? Che idea si possono fare? I libri di testo non servono proprio. Io sono andato a visitare tanti musei d’Europa, in Francia, in Inghilterra, in Germania. C’è il professore che arriva nella tale sala con gli studenti, davanti a un certo quadro, ed ecco comincia a spiegare perché è bello o perché è brutto; i ragazzi, ognuno sul suo sedile pieghevole, scrivono attentissimi. Così bisogna studiare la storia dell’arte. Il testo andrebbe abolito. Bastano dieci pagine come promemoria per le date e per i nomi, nient’altro. La storia dell’arte dovrebbe essere insegnata dagli artisti e non dai laureati in lettere che non si sono presi la briga di visitare ripetutamente i musei, le chiese e le gallerie d’arte.
Ma, forse, una cosa è insegnare la storia dell’arte e un’altra è insegnare l’arte.
È la stessa cosa.
Qui apriamo un discorso controverso: l’insegnabilità dell’arte. Si possono insegnare le tecniche artistiche; ma l’arte, è davvero possibile insegnarla?
Si, tutto si insegna. L’allievo però deve avere un minimo di inclinazione.
Ma come si spiega che, per esempio, centinaia e centinaia di studenti frequentano corsi artistici e poi solo qualcuno…?
Uno su mille!
Appunto, solo qualcuno diventa vero artista, o almeno viene riconosciuto tale?
Intanto, veri insegnanti, oggi, non ce ne sono più. Come prima cosa dovrebbero insegnare l’ordine formale, e invece.
Ecco, Lei, da maestro, che cosa insegnerebbe a un allievo in modo particolare?
La prima cosa da insegnare è l’ordine formale, perché prima dei colori, per esempio in pittura, si studiano le forme. Senza le forme non esistono i colori, allora bisogna parlare delle forme, dire che cosa sono queste forme. Poi che cos’è l’ordine, bisogna definire l’ordine. Poi bisogna definire la parola “armonia”, l’espressione “armonia formale”, dire quando c’è armonia e quando non c’è armonia. Quando non c’è armonia, cosa succede? C’è il disastro, c’è zero! Bisogna capire che c’è un rapporto formale fra elementi della stessa opera, tanto in pittura che in scultura che in architettura. Quindi si può fare un discorso che riguarda solo le forme, poi un altro che riguarda solo i colori. Come Le ho detto, ci sono dei colori che vanno d’accordo fra di loro e altri che non vanno affatto d’accordo. I colori non sono tre, come dicono gli scienziati. Il vero scienziato sa che i colori sono infiniti, perché i colori fondamentali sono sì tre – il rosso, il giallo e l’azzurro -, però il rosso col giallo fa l’arancio, l’azzurro col rosso fa il violetto, vien fuori il verde col giallo e l’azzurro, e siamo già a sei colori, e ognuno dei sei colori va dal chiarissimo allo scurissimo. Il chiarissimo è il bianco e lo scurissimo è il nero; il chiarissimo è la luce e lo scurissimo è il buio assoluto. Quindi i colori sono infiniti, e i toni di colore sono anch’essi infiniti, dal bianco al nero.
A ogni tono corrisponde un colore?
No, ogni colore ha infiniti toni.
Questa teoria dei colori – perché sui colori esistono numerosi studi e opinioni – è un fatto tutto suo, personale?
Non ho un’idea personale sui colori, è un fatto di esperienza. In tutto il mondo, non solo in Italia, gli scienziati vanno per la loro strada e i pittori vanno pure per la loro, e non c’è nessun accordo, c’è solo un incontro casuale, momentaneo. Di professori di fisica che si occupano dei colori, non ne conosco uno che avvicini un pittore, voglio dire non un pittore qualsiasi, ma uno veramente bravo. Per esempio, se un professore di fisica dell’Università di Roma avesse interpellato De Chirico sui colori, avrebbe imparato molto, perché De Chirico ha studiato i colori tutta la vita. Lo stesso vale per Morandi, che è vissuto isolato dal mondo come un eremita. Il risultato è che Morandi vive da solo come un eremita, De Chirico parla solo con se stesso, e c’è questo distacco tra scienza e arte.
Questa separatezza fra scienza e arte, a che cosa si può attribuire
Sono diversi i loro interessi e i loro obiettivi. Non può esserci che incomunicabilità.
Eppure, nella storia, quando fra arte e scienza c’è stato confronto, accordo, interdisciplinarità, i risultati sono stati eccellenti. Penso, per esempio, al Bauhaus, l’istituto d’arte e mestieri fondato da Walter Gropius in seguito alla fusione della Scuola di Arti Applicate e dell’Accademia d’Arte di Weimar, in Germania, nel ’19
Dipende sempre dalla comunanza degli interessi e degli intenti. Anch’io ho lavorato con Giuseppe Terragni e Cesare Cattaneo, prima dei trenta, quarant’anni.
Riprenderemo questo discorso sui suoi rapporti con Terragni e Cattaneo. Intanto parliamo ancora dei colori. Nella musica c’è la scala dal do al si; in pittura c’è qualcosa di analogo con i colori?
No, non c’è una scala, ma la si fa.
Ogni pittore si fa la sua
Ce n’è una che è convenzionale e ognuno la segue.
Dopo le forme e i colori, che cosa insegnerebbe al suo ipotetico allievo?
A copiare dal vero, perché il mondo vegetale, il mondo animale e il mondo dell’uomo, che è al vertice della natura, possiedono delle proporzioni misurabili e chiare. Qualcuno sostiene che queste proporzioni sono superate, come se in musica fossero superati l’armonia o il contrappunto. Adesso la parola “superato” è quella che domina di più, perché c’è questa ubriacatura che riguarda le scienze e le tecniche che derivano dalle scienze. Da un mese all’altro un oggetto viene superato e ne viene fabbricato uno migliore: analogamente si crede sia superato quel quadro o quell’altro. Invece le vere opere d’arte non sono mai superate.
Nell’arte non c’è progresso? Non c’è ricerca?
No, ci sono piccole oscillazioni. Io ho sempre sostenuto, da vent’anni, che non bisogna confondere la scienza con l’arte, e che l’artista non ricerca niente. Il pittore, il musicista, il poeta non cercano niente. Se l’immagina Verdi che fa delle ricerche? Dico Verdi ma potrei dire anche l’ultimo artista che scrive e compone canzonette. Non fanno ricerche gli artisti. Gli artisti semplicemente “cantano”. Quando ancora studiano, allora sì si tratta di una ricerca, perché ognuno impara il proprio mestiere. Quando un artista ha finito di studiare e conosce il mestiere, non cerca più niente, deve solo “cantare” al meglio possibile. Uno scienziato, invece, non può far altro che cercare perché la scienza deve progredire, è condannata a progredire: io l’ho detto e scritto cento volte. Se non progredisce, non è scienza. Mentre il pittore, il musicista, il poeta non pensano a progredire o a regredire, “cantano” e basta. Cercano, semmai, di perfezionare il proprio “canto”; ma questo lo fanno tutti, esclusi i mediocri, che sono il novantotto per cento degli artisti. D’altra parte, tutto questo entusiasmo che c’è nella nostra società per la scienza, questo primato dato alle scienze per me è sbagliato. Il primato deve esser dato alla poesia, alla musica, alla pittura, insomma all’arte.
Torniamo all’ipotesi del suo insegnamento. Lei diceva che avrebbe insegnato a copiare dal vero.
Lei come crede che si insegni a dipingere? Oggi non c’è insegnante che non cominci il suo corso col dire all’allievo: “Fa’ come senti!”, e l’allievo fa degli scarabocchi. E l’arte va a zero.

Quindi, invece di lasciar fare quello che uno sente, un buon maestro cosa dovrebbe insegnare?
In principio fa copiare un cubo di gesso o di legno, tale e quale, con le ombre e le luci, le ombre portate in un certo modo; poi fa copiare una piramide; poi un ornato ad esempio di foglie, in bassorilievo; poi gli fa copiare oggetti, ad esempio un bicchiere, una scodella, una bottiglia, un libro, qualsiasi cosa, tutto quello che si vede. E tutto quello che copia deve farlo non come lo sente, ma come è; altrimenti come fa ad educare la mano e l’occhio? Deve fare la “fotografia” di quello che vede; altrimenti come fa a prendere le misure a mano, a trovare le proporzioni di quello che vuoi disegnare? Dopo un anno o due di questi esercizi, l’allievo può copiare un braccio di gesso o di marmo, poi una gamba, poi un torace, delle maschere come ci sono in tutte le scuole di pittura. Quello che l’allievo vede, deve essere riprodotto tale e quale. “Non vedi questa figura, questa forma? Là è grande il doppio e tu non la fai uguale!” “Ah! ma io la faccio come sento!” S’immagini un po’ quel che ne vien fuori! Quando l’allievo ha imparato a copiare, a fare un ritratto preciso, allora sì che può fare come sente. Prima però deve imparare a fare tale e quale, perché, sennò, come fa a educare e a correggere l’occhio e la mano? Insomma per due anni deve fare esercizi quotidiani di educazione dell’occhio e della mano. Mentre fa il ritratto e copia dal vero, tale e quale, senza che lui lo sappia si verifica un mutamento e a poco a poco nasce il suo vero stile di pittura: ci mette altri due anni di lavoro per nascere veramente. Quando ha imparato perfettamente: “Ora sì che puoi fare quello che vuoi e come lo senti!”.
Ma è davvero possibile copiare tale e quale la realtà, la realtà esterna al soggetto?
Madre natura sembra fondata sul “diverso”. Non sono immaginabili due gocce d’acqua uguali. Lo scienziato che analizzi due gocce d’acqua, due gocce che sembrano uguali, troverà sempre una diversità di peso se la bilancia è sensibile, per esempio, a un miliardesimo di milligrammo. Se lo scienziato farà l’esame chimico cento volte, troverà sempre qualche differenza fra un risultato e un altro qualsiasi. Non sono immaginabili due uomini o due donne perfettamente uguali. Non è immaginabile neppure una sostanza perfettamente pura. Le uguaglianze sono state inventate dai matematici, e infatti esistono solo in matematica. Senza le uguaglianze matematiche non esisterebbe nemmeno il vocabolo “uguale”. Perfino lo specchio non può dare due riflessioni identiche in maniera perfetta. L’uguaglianza è forse una delle più importanti “invenzioni” della scienza matematica. Ecco ora il punto: quando un pittore dipinge un ritratto, la sua opera sarà sempre “diversa” dal vero.
Dicevamo che ci vogliono quattro anni per imparare a copiare dal vero e quindi a dipingere. Quattro anni perché un allievo venga fuori bene.
Almeno quattro anni. E prima deve saper fare anche il nudo, maschile e femminile, da tutte le parti, in scorcio e no. C’è una complessità, una perfezione estrema nel nudo umano che non c’è in nessun vegetale o animale; nessun vegetale o animale è armonioso come il corpo umano.
Neanche il cavallo, che viene ripreso spesso?
Neanche per sogno! È lontano un carro dall’uomo, benché anche il cavallo sia stato creato da Dio con quel tipo di armonia che chiamiamo “sezione aurea”, che è un termine matematico, oppure “divina proporzione”, come l’ha chiamata Piero della Francesca, e poi il suo allievo che ha scritto il libro intitolato De divina proportione, un frate francescano di nome Luca Pacioli. Pensi che l’unico esemplare del libro di Luca Pacioli si trova nel Museo di Vienna, e io l’ho veduto. Ora questo corpo umano era sconosciuto nelle sue proporzioni complesse prima dello splendore della Grecia. Se non ci fosse stata la scultura dell’epoca d’oro ateniese, se non ci fosse stata anche la pittura che però è andata perduta – ma la pittura si conosce un poco da qualche ceramica, da qualche vaso che ci è rimasto -, ebbene, il corpo umano non sarebbe stato mai visto nella sua bellezza e perfezione. Insomma la Grecia “ha fabbricato” il corpo umano così perfetto. Non si è trattato di un autore solo, ma di innumerevoli autori, l’uno migliore dell’altro, in quell’epoca d’oro. Noi conosciamo il nudo perfetto dall’arte greca: prima non c’era. L’arte egiziana è meravigliosa ma non arriva a questa perfezione. Così pure qualunque tipo di arte che io conosca, sia cinese che indiana, e si tratta di due civiltà importanti.
Ma l’arte indiana è ricca di templi pieni di statue e sculture
Però non c’è mai l’espressione della perfezione formale come nell’arte greca.
Si tratta forse più che altro di un’arte didascalico-religiosa.
Talvolta sono sculture stupende, però non mirano mai alla perfezione formale. Invece la Grecia, per un secolo o due, ha mirato alla perfezione formale: perchè i Greci pensavano, senza dirlo, che la perfezione formale fosse il corpo umano. E avevano ragione.
Come si è reso conto di tutto questo
Osservando le statue greche, quelle tre o quattro che ci sono a Londra, quelle due o tre di Parigi. Ce ne sono anche in Italia, naturalmente. Ho girato tutti i musei per vederle. La cosa principale da guardare è come mai siano così perfette.
Come spiegherebbe, in poche parole, la sezione aurea
Prendo una matita e gliela spiego così, alla buona, senza formule matematiche. Ecco, c’è, per esempio, questo segmento, che sto tracciando da qui a qui. Se lo divido in due parti uguali, ho due elementi o, meglio, due dimensioni: l’intero e le altre due parti uguali. Se invece faccio questa suddivisione in questo punto preciso -ecco, stia attento proprio a questo punto-, ho ottenuto che l’intero segmento sta al maggiore degli altri due come il maggiore degli altri due sta al minore. Difatti i matematici definiscono la parte aurea di un segmento quel segmento che è medio proporzionale fra l’intero segmento e la parte rimanente. In questo modo ho ottenuto una proporzione. Mi sono spiegato?
Perfettamente.
È tutta qui la sezione aurea. Un pittore che abbia esperienza riesce a determinare la sezione aurea a occhio, senza bisogno di ricorrere a strumenti o a formule matematiche. Tutto questo è stato scoperto dai Greci o forse, come sostiene qualcuno, dagli Egiziani; ma io credo che gli Egiziani l’avessero capito così, d’istinto, mentre i Greci hanno riflettuto sul fatto che la sezione aurea domina le proporzioni del corpo umano. Il corpo umano è fatto in modo che non lo si possa immaginare al di fuori di questo rapporto, mentre gli animali e i vegetali non è che escano fuori dal rapporto della sezione aurea, solo che si fa più fatica a misurarli in base alla legge di questa proporzionalità. L’uomo, invece, è più graduale, più armonioso, anche se più complesso. Insomma il corpo umano è perfetto, non si riesce a immaginare una forma più perfetta del corpo umano così come è stato scolpito o dipinto dai Greci nel periodo aureo. La Grecia è al vertice. Prima, come ho già detto, ci sono secoli e secoli di pittura e scultura che non raggiungono la perfezione dell’arte greca del V secolo a.C. In quel secolo è successo qualcosa di definitivo per tutta la civiltà europea, non solo per la storia e per la civiltà greca.
In Lei c’è questo amore verso la perfezione formale, soprattutto della figura umana?
Non è la perfezione della figura, io non parlo di perfezione della figura, parlo del rapporto perfetto tra una forma e l’altra.
Però quando Lei dipinge un quadro astratto è come se volesse dimenticare la figura, umana o no che sia.
Tutt’altro. Perché nell’arte astratta si tratta di proporzioni, non di forme copiate così. Quello che conta sono le proporzioni. Con la pittura astratta si possono ottenere dei rapporti molto più esatti che con la pittura figurativa. Adesso Le dico una cosa che mi diverte parecchio a pensarci sù. Io penso che, se non ci fosse stata la scultura greca, la risurrezione del corpo, secondo il cristianesimo, sarebbe una cosa ridicola: cioè Gesù Cristo non sarebbe stato credibile nel predire la risurrezione del corpo. Ma come!? Un gobbo risuscita gobbo? Uno ha una gamba un po’ più lunga dell’altra e risuscita con quella gamba lì? Quell’altro ha il naso un po’ troppo sviluppato e risuscita così? Nessuno è senza difetti, nessuno al mondo nasce perfetto. Mentre le statue greche di cui stiamo parlando, sono prive di difetti. Perché i Greci hanno fatto questo? Non lo sapevano neanche loro.
Torniamo all’arte astratta. E mi domando: se l’arte astratta ricerca queste proporzioni esattamente come le ricercava l’arte della Grecia antica, non potrebbe essere accusata di eccessivo formalismo? In effetti, questo continuo tendere alla perfezione formale, al ritmo e all’armonia delle forme.
Lei se l’immagina un’arte musicale, pittorica o anche letteraria che si proponesse, invece dell’armonia, la dissonanza? Se l’immagina una musica stonata apposta? Se l’immagina un’arte.
Prendiamo il neo-figurativo attuale, oppure la cosiddetta “transavanguardia”
Quella è fatta da dilettanti. Non sanno niente, sono degli analfabeti in pittura.
Prendiamo magari l’espressionismo tedesco.
Bella roba!
Da questo suppongo che Lei non abbia mai accettato l’arte informale.
L’arte informale è ridicola, perché non esiste niente di visibile che non abbia una forma, quindi è già ridicola la parola “informale”. Uno che non sa dipingere, fa delle porcate informali! È una cosa di una semplicità estrema!. Il fatto è che un buon numero di critici non capisce niente di pittura e scultura, delle quali scrive continuamente sui giornali. Buona parte di quelli che dipingono, non sa cosa fa, ignora i principi della pittura: è come se a scrivere fossero degli analfabeti.
Delle esperienze artistiche successive all’arte astratta, Lei quale accetta? Ce n’è qualcuna?
Io non ne conosco.

Dopo l’astrattismo, praticamente, si è fermato tutto
Non si è fermato niente. Continua l’arte figurativa, tranquillamente migliorata dalle esperienze astratte.
Quindi Lei assegna un ruolo ben preciso all’esperienza astratta anche come incidenza sul figurativo?
C’è, ad esempio, la scultura di Alberto Viani: Viani è vicino alla figurazione, è forse il miglior scultore vivente in Italia, nessuno lo conosce – pazienza! -, però tutto quello che fa è quasi figurativo, e va benissimo: diventa armonioso come la scultura astratta.

A questo punto potremmo sottolineare gli anni in cui Lei decide di dedicarsi alla pittura di ispirazione astratta. Lei non ricorda precisamente verso quale epoca della sua vita ha cominciato a indirizzarsi verso l’astrattismo?
Verso la metà del ’33. Io ero molto amico di Mauro Reggiani, perché Reggiani aveva molta stima di me ed io stimavo lui. Lui è stato il primo in Italia a esporre, con Gino Ghiringhelli e Oreste Bogliardi, la pittura astratta. Io ho cominciato qualche mese dopo Reggiani, che aveva cominciato nel ’32. Nel novembre del ’34 ebbe luogo a Milano, alla Galleria del Milione, la prima mostra dell’astrattismo italiano, con le opere di Reggiani, Ghiringhelli e Bogliardi, ed è durata un mese. Lo stesso anno, a dicembre, sempre alla Galleria del Milione, ci fu una mostra di «Bianco e Nero Astratto», ed io vi partecipai con il mio primo disegno astratto, che posseggo ancora come ricorda.
Lei in quel periodo faceva dunque la spola fra Como e Milano. In quegli anni, diciamo fra il ’30 e il ’32, prima della realizzazione degli affreschi astratti per la Casa del Fascio, ha avuto contatti con l’arte che si faceva in Europa?
Ho fatto frequenti viaggi all’estero, a Parigi, a Colonia, a Düsseldorf, a Basilea. A Parigi ero già andato tante altre volte. In Francia vanno tutti, è come andare in Svizzera a Lugano. Non so dire quante volte né quando ho cominciato ad andarci.
Le sue andate a Parigi hanno influito in qualche modo sulla sua scelta astrattista?
Sì, perché in Francia ho conosciuto anche i cubisti. Poi a Milano discutevo sul cubismo con Reggiani specialmente, ma anche con gli altri amici. E mettevamo a confronto il cubismo col futurismo. Ho visto i primi quadri di Reggiani e ho cominciato a pensarci, e mentre ci pensavo facevo degli esperimenti anch’io, naturalmente.

All’estero quali artisti importanti ha conosciuto?
Sono stati quasi tutti contatti deludenti, che ho avuto; salvo quelli con Léger che sono andato a visitare a Parigi nel suo atelier. Léger è stato il più gentile e il più cordiale. Tutti gli altri, meglio non parlarne. C’era poco da imparare, quasi niente, anzi niente del tutto. Senza volerlo ho dimenticato parecchie cose di quell’epoca, anche i nomi di quelli che ho incontrato.
Perché questi contatti sono stati deludenti?
Perché io facevo qualche domanda e loro non avevano piacere di parlare di arte con uno sconosciuto, perché io ero uno sconosciuto allora a Parigi. Non avevano voglia di discutere e di perder tempo. Però ho visto tanti loro lavori. Ma non ne sono rimasto entusiasta. Non sono mai stato entusiasta della pittura francese.
Vuol dire di quella che ha visto in quegli anni?
Di tutta in generale. Morto Picasso, che per altro era italo-spagnolo e non francese, morto Matisse, morto Braque, chi resta in Francia? I francesi potrebbero dire, naturalmente: “E in Italia, morto De Chirico, chi resta?” È lo stesso discorso. Però anche questi colossi francesi contemporanei, Picasso, Matisse, Braque, non sono grandi come crediamo in genere noi italiani, secondo me. Per esempio non c’è un Morandi, non c’è un Carrà, a Parigi; non c’è neanche un Casorati o un Sironi. Aveva ragione Casorati di dire che noi dalla Francia non abbiamo avuto proprio niente da imparare, salvo l’impressionismo dell’Ottocento, che era superiore alla nostra pittura. Ma in tutti i secoli precedenti non abbiamo avuto niente da imparare. Non è che in Francia abbiano avuto scarsità di pittori, ne avevano come noi, solo che erano tutti un gradino più sotto.
Ma con Léger è stato diverso.
Sì, perché Léger aveva una scuola e quindi era abituato a parlare con i giovani. Io allora ero giovane, mica avevo l’età di oggi. E quindi Léger mi parlava come un maestro parla con un allievo. Io gli facevo delle domande e lui rispondeva perfettamente. Queste domande erano preparate su un foglio di carta, e lui lo vedeva, capiva che a me premevano. Lui era maggiore di me di più di quindici anni. Era già molto noto. La sua era una scuola privata molto frequentata. A Parigi mi avevano detto che lui insegnava molto bene.
E Lei che cosa gli domandava?
Non so più cosa gli domandassi. Tutto quello che riguarda la pittura naturalmente. Certo, si parlava della composizione, non tanto dei colori, perché i colori sono più facili da affrontare. Però il grande colorista è raro, rarissimo anzi. I coloristi hanno una particolare sensibilità, vengono molto ammirati, sono proprio degli artisti, i bravi coloristi. Però è una dote innata. Invece la composizione è più difficile. Io, se vuole lo dico senza modestia, sono uno dei pochi pittori in tutta Italia che la curano abbastanza; gli altri non sanno cosa sia la composizione, ecco, basta, è detto tutto: sono ex pittori figurativi passati all’astrattismo. Ha capito? Purtroppo è così.
E Lei come colorista si ritiene bravo?
Me la cavo meglio nella composizione che nel colore, però qualche quadro. mica male!
Diceva che quando parlava a Parigi con Léger si preparava in anticipo le domande.
Tutte le volte che parlo con un pittore che mi interessa, mi preparo delle domande, altrimenti non me le ricordo più. Lo faccio ancora adesso; anche cinquant’anni fa facevo così.
Quindi Lei, ogni volta che ha accostato qualche collega, ha sentito il bisogno di dialogare, chiacchierare con lui, e si è sempre servito di una scaletta preparata prima. Ha questa esigenza, si direbbe, di metodo
Così ho imparato sempre moltissimo. Un amico carissimo una volta mi ha detto: “Bisogna saper scrivere!”, e io che non sapevo scrivere l’ho ascoltato attentamente. È stato Borra.
Pompeo Borra?
Si; Borra ha avuto un periodo felicissimo; il secondo periodo, che è il più lungo, è meno felice, anzi poco felice. Ma il primo periodo di Borra è un periodo felicissimo che tutti hanno dimenticato, anzi nessuno conosce. Tutti conoscono i suoi ultimi quadri, che sono proprio molto diversi e meno importanti. Quella volta Borra mi ha detto: “Bisognerebbe scrivere per approfondire qualche cosa di buono!”. Fatto sta che un giorno trovo Borra a Milano, e mi dice: “Accetti di scrivere semigratuitamente su un quotidiano di Milano?” “Certo!” gli rispondo. “Perché accetti?” “Perché così posso frequentare Tizio, Caio e Sempronio, i massimi pittori italiani, e far loro delle domande!” Ecco, chiarissimo, no? È quello che poi è successo.
Come mai questa proposta di Borra?
Appena è finita la guerra, ecco, sarà stato il 28 o il 30 di aprile del’ 45, il quotidiano cattolico di Milano L’Italia chiude i battenti, non esce per due giorni e poi riprende con un direttore nuovo. Questo nuovo direttore era un bravissimo giornalista che veniva da non so dove, ed era cognato di Borra. Purtroppo è durato appena due o tre anni perché non era amato dai preti. Allora mi presento a lui – Borra gli aveva già parlato – e lui mi assume immediatamente come critico d’arte. Ho scritto così il mio primo articolo di critica d’arte, io che non so scrivere tuttora. E, si capisce, non è quello il mio mestiere. Però me la sono sempre cavata decentemente. Questa collaborazione è durata dal’ 45 al ’57.
Poi ha fatto il critico per il quotidiano di Como La Provincia: è una collaborazione che dura ancora oggi.
Sì, dura ancora oggi.
Ecco, vorrei approfondire questo suo rapporto con i giornali. È raro che un artista si occupi, giornalisticamente parlando, di critica d’arte.
Lei si sbaglia. I primi critici d’arte, in Italia, sono stati, primo Carrà, che tra l’altro non sapeva scrivere, poi Sironi, critico del Popolo d’Italia e del Popolo d’Italia Illustrato, terzo De Chirico, che ha sempre scritto. Parlo dei migliori pittori italiani, e gliene potrei citare altri sette o otto in tutta Italia, in quegli anni immediatamente dopo il ’45, finita la guerra. Erano loro i critici italiani, anche durante la guerra e prima della guerra. Carrà ha cominciato nel ’20 a scrivere.

Sì, ma oggi?
Purtroppo oggi non è più così. Carrà non sapeva scrivere ma era competente di pittura, e quindi era competente nel suo mestiere. E così pure si può dire di Sironi. Carrà aveva fatto la quarta, non so, la quinta elementare; ma Sironi aveva fatto fino al terzo anno del Politecnico di Milano: studiava ingegneria, poi non se l’è più sentita di continuare, ha smesso di studiare e si è messo a dipingere. Ha studiato pittura, naturalmente, non so come. Lo stesso si può dire di Soffici, il primo critico di Firenze, di Roma e di Milano: era un pittore, ha studiato pittura. Insomma i primi critici erano tutti o pittori o scultori. Come faceva uno a mettersi a parlare della pittura senza capire niente, come adesso succede? Adesso qualunque professore di filosofia o di lettere – tranne qualche eccezione – si mette a scrivere articoli senza la dovuta competenza, senza capire nulla di pittura. Critici del genere cominciano a capire la pittura a sessant’anni. Le fasi in generale sono queste: un critico d’arte che sia laureato in filosofia o in lettere incomincia a scrivere le sue impressioni sulla tal mostra, naturalmente qualche amico pittore gli dice: “Ma che ti è saltato in mente di scrivere quelle cose? Il tuo articolo è pieno di stramberie”, e allora gli spiega il perché; poi trova un altro pittore che gli dice: “Bello quell’articolo!”, e anche questo gli dice il perché. Tra l’uno e l’altro comincia a farsi qualche idea personale e più fondata. Naturalmente questo professore di filosofia o di lettere, non so, che insegna magari al liceo e non capisce niente di pittura, scultura, architettura, e scrive su questi argomenti, non può imparare se non facendo un corso particolare. Ma spesso non ha il tempo di farlo. Allora, a forza di frequentare artisti e di sentirsi dire: “Sì, no, così non va bene, ecc.”, comincia a capire qualcosa verso i quarant’anni, e quando è arrivato ai sessanta incomincia a essere abbastanza pratico di questi argomenti. Mai come un pittore, però.
Lei quali critici d’arte ha apprezzato o apprezza di più?
Quelli per me più noti, che sono: l’ex sindaco di Roma, Argan, poi Guido Ballo, che abita a Milano, Ragghianti che vive a Firenze, Enrico Crispolti, che sta a Roma, infine Luciano Caramel, che è di Como. Un altro che stimavo era Nello Ponente di Roma, che però è morto. Quand’ero giovane io, il critico più importante era ritenuto Ugo Ojetti, che scriveva sul Corriere della Sera. Chi parla più oggi di Ojetti? Nessuno. Ed era il pontefice massimo della critica d’arte in Italia. Era inavvicinabile, quando andava alla Biennale di Venezia era seguito da un codazzo di personaggi. Spaventevole! Ojetti imperava in tutta Italia tranne che a Torino, che era il regno di Lionello Venturi. Le lezioni di Venturi all’Università erano affollatissime, soprattutto dalle signore.
E Lei, nei panni del critico d’arte, come si è trovato?
Mi son trovato male perché non scrivo come vorrei. E allora perché mi sono messo a scrivere? Un po’ per conoscere i massimi artisti e un po’ per impedire che a scrivere fossero altri senza alcuna competenza.
Ha imparato qualcosa dai pittori che andava di volta in volta a intervistare?
Certo.
Cosa ricorda in particolare?
Diventato critico del quotidiano L’Italia per puro caso, come Le ho detto, ho naturalmente chiesto consiglio a qualche amico, così ho potuto chiedere di essere ricevuto da tutti i massimi pittori italiani ai quali facevo le domande col solito biglietto pronto. Quindi tutto quello che ho imparato, l’ho imparato da loro. Non osavano dirmi: “Non rompermi le scatole!”, capisce? Poi scrivevo un articolo qualunque, qualcuno mi ringraziava perfino di questo articolo. Ma io ho imparato così un mucchio di cose, perché facevo delle domande che a me servivano. Ho imparato tutto frequentando i più importanti, specialmente quei tre o quattro uomini di genio autentico come De Chirico, Carrà, Sironi, Casorati. Il più amico era Casorati.
Erano tutti disponibili? Anche De Chirico?
Tutti, sì, anche De Chirico, che era abbastanza rustico di modi, con me è stato sempre gentile, devo dirlo. Anche Sironi amava parlare. Quello che non voleva parlare era Carrà, il più rustico di tutti; però a qualche domanda rispondeva con gentilezza: io lo ringraziavo perché neanche lui osava lasciarmi lì così, vedendo che prendevo appunti mentre parlava. L’ultimo che ho frequentato di più, negli ultimi quindici anni della sua vita, è stato Ugo Bernasconi. Ci si vedeva una volta alla settimana, passavamo il pomeriggio insieme. Mi rivolgevo a lui col mio solito biglietto di domande. Bernasconi aveva una memoria formidabile, un’erudizione incredibile, tant’è vero che, siccome ha scritto anche dei libri interessanti di memorie, ma anche di pittura, viene considerato anche un bravo scrittore. Il suo Parole ai pittori è un libro molto bello. Ho imparato moltissimo da Bernasconi.
Quando Lei conversava con questi pittori, che cosa cercava di scoprire e di comunicare poi ai lettori?
Domandavo delle cose che interessavano soltanto me.
Ma come critico che cosa scriveva poi? Le sue impressioni?
Scrivere quello che ho scritto io, credo che non abbia nessuna importanza: le solite stupidaggini che si dicono. Non so che importanza possano avere i miei articoli di critica.
Magari sono importanti.
Ah, non credo, no! Scrivo malissimo; sì, non ci sono errori di grammatica, ma insomma scrivo male, dico sempre le stesse cose, specialmente quando parlo della composizione. Sono rarissimi i miei colleghi che hanno approfondito lo studio della composizione. Tutti compongono senza sapere cosa sia, eccetto qualcuno: per prima cosa. Come seconda cosa, quasi tutti compongono solo in bianco e nero: un disegno a matita. Fanno il progetto di un quadro, quei pochi che lo fanno; gli altri si mettono li davanti alla tela ancora col sistema impressionistico, quello che arriva arriva, capisce? Invece io faccio un bozzetto grande come un francobollo o poco più, due per due o due per tre, tre per quattro centimetri al massimo, ma di queste dimensioni è già grande. Poi lo faccio grande il doppio per vedere se regge; poi grande il quadruplo. Grande così non regge più perché sembra vuoto, mentre qui è pieno ancora, capisce? E allora vado avanti, insomma, ecco. La nascita di una composizione buona è la scoperta di uno che ha in testa di fare qualche cosa e non riesce a metterla giù subito al primo colpo. Capita anche a me questo fenomeno, ma capita una volta ogni due anni: che metto giù un bozzetto grande come due cartoline illustrate e va subito bene perché l’avevo già pensato tutto più a fondo prima. Di solito parto da pochissimi centimetri.
Quindi si va avanti per tentativi?
Non sono tentativi, sono sviluppi. Sì, qualche errore si fa sempre, ma insomma non sono tentativi, è sbagliata questa parola: sono abbozzi, qualcuno è un po’ meglio, qualche altro è peggio. Lo stesso fenomeno mi succede anche quando faccio pittura figurativa. Se faccio pittura figurativa, quello che fa perdere tempo è la composizione. È per questo che nessuno l’approfondisce. L’accordo dei colori è più istintivo; se uno ha un po’ di buon gusto si arrangia; poi un quadro si può reggere anche con un colore solo, se la composizione è buona.
Ogni quadro ha una sua misura che è l’optimum, così pure una tecnica è più adatta a un soggetto anziché a un altro: da che cosa dipende tutto questo
Bisogna vedere il quadro, discuterlo. Ma si tratta di qualcosa di imponderabile. Più piccolo o più grande, è meno bello, a volte; ogni quadro richiede la sua misura, ogni misura ha un limite. Però voglio dire una cosa che io ritengo importantissima: nei momenti di decadenza prevalgono le opere di grandi dimensioni, nei momenti di massimo splendore prevalgono i quadri di dimensioni modeste. Questo si può dimostrare davanti ai capolavori antichi, dal V secolo prima di Cristo a oggi.
Però le Stanze di Raffaello o la Cappella Sistina di Michelangelo sono opere di grandi dimensioni.
Grandi sono le dimensioni della Cappella Sistina non delle pitture di Michelangelo. Le figure di Michelangelo sono quasi tutte in grandezza naturale e quindi saranno un po’ più grandi perché sono a circa sette metri di distanza, non è che siano ingrandite il doppio, il triplo.
Quindi Lei si riferisce alle dimensioni piccole o grandi del soggetto, non del quadro in se stesso.
In generale, sì. Oggi magari un artista espone un quadro di venti metri, ma che cos’è? Io ho visto la fotografia di un quadro lungo venti metri: è una cosa qualunque. Si fanno quadri grandi invece che piccoli solo per farsi notare di più.
Comunque Lei, quando si pone davanti alla tela bianca, ha già il quadro bell’e pronto perché ha già il bozzetto. La tela è l’ultimo stadio?
Sì, è così. Ecco, guardi questo bozzetto: rappresenta la Nascita della Madonna, l’ho fatto per un affresco che ho poi eseguito in una chiesa con le figure in grandezza un po’ più piccola del naturale. Di questi bozzetti ne avrò fatti, prima, quindici, venti forse.
Ingrandendoli sempre di più ogni volta?
Sì. Qui non c’è niente di straordinario, però Lei vede che c’è uno studio di composizione, e la composizione è ordinata. Ne ho altri tre o quattro di questi bozzetti a matita. Ecco, lì c’è la Madonna che nasce, e questa qui a letto è Sant’Anna. È la nascita di una bambina insomma.
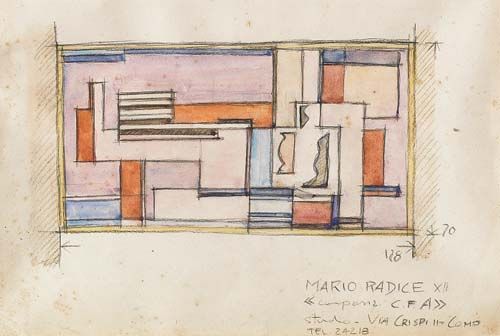
E oltre alla composizione, quale altro elemento è importante in un quadro astratto?
È meglio parlare dei quadri in generale, senza fare distinzione fra astratto e figurativo, perché non c’è nessuna differenza. Lei può dire: “Cos’è importante nella natura morta?”, e allora io rispondo: “Non capisco cosa voglia dire”. Oppure Lei può dirmi: “Che differenza c’è fra un quadro astratto e uno figurativo?”, e ancora io Le risponderei: “Non capisco cosa voglia dire”.
Vorrei tornare dopo sull’opposizione – se esiste – tra figurativo e astratto. Ora comunque parliamo di composizione in generale; ma vorrei domandarLe: oltre alla composizione che cosa ritiene sia importante in un quadro? Il colore forse?
Si, l’accordo cromatico: il colore è altrettanto importante che la composizione, però qualche volta può essere assente addirittura. Voglio insistere su questo concetto: se un quadro è quasi monocromo o monocromo del tutto, come qualche volta ho dovuto fare anch’io dopo aver fatto tante prove, quindi parlo per esperienza personale, qualunque modifica di un elemento del colore può rompere la composizione, la quale invece è inamovibile. La composizione è importante in tutte le opere di pittura, non solo nel quadro astratto. È importante, ad esempio, anche quando uno fa un vaso di fiori; è altrettanto importante anche nel fare delle boccette, come faceva Morandi; è altrettanto importante per chi fa figure, quadri sacri, qualunque tipo di pittura. Il punto di partenza è sempre la composizione. Diversamente sarebbe come se uno facesse musica con i suoni messi lì in disordine, capisce? Questo non è neanche immaginabile, ecco. Il pittore sceglie lo spazio del quadro, sceglie le due dimensioni dello spazio perché dipinge su un piano, dopo avere scelto il rapporto fra base e altezza del quadro.

Casa Carcano, Maslianico, 1950.
E il timbro?
Il timbro in pittura corrisponde al timbro in musica. Insomma, quando Lei vede un pastello, poi un olio, poi un acquerello, poi ancora un affresco, quelle quattro tecniche di pittura sono completamente diverse, ma io posso fare lo stesso quadro con tutte e quattro le tecniche di pittura, e ognuno presenterà un carattere, un timbro particolare.
Lei quale tecnica preferisce?
Io non ho nessuna preferenza, adopero l’olio solo per abitudine, e poi mi piace moltissimo anche l’acquerello; e l’affresco è in testa a tutto perché dura parecchie centinaia di anni.

E il mosaico?
Il mosaico dura, invece di quattrocento, quattromila anni!
Cosa pensa della critica d’arte che vien fatta sui giornali?
La critica d’arte in Italia è recentissima. Supponiamo che abbia sessant’anni di vita, forse settanta; bene, ci dovrebbe essere, secondo me, una laurea in critica d’arte, oppure, se la laurea non si può ottenere, una specializzazione universitaria. Per scrivere in questo ramo bisogna essere competenti. E come si acquista la competenza? Ognuno deve approfondire, deve imparare a capire se un’opera d’arte, una statua, un quadro è fatto da un dilettante oppure da un professionista. Bisogna anzitutto conoscere l’ambiente degli artisti: su cento pittori o scultori, novanta sono dilettanti. E il bello è che non si possono chiamare dilettanti, perché espongono continuamente, fanno mostre dappertutto, espongono più dei professionisti. Insomma i dilettanti pagano, capisce? Io da che sono al mondo non ho mai pagato una lira per esporre qualcosa, non ho mai pagato nemmeno in quadri o disegni, mai.
Nemmeno quand’era alle prime mostre?
Mai, nemmeno agli inizi. E poi cinquant’anni fa non si usava fare delle mostre a pagamento. Non era ancora invalso questo malcostume. E cinquant’anni fa, sessant’anni fa, non c’erano neanche i cosiddetti critici militanti, si figuri un po’!
Ma le gallerie d’arte c’erano.
Le gallerie erano poche. A Milano, nel 1935, erano quindici o venti; oggi, centocinquanta o duecento. Però un gallerista distingueva lui, con un colpo d’occhio, se un artista era dilettante o professionista. Un gallerista non esponeva mai un dilettante, altrimenti veniva squalificato, non rispetto ai colleghi, ma rispetto ai clienti, mi spiego? Ora, con tutti gli ismi che sono nati in questi ultimi cinquanta anni, con la baraonda che c’è nel campo delle belle arti e, ancora più grande, nel campo della critica d’arte, non capisce più niente nessuno. È per questo solo motivo che io perdo tempo ancora a scrivere su La Provincia di Como.
Secondo Lei che rapporto esiste fra critica d’arte militante e mercato artistico? Quanto la critica d’arte influisce sulla vendita dei quadri?
Influisce molto perché il lettore dei giornali e delle riviste quando sente un nome che viene citato molte volte, comincia a dire: “Ma allora questo qui è bravo!”, e compera un suo quadro. L’acquirente dell’opera d’arte è rarissimamente un competente.
Quindi è giusto che la critica d’arte esista. Se non altro indirizza il gusto del pubblico
Sarebbe giusto se la critica d’arte a sua volta fosse scritta solo da persone competenti.
Si può pensare che dietro una certa critica d’arte ci siano interessi di mercato che poi si traducono in vere e proprie cointeressenze finanziarie?
Credo di sì. Anche se inizialmente non ci sono questi interessi, pian piano diventano importanti. Quando un artista viene nominato due, tre, cinquanta volte, per forza diventa famoso e vende quadri. Però quella notorietà sparisce subito dopo la morte dell’artista: questo capita per il novanta per cento dei casi. Resta il dieci per cento dei più citati.
C’è un rimedio a quella che possiamo chiamare la perversione della critica? Lei dice: nelle scuole l’arte non viene insegnata, i critici sono quasi tutti degli incompetenti, i galleristi badano ai loro guadagni, molti critici vivono in stretto rapporto di cointeressenza finanziaria con i galleristi, i pittori competenti che scrivono sui giornali per aprire gli occhi alla gente sono pochissimi, la maggior parte degli artisti è composta da dilettanti. Bene, come far sì che la gente conosca effettivamente il valore di un artista, in quale maniera può essere messa in condizioni di scegliere autonomamente e di scegliere bene?
Da che mondo è mondo l’arte è vissuta senza bisogno della critica. Sessanta, settant’anni fa – parlo dell’Italia – la critica militante sui giornali non esisteva: l’ho già detto, mi pare. Le voglio raccontare un fatto che ricordo con particolare commozione. Quando ho esposto, nel 1972, alla Galleria Annunciata di Milano, le sale della mia mostra erano cinque. Tutte le volte che alla sera mi sono trovato li, ho visto che, verso le sei, forse all’ora d’uscita dal lavoro, veniva sempre un operaio con ancora indosso la tuta: si vedeva che era un operaio, ma doveva avere una passione enorme per la pittura. Si riguardava a uno a uno tutti i quadri e poi si fermava, finché poteva, sempre davanti a uno in particolare. Era un quadro riuscito bene, posso dire anch’io che era uno dei più belli. Io non gli ho mai domandato nulla. Però mi ha molto colpito questa sua attenzione a quel quadro particolare. Forse aveva fatto degli studi d’arte, forse no. Pensa Lei che quell’operaio avesse bisogno di un critico d’arte per capire se un lavoro era buono o no?
Se non c’è una cultura, diventa un fatto istintivo?
In parte sì, in parte no. Bisogna vedere e confrontare. Solo così ci si può fare un’idea giusta. – Tutto sommato, però, la comprensione dell’arte resta privilegio di pochi.
Sono d’accordo, sì, è così. Lei come definirebbe l’arte astratta?
Un’arte che mira a fare delle opere di armonia formale e cromatica, come tutte le altre pitture che ci sono. Finora ci sono stati tre generi di pittura: la figura, il paesaggio e la natura morta; adesso se ne è aggiunto un quarto: la pittura astratta. Non c’è niente di straordinario. È una cosa semplicissima! Bisogna pensare che l’arte non figurativa o astratta, che è la stessa cosa, è sempre esistita da che mondo è mondo, e noi la chiamavamo pittura ornamentale, perché era fatta in gran parte da decoratori o da pittori falliti, per decorare un soffitto, una parete, ecc. Quindi non era una novità, salvo che era fatta da imbianchini, e non da artisti, perciò non veniva presa in considerazione, era una cosa da ridere: delle spirali, delle greche.
Che differenza c’è, dunque, fra arte ornamentale e arte astratta?
Nessuna differenza, se l’arte ornamentale è eseguita a regola d’arte. Anche un paesaggio è un ornato, anche un ritratto è un ornato, anche una natura morta è un ornato. È l’ornamento di un salotto sia un ritratto sia lo studio di un impressionista.

Vuol dire che un’opera d’arte è sempre in funzione di un ambiente?
Un’opera d’arte vive prima di tutto da sola. Ma io voglio ripetere che il tema di un’opera d’arte è la cosa meno importante, e quindi ecco perchè è ridicolo mettere al primo posto, non so, la pittura di figura, poi il paesaggio, poi la natura morta e – come quarto genere di pittura – il quadro astratto. Il tema della pittura, se è valido, non importa niente che appartenga a questo o a quel genere di pittura. Io dico quattro generi, ma potrebbero essere di più: mettiamo per esempio la composizione di fiori, che non è natura morta; o qualsiasi altra cosa. Allora, che differenza c’è fra la pittura astratta e l’ornamento antico? L’ornamento antico era fatto con forme ripetute, stereotipate; l’arte astratta è un fatto compositivo, prima di tutto, poetico, non c’è niente di ripetitivo, di stereotipato. Qualunque quadro, anche un capolavoro di Raffaello, è l’ornamento di una chiesa, di una pinacoteca o di un salotto; ma si tratta di un fatto secondario. Il fatto fondamentale è l’aspetto poetico di una composizione, non l’aspetto ornamentale. La pittura astratta, in Italia, l’aveva già fatta il futurista Giacomo Balla, negli anni Dieci: ma erano più che altro dei precorrimenti. Lui li chiamava “iridescenze”. Poi naturalmente è stato zittito dagli stessi ex futuristi, come Carrà. Però Balla aveva lavorato con sincerità: come astrattista non è molto importante, perchè non ha approfondito questo genere, ha fatto solo alcuni esperimenti. Non era, Balla, un grande pittore come in realtà era Carrà. Più importante – dopo Carrà – è Sironi, più importante è Funi: erano stati bravi come futuristi e lo sono stati anche come novecentisti. Invece Balla è rimasto futurista, anche se nell’ultima parte della sua vita ha prodotto delle opere figurative.
Lei poco fa diceva che l’arte astratta si è sempre fatta, solo che veniva fatta in maniera marginale e spesso da pittori mediocri che se ne servivano per ornare qualche ambiente dei ceti medi. A un certo punto, invece, nell’arte del ‘900 – e non solo in Italia (anzi in Italia con un certo ritardo rispetto ad altri Paesi d’Europa) – viene ripresa e messa in primo piano la pittura astratta. Potremmo dire che questa scelta corrisponde a un atto di giustizia nei confronti di qualcosa di umile, di marginale, di qualcosa che fino a quel momento era “in funzione di qualcos’altro”. E questa operazione veniva fatta nei primi anni Trenta, cioè in pieno regime fascista, in un contesto artistico che mirava al ricupero della tradizione italiana con evidenti aspetti celebrativi, scopertamente retorici. Insomma l’arte astratta nasceva non solo come esaltazione del marginale decorativo, ma anche – sia pure implicitamente – come dissenso, se non opposizione, nei confronti dell’arte ufficiale. Le sembra, questa, un’osservazione peregrina?
Non è affatto peregrina, però la questione va messa su un piano diverso, più semplice. A me è successo questo: un giorno eravamo insieme io e Terragni, c’era sul cavalletto un mio quadro astratto, e lui dice: “Cos’è quella roba lì?” “È un quadro astratto.” “Ma sei diventato matto?” “Non sono matto, tento di fare dei quadri astratti come prima tentavo di fare dei quadri figurativi.” “Ma è una pazzia!” È andato via brontolando, ed io ero persino offeso. Ci stimavamo reciprocamente, e anche lui rimase un po’ offeso. Io assistevo sovente a discussioni fra Terragni e Lingeri, l’architetto Piero Lingeri che era socio di Terragni solo per le opere che costruivano a Milano, perché le opere fuori di Milano Terragni le faceva in proprio; ed è per questo che Terragni aveva lo studio a Milano nello studio di Lingeri: una cosa che va sottolineata perché nessuno la sa. Ebbene, un giorno mi trovai con Terragni e Lingeri che discutevano su un concorso, concorrevano a un premio per la costruzione di un edificio importante. La discussione non finiva mai, perchè Lingeri era maggiore di Terragni più di dieci anni e aveva molta esperienza; Terragni lo stimava, e Lingeri non solo stimava ma addirittura venerava Terragni.

Discutevano davanti a dei disegni, qualcuno fatto da Terragni, qualcun altro fatto da Lingeri: erano lì sul tavolo, tutti disegni di architettura, una sezione orizzontale, una sezione verticale, in questo senso o in quest’altro, e si riferivano a un fabbricato in corso di progettazione. A un certo punto Terragni salta fuori con una frase di questo tipo: “Ma non vedi come è brutto quel disegno lì?” “L’hai fatto tu!” dice Lingeri. “Ma è bruttissimo! Ho sbagliato a farlo” risponde Terragni. Lingeri prende il disegno della pianta, tutta ad angoli retti, e domanda a Terragni: “Cos’ha di brutto?” “Ma non vedi che è tutto sproporzionato? Sono tutti quadrilateri piccoli, questi qui son tutti quadrati, corridoi di rettangoli lunghissimi e strettissimi. È brutto perchè è sproporzionato, indipendentemente dal funzionamento, perchè il funzionamento ci deve essere, ma si può ottenere un funzionamento buono che sia anche bello, anche armonico.” Allora intervengo io. Quella parola mi aveva colpito. Intervengo io e dico: “Cosa vuol dire armonico?”, e loro non me lo hanno saputo dire. “Ma come fai a dire che è bello?” domando ancora a Terragni. “Perchè è armonico!” mi risponde lui. Non ho capito niente, però ho capito che forse Terragni aveva ragione. Fatto sta che Terragni mi ha guardato e mi ha detto: “Allora è per quello che fai le pitture astratte?” “Certo che è per quello, perchè cerco anch’io l’armonia formale come la cerchi tu.” E così finì la discussione. La sezione di un fabbricato può essere armoniosa; allo stesso modo la pianta di un fabbricato può essere brutta perchè non è armonica, è mal fatta dal punto di vista dell’ordine e dell’armonia. “Armonia di parti diverse”: questa è la definizione greca dell’ordine. E non è cambiato niente a tutt’oggi, quella definizione rimane per sempre.
Poco fa Lei faceva questa distinzione dei generi della pittura: figura, paesaggio, natura morta e, infine, pittura astratta.
Nessuno accetta questa distinzione.
Perché? Quali obiezioni Le fanno?
Non fanno nessuna obiezione, stanno zitti: il che è ancor peggio.
L’astrattismo, però, cronologicamente parlando, arriva a un certo punto della storia dell’arte come fatto di estetica, oltre che di poetica individuale. Nasce come esigenza estetica specifica, non come genere di pittura. Sicché l’arte astratta viene generalmente intesa sia come rifiuto dell’espressione mimetica della realtà sia come riflessione sul fare dell’arte, viene cioè intesa come riflessione dell’arte che fa se stessa. Lei cosa ne pensa?
Cosa vuol dire “arte che fa se stessa? “
Arte che riflette sulle proprie possibilità tecniche ed espressive, cioè cerca di sperimentare nuove tecniche e nuovi materiali, cerca di vedere come armonizzare diversamente le forme e i colori rispetto al passato.
Allora si dovrebbe dire la stessa cosa anche della musica sinfonica.
Anche la musica sinfonica è un’arte che riflette su se stessa?
Certamente.
Anche il Giudizio Universale di Michelangelo, o una Madonna di Raffaello, è un’arte che riflette su se stessa? sul proprio linguaggio espressivo? sulle sue possibilità tecniche?
Non capisco cosa voglia dire.
Voglio dire che, forse, l’arte astratta è un’arte pura che prende in considerazione non tanto l’esterno quanto l’interno, non tanto ciò che può essere preso come spunto dal reale affinché l’artista lo faccia suo e poi lo trasferisca sulla tela modificato secondo la sua concezione espressiva del mondo, quanto piuttosto la propria intima sensibilità, il proprio mondo interiore. Nel momento in cui un artista rifiuta l’espressione mimetica della realtà, e fa dei disegni astratti, sembra fare un’arte che ragiona su se stessa, che riflette sulle sue più segrete interiorizzazioni e sulle sue stesse possibilità espressive.
Sì, ma le stesse parole Lei potrebbe ripeterle a proposito di ogni genere di arte. Se un artista dipinge un paesaggio, si interroga o no sulle sue possibilità espressive?
Indirettamente sì; però il riferimento – cioè il paesaggio – è esterno; è quello il tema del quadro; è quello il fatto artistico predominante.
Non c’è nessuna differenza, perché se uno fa un paesaggio, fa magari uno schizzo sul posto in tre minuti, per promemoria, e poi lo sviluppa a casa, e fa un quadro. Bisogna distinguere il tema che si svolge, dal motivo artistico. Qualunque pittura di paesaggio ha un motivo che non è il tema (cioè il paesaggio). Il motivo di un paesaggio o anche di una natura morta o di un quadro figurativo vero e proprio, è sempre un motivo plastico indipendente dal tema.
Che cos’è questo motivo plastico indipendente dal tema?
È quello che si vede più chiaramente nell’astrattismo: l’armonia tra forme e colori, tra forma e forma e tra colore e colore. E se l’armonia è perfetta o quasi, il quadro è buono e basta.
Vorrei tornare al rapporto fra disegno architettonico e arte astratta. C’è un rapporto intrinseco fra architettura razionale e arte astratta?
La pittura astratta è nata in seguito al futurismo e al cubismo, quindi la pittura astratta ha preceduto l’architettura razionale.
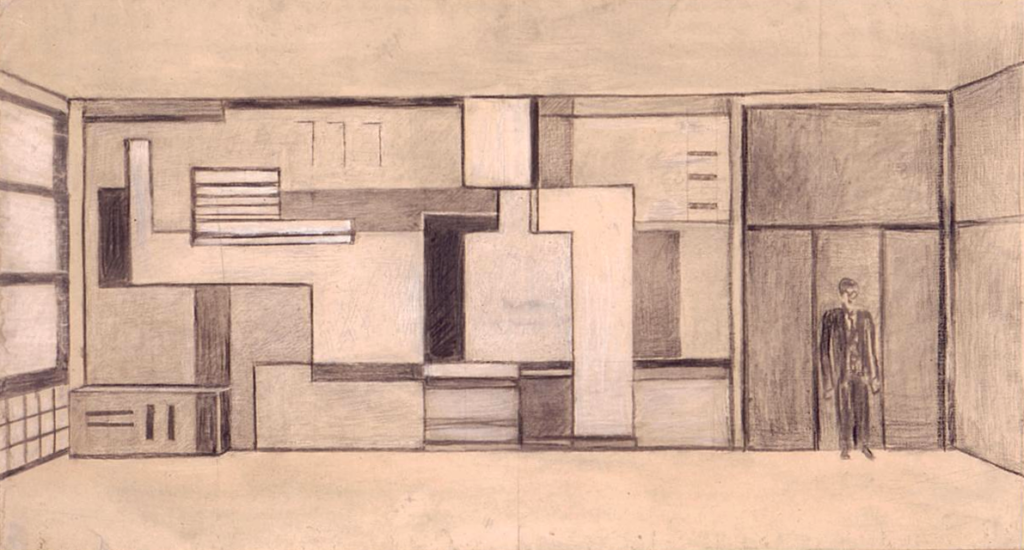
Nel momento in cui, però, Lei lavora ai pannelli che andranno a decorare la Casa del Fascio di Terragni, a Como, questo rapporto c’è.
L’arte astratta è nata, si, con l’architetto presente. Quello che è capitato a Ozenfant con Jeanneret – che si è poi chiamato Le Corbusier – a Parigi, come pure quello che è capitato a Theo Van Doesburg con Mondrian ad Amsterdam e a Kandinskij con Gropius a Weimar, è capitato un po’ a Milano e un po’ a Como tra me e Terragni. Però è sempre il pittore che è più avanti. Perché? Perché l’architetto, prima di essere artista, è professionista, altrimenti non potrebbe far costruire nulla e morirebbe di fame. Se non ha clienti, cosa fa l’architetto? Progetta delle case o insegna disegno e basta, e quindi deve vivere di rendita, se ce l’ha. Quindi è sempre il pittore o lo scultore, perché pittura e scultura vanno sempre insieme e senza interessi immediatamente commerciali, ad essere avanti.
Quando Lei decora la Casa Terragni, fa una cosa completamente staccata dall’edificio, e quindi dal fatto architettonico, oppure cerca di sposare pittura e architettura?
È istintivo sposare le due cose. Uno è dentro l’ambiente, e tutto quello che fa non solo non deve rovinare l’ambiente inventato dall’architetto, ma deve continuare, con altri mezzi, l’opera dell’architetto.
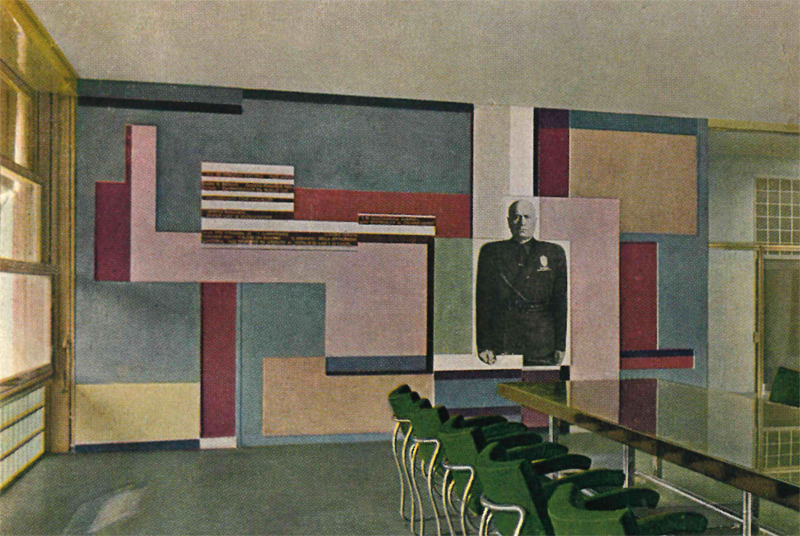
Quindi è un lavoro in comune ma nello stesso tempo autonomo.
Certamente. L’attività con Terragni si è sviluppata, appunto, in Como con la creazione di queste pitture per la Casa del Fascio. Ne lui ne io, tranne il rimborso delle spese vive, abbiamo avuto qualcosa in compenso. Terragni, in pittura, era un novecentista. Ci ha messo dei mesi a capire anche lui l’astrattismo. Per le decorazioni della Casa del Fascio avrebbe preferito Sironi, e poi invece ha capito che Sironi non andava bene perché era il contrario di quello che faceva lui. Sironi sarebbe andato bene con Piacentini, non con Terragni. Io ho fatto i pannelli. In uno ho dovuto mettere la fotografia di Mussolini: era obbligatorio metterla perché si trattava della Casa del Fascio. C’era anche una scritta tratta dai discorsi del Duce. Io la scelsi con cura. Diceva così: “Ma un pericolo tuttavia può minacciare il regime: questo pericolo può essere rappresentato da quello che comunemente viene chiamato ‘spirito borghese’, spirito cioè di soddisfazione e di adattamento, tendenza allo scetticismo, al compromesso, alla vita comoda, al carrierismo. Contro questo pericolo non v’è che un rimedio: il principio della rivoluzione continua. Tale principio va affidato ai giovani di anni e di cuore”. Quando il federale la lesse mi disse: “Ma come vi siete permesso di mettere quella frase lì?” “Ma è di Mussolini, l’ho presa dalla raccolta dei suoi discorsi!” Naturalmente era una frase del primo Mussolini, quello permeato ancora di spirito socialista, e non andava più d’accordo con l’ideologia fascista. In ogni modo la scritta rimase perché io dissi al federale: “Se voi la fate togliere, io scriverò al Duce!”.
I pannelli oggi non esistono più. Vogliamo ricordare come è andato perso questo patrimonio artistico?
Non solo i pannelli, ma tutta la suppellettile: il tavolo di sette metri, i lampadari.

Lei aveva progettato anche il tavolo
No, lo aveva progettato Terragni. Aveva una lastra di cristallo alta alcuni centimetri, un pezzo solo: in Italia non la faceva nessuno, e Terragni l’ha fatta venire da una fabbrica belga, che l’ha data a basso prezzo, come aiuto, ma anche per pubblicità.
Tutto è stato distrutto nel ’45, dopo la fine di Mussolini
Certamente. È successo che, dopo la Liberazione, le forze antifasciste sono andate alla Casa del Fascio e hanno cominciato a buttar giù tutto. Quando ho saputo che stavano distruggendo anche i pannelli, non sono entrato nella Casa del Fascio, altrimenti mi avrebbero fatto la pelle. E allora sono andato dal prefetto di Como, che mi ha ricevuto subito perché era un vecchio amico di famiglia, soprattutto di mio fratello. Era l’avvocato Bertinelli, lo avrà sentito già nominare. Dico a Bertinelli: “Stanno distruggendo la Casa del Fascio”, e lui ha avuto il coraggio di andarci subito, perché bisognava aver coraggio, lui era comasco ed era il prefetto, lo avevano eletto prefetto così, da un giorno all’altro, dopo la Liberazione. È entrato: “Cosa state facendo?” – così ha raccontato lui dopo -. E quelli: “Non vede, stiamo distruggendo questa porcheria!” cioè tutta la Casa. “Siete diventati matti? Questa qui è la Casa dei Partiti, adesso.” “Come, dei Partiti?” “Sì, tutti i Partiti nuovi che già sono stati fondati avranno la sede qui!” “E Lei chi è?” “Sono il prefetto di Como!” Allora se ne sono andati, ma ormai avevano finito di distruggere quasi tutte le decorazioni.
Lei ha provato molto dispiacere?
Certo. Ma cosa potevo fare?
E dal punto di vista documentario, è rimasto qualcosa?
Sono rimaste delle foto e dei bozzetti. Le foto sono quasi tutte molto scure. Ero giovane, non pensavo alle foto. Non ci penso neanche adesso, voglio dire per i lavori che continuo a fare; le foto le faccio fare solo quando me le chiedono. Non sono adatto al mondo pratico.

Nei confronti del regime voi artisti comaschi che atteggiamento assumevate?
Guardi, il fratello di Terragni era il podestà di Como. Prima di diventare podestà era stato vicesegretario federale, quindi era un’autorità. Terragni era sempre al limite di abusare di questa autorità, dell’autorità di suo fratello, perché parlava sempre chiaro e nessuno lo attaccava, nessuno poteva toccarlo. Per esempio, un giorno eravamo seduti al tavolo di un caffè, a giocare a scopa, Terragni, Rho, io e un altro del quale non ricordo il nome, probabilmente Mulazzi, un compagno di scuola di Rho. Giocavamo a scopa e il locale era grande quanto due stanze, niente di più: in un tavolinetto giocavamo noi, in un altro tavolinetto c’erano altri quattro giocatori, e poi c’era il bar dove si stava in piedi.
Quindi c’era della gente.
Cinque o sei persone oltre al nostro gruppo. Arriva dentro il podestà, messo tutto in divisa, e viene a salutare me e gli altri. Terragni lo guarda e gli dice: “Ta ghe mia vergogna de andà in gir cunscià in chela manera li?” Tutti si sono voltati a guardare. Silenzio generale. Il podestà si è messo a ridere e ha detto: “Adesso vado a prendere un caffè!”.
Era un atteggiamento alquanto disincantato
C’era la dittatura, orribile cosa, intendiamoci; però qualunque dittatura finisce a un certo punto, come finisce una malattia. Uno ha l’influenza, dura quindici o venti giorni, poi guarisce e basta, non se ne parla più.
Però come malattia il fascismo è durato vent’anni, un po’ troppo per un’influenza, no?
Sì, d’accordo; ma bisogna guardare tutto secondo una prospettiva molto più ampia, che è quella della storia.
Per poter lavorare indisturbati bisognava essere allineati con le direttive del regime.
Ma oggi è diverso? Forse per alcune cose c’era più libertà allora.
Vuol dire che allora è riuscito a fare delle cose che oggi non avrebbe potuto fare?
Adesso per avere le libertà di allora bisogna militare in un partito politico. Chi è fuori da ogni partito, è fuori da tutto. Noi a Como, durante il fascismo, parlavamo liberamente delle storterie dei fascisti.
Forse la piazza di Como era privilegiata rispetto ad altre piazze d’Italia, magari non era ritenuta importante.
Ma non è che si parlasse male del fascismo, si parlava male del tale o del tal altro.
Facevate delle questioni personali, insomma
Si.
Io mi sono fatto l’idea che l’adesione al regime in una città come Como, negli anni Trenta, è stata un’adesione in fin dei conti utilitaristica, opportunistica.
Sicurissimo.
Lei diceva che per poter fare qualcosa bisogna militare in qualche partito politico, anche, e forse soprattutto, nell’Italia di oggi. La politica dà potere. In che rapporto mette Lei l’arte col potere politico
In un rapporto problematico a tutto detrimento dell’arte. I politici, per ovvi motivi, non possono occuparsi di arte. Quando intervengono i politici, intervengono per fini clientelari o elettoralistici, non per fini d’arte.
L’artista non ha alcun potere per se stesso?
No, non ha alcun potere.
Neanche il potere specifico che gli viene dal portare avanti un suo progetto artistico?
Non è un potere. È una missione. Il missionario che potere ha? Il suo lavoro è rivolto al bene del prossimo. Anche il lavoro dell’artista, il mio lavoro, è rivolto al bene del prossimo. Il bene del prossimo è quello che mi guida. Io non ho alcun potere, ne il potere m’interessa, ci mancherebbe questo!

E durante la seconda guerra mondiale è stato richiamato sotto le armi?
Sono stato richiamato come capitano di artiglieria alpina poco prima che fosse dichiarata la guerra alla Gran Bretagna e alla Francia. Mi hanno chiamato al distretto di Aosta e poi mi hanno mandato al passo della Seigne. Quando è scoppiata la guerra, la mia batteria è andata a piedi dalla Val d’Aosta al Monte Bianco, fino a circa tremila metri d’altezza. La guerra contro la Francia per noi è durata solo alcuni giorni, eravamo tagliati fuori dal mondo, sia gli italiani che i francesi. In quel periodo ho conosciuto lo scrittore Curzio Malaparte, anche lui al fronte con me. Eravamo coetanei. Io ero capitano, lui tenente. Abbiamo fatto il viaggio a piedi insieme, tre giorni di marcia. Si camminava per dodici ore, ci si fermava solo una mezz’ora per mangiare e poi si riprendeva il cammino. Per dormire, dormivamo sotto le tende.

Lei sapeva che Malaparte era uno scrittore?
Altro che! Lui invece non conosceva me come pittore. Era un tipo molto simpatico. Ho di lui questo ricordo preciso: a Saint-Vincent siamo andati insieme da un fotografo per farci fare dei ritratti da mandare alle famiglie.
E dopo quell’esperienza di guerra?
Fui mandato a Bolzano dove rimasi a disposizione e aspettavo l’ordine di partire per qualche destinazione che ancora non si conosceva. Nel frattempo son dovuto andare in ospedale per una grave forma di febbre intestinale. Questo, dieci giorni prima che il mio reggimento fosse mandato in Russia.
È stata la febbre della salute
Certamente, perchè mi ha salvato la vita. Chissà se dalla Russia sarei tornato vivo! Dopo la guarigione sono stato mandato in licenza di convalescenza per sei mesi e poi mi sono dovuto ripresentare di sei mesi in sei mesi all’ospedale militare, dove mi veniva rinnovata la licenza. Alla fine mi hanno mandato in congedo, anticipatamente; ma prima mi hanno fatto firmare una dichiarazione dalla quale risultava che io non avevo contratto la malattia durante il servizio militare. Questo, per non far pagare allo Stato qualche indennità. Come vede, c’è sempre qualche zelante funzionario statale che, in modo molto ottuso, si sente in dovere di fare gli interessi dello Stato a spese della povera gente!
Lei è poi guarito, immagino
Sì, sono guarito; ma in seguito sono sempre stato debole di stomaco. In ogni modo, quelle licenze e il congedo definitivo a qualcosa sono valsi: mi hanno tenuto alquanto lontano dal fronte di guerra e, probabilmente, mi hanno salvato la vita. Sono stato congedato col grado di maggiore.

Che valore attribuisce alla memoria?
Io credo che sia una delle cose più importanti, perché senza memoria si diventa zero. Perfino gli animali hanno memoria. Certe cose però col tempo vanno perdute. Devo proprio far fatica a ricordarmele. Mi aiuta molto mia moglie. Mia moglie ha una memoria e un udito straordinari. Senza di lei non saprei proprio come fare. Per l’udito mia moglie è un fenomeno, sente parlare al di là di due piani, sente mia sorella che si muove all’ultimo piano mentre noi stiamo qui al pianterreno. Lei è come le vipere. Sa che le vipere sono quasi cieche, ma hanno un udito finissimo? Anche i gufi.
Anche i gufi?
Il gufo sta su una pianta alta circa due, tre metri, in attesa che passi un topo. Il topo sa che quello è un passaggio pericoloso, ma obbligato, in certi punti della campagna, del giardino. Il gufo è lì in attesa che passi. Il topo va lentissimo sotto le foglie secche, quindi non si può vedere, anche se il gufo ci vede benissimo di notte. Però il topo va così, alla velocità di un ragno, e quindi non fa nessun rumore. Lo sente solo il gufo, il rumore di una foglia smossa anche se non è secca. Quando il topo gli passa davanti, gli salta addosso; che ci sia una foglia sopra non ha importanza, e lo mangia. Il gufo è provvisto di due orecchie distanziate fra loro in maniera da poter sentire e calcolare la provenienza di ogni più piccolo rumore.
Un particolare ricordo di quel periodo riguardante la costruzione della Casa del Fascio e la realizzazione delle sue pitture e delle sue sculture.
Mi è rimasto in testa questo fatto, che ho sempre ritenuto eccezionale: la Casa Terragni era già inaugurata, gli affreschi erano naturalmente già tutti finiti, anche quello più grande, di sette metri, che era un bassorilievo affrescato; un giorno arriva Fontana, Terragni lo accompagna a vedere l’opera finita, e c’ero anch’io perché ero molto amico di Fontana, lui stimava me come io stimavo lui. Quando Fontana ha visto l’insieme mi ha fatto le congratulazioni e mi ha detto: “Sono proprio contento di vedere finalmente delle cose di questo genere. Vorrei averle fatte io”. Allora Terragni in dialetto ha detto: “Finalment v’un che ‘l parla ciar!” Immagini come sono rimasto io.
Quindi un bellissimo elogio. Fontana era suo coetaneo.
Aveva un anno in meno.
E Lei ha sentito quel complimento come un elogio.
Sì, perché Fontana era già noto e apprezzato a Milano e fuori di Milano, mentre io ero quasi sconosciuto.

Vorrei, per un momento, approfondire l’argomento che riguarda i rapporti fra maestro e allievo. Lei ha avuto dei legami artistici con qualche allievo particolarmente riuscito, di cui può vantarsi?
Sì, qualcuno c’è. Ricordo con particolare piacere Ezio Frigerio, un bravo pittore che è diventato un importante scenografo conosciuto in tutto il mondo perché ha lavorato al Piccolo Teatro di Milano e alla Scala, e poi è stato chiamato anche all’estero. Ricordo ancora Romano Rizzato e Giuseppe Giardina: il primo è diventato anche un ottimo illustratore di libri, l’altro si è dedicato esclusivamente al disegno e alla pittura astratta e ha raggiunto un alto livello di esecuzione. Giardina non si vergogna di dire che è stato mio allievo: ci vogliamo bene, ci stimiamo a vicenda. Verrà conosciuto tardi, ma sono stato conosciuta tardi anch’io. Non può pretendere: dovrebbe fare più mostre. E le mostre costano, purtroppo; costano tempo e danaro; dopo rendono, ma prima bisogna tirar fuori molti quattrini perché i mercanti non vogliono arrischiare troppo.
Ecco, anche il discorso del rapporto dell’artista con i mercanti d’arte mi sembra molto interessante.
I mercanti san solo mercanti, non bisogna prenderli come competenti, benché qualche mercante sia anche grande competente. In quest’ultimo caso è facile instaurare dei buoni rapporti che possono giovare sia all’artista che al mercante.
Ma il mercato di un artista come si forma?
È difficile dirlo. Ogni successo segue regole individuali. Si può affermare che, a un certo punto, se l’artista è veramente valido non trova difficoltà ad affermarsi.
Lei quando ha cominciato a vendere quadri con una certa regolarità?
Tardi, molto tardi, vale a dire quando avevo già una sessantina d’anni.
Quali gallerie in particolare si sono interessate al suo lavoro
La Lorenzelli di Bergamo e Milano e la Marlborough di Roma. Con Lorenzelli sono stato dieci anni: era un mercante molto onesto. Il vecchio Lorenzelli, che adesso è morto, era un uomo molto intelligente. C’è da dire solo che era un gallerista buono più per sé che per l’artista, perché lui vedeva subito il quadro bello, lo comprava, lo pagava meno che poteva, come tutti i galleristi d’altronde, e poi lo metteva via e se lo teneva per sé. Difatti gli eredi ne hanno ancora molti. Insomma non faceva circolare le opere. È per questo che quando ho avuto l’offerta della Marlborough di Roma, l’ho accettata. Pensavo che Lorenzelli facesse delle storie, ma non c’era nessun contratto scritto. Quando, dopo, Lorenzelli mi ha rivisto, mi ha detto: “Hai fatto bene, perché quando si cambia per migliorare è sempre giusto”. È stato molto onesto.
E con la Marlborough, come si è trovato?
Sempre in ottimi rapporti. Ancora oggi i suoi dirigenti mi vengono a trovare.
Il suo primo incontro con Lorenzelli, se lo ricorda?
Prima mi aveva chiesto di portargli qualche quadro ogni tanto, e gliel’ho dato, poi ho deciso di fare una mostra con lui. Ho fatto una bella mostra a Milano, ed è andata molto bene. Erano i primi anni Sessanta. Da allora le cose sono incominciate ad andare meglio.
Diciamo dunque che Lei ha cominciato a vendere regolarmente i suoi quadri dai primi anni Sessanta.
Ci ho messo trent’anni per arrivare.
E durante questi anni non è mai stato preso da scoraggiamento?
Mai.
Adesso non ha una galleria particolare?
No. Ci sono dei galleristi che mi chiedono di avere l’esclusiva delle mie vendite, mi offrono di portarmi in giro per il mondo, per mostre all’estero. Ma stento ad accettare per due motivi: il primo è che la Marlborough era la Marlborough, e dei galleristi non ci si può mica fidare così come niente, perché in fondo gli si dà in mano fior di quattrini e non si sa quando e quanti se ne piglierà; il secondo motivo è che io e mia moglie ormai siamo vecchi e se dovessimo mancare, le nostre figlie cosa farebbero? Perché bisogna star dietro alle cose. È mia moglie che bada a tutto. Lei, adesso, a questi che mi chiedono tutte queste cose, dice: “Voi mandatemi un fac-simile di contratto dove sia registrato tutto, ma completamente tutto, in modo che le mie figlie ne siano al corrente”. Ma le figlie non vogliono che si venda troppo perché non hanno bisogno di niente, grazie a Dio, e preferiscono tenere i quadri, perché i soldi vanno subito alla malora.
Le sue mostre sono sempre andate bene? Ha sempre venduto i suoi quadri?
Da vent’anni a questa parte non posso lamentarmi affatto.
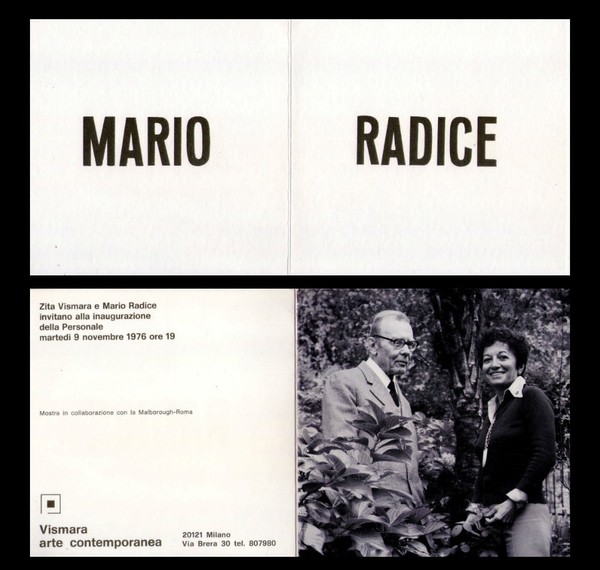
C’è stata qualche mostra in cui Lei ha venduto tutto
Sì, ci sono stati due o tre casi. La prima volta è stato alla prima sala personale che ho avuto alla Biennale di Venezia: è stato venduto tutto, tranne un quadro di proprietà dello scultore Somaini, che non ha voluto venderlo. La seconda volta è stato a Firenze alla Galleria Spagnoli: qui è stato venduto tutto prima di aprire la mostra. Il gallerista mi telefonava: “Mi mandi degli altri quadri”, e io gli rispondevo: “Guardi che i quadri, a venderli si fa in fretta, ma a farli ci vuol tempo!” E difatti non ho potuto mandargliene. Sono stati venduti tutti e amen! La terza volta è stato ad una sala-omaggio che mi avevano allestito a Gallarate: anche lì hanno venduto tutto e dopo, finita la mostra, il gallerista è venuto ancora a Como a prendere altri due quadri per accontentare due clienti che erano rimasti senza. Queste tre volte ho venduto tutto.
E un’emozione?
È un’emozione perché non è mica uno scherzo vendere tutta la mostra. Io ci piango perfino sopra. La prima volta che è venuto da me Lorenzelli e ha portato via un pacco di tele alto così. Beh! quando la macchina è partita mi sono messo a piangere.
Vorrei, appunto, approfondire questo aspetto: che rapporto affettivo si instaura fra l’autore e la sua opera artistica?
Si instaura lo stesso, identico rapporto che ha un padre con la figlia. Cosa vuole che sia? È una cosa naturale: c’è bisogno di spiegarla? Non so cosa dire. Uno fa una certa cosa – un sarto fa un vestito, e così via – e quando se ne separa prova una certa commozione. Poi voglio dire anche questo: i quadri che io prediligo, sono quelli che mi hanno fatto tribolare di più. Adesso non mi succede, ma negli anni passati, quando i quadri non si vendevano e restavano a lungo qui in casa, magari dopo anni io li tiravo di nuovo fuori, vedevo un quadro con dei miglioramenti da fare e lo ripassavo. A forza di ripassarlo diventava un quadro quasi perfetto. Allora mi abituavo a vederlo lì, magari messo in un angolo, e quando dovevo darlo via mi rincresceva. Qualche volta se lo prendeva mia moglie per se e allora non andava più via di casa.
Vuol dire che sua moglie possiede una collezione personalissima di Radice?
Proprio così. Mia moglie ha un occhio critico straordinario e capisce al volo quali sono i quadri più belli.
Questo significa che la collezione privata della signora Rosetta ha i Radice più belli
Non i più belli in esclusiva, ma tra i più belli. Sono quadri mica male.
E che pensieri Le suggerisce il sapere che tanti quadri, tanti lavori fatti da Lei, sono sparsi un po’ per il mondo, in Europa e nelle Americhe, in casa di persone estranee, sconosciute?
Non c’è niente di più naturale, non c’è niente di più inevitabile. È perché faccio quadri. Faccio quadri perché questo è il mio “mestiere”; perché il mio mestiere è quello di “cantare”. Adopero apposta questa parola: “cantare”, perché ogni quadro sarà un “canto” mediocre ma è un “canto”.
Poco fa Lei diceva che, per un artista, fare un quadro, in fondo, è come, per un sarto, fare un vestito. Ecco, che cosa pensa Lei della moda, sia maschile che femminile, naturalmente?
La moda, soprattutto quella femminile, è diventata un motivo importante per il mercato. Però è sempre esistita, da che mondo è mondo, tanto è vero che noi conosciamo benissimo la moda dei secoli passati grazie anche all’arte, alla pittura e alla scultura. Il modo di vestire cambia: per quale motivo? Il motivo è sempre uguale a quello per il quale cambia la lingua, cambia il modo di dipingere, di cantare. Ma oggi anche il canto, il vero canto è morto. Nessuno più canta, non si sente cantare più nessuno. Si ascoltano le canzonette, le romanze, ma difficilmente si canta. Pensi che anche in chiesa non si canta quasi più. In tutte le chiese si cantano due o tre brani della messa, qualcuno dà il la con l’organo o l’harmonium e quei pochi che gli vanno dietro cantano all’unisono e sempre su una nota sola. In Duomo è un po’ meglio, ma nella mia parrocchia è così.
Qual è la sua parrocchia?
Si chiama S. Giuliano, è qui a cento metri di distanza in linea retta. Si canta male, malissimo, urlando le parole su una nota sola.
Parlavamo, poco fa, della moda. Lei come l’ha praticata nella sua vita? Ha amato vestirsi bene?
Non ho mai dato nessuna importanza ai vestiti. Ho capito sempre più il valore della moda e degli abiti, ma non ho dato importanza a questo aspetto. È proprio vero: l’abito non fa il monaco. In qualsiasi modo il vestito non cambia niente. Cos’è che cambia? Io porto la cravatta perché la portano tutti, perché si usa così e basta.
Non ha mai badato a vestirsi in maniera eccentrica, particolare.
No, a cosa serviva? È una sciocchezza. Potevo andare in giro con una gamba nuda, per esempio, ma cosa cambiava?
Anche da giovane non badava al suo abbigliamento? In genere da giovani si cerca di essere più appariscenti, più ammirati.
No, pensavo a tutto meno che al vestiario. Un abito, bastava che mi andasse giusto.
E Terragni, Rho, Cattaneo? Neanche loro curavano il proprio abbigliamento?
No. Ci si vestiva così, alla buona. C’era molta semplicità in tutto, nel vestirsi come nel comportarsi in generale.

Torniamo ai suoi rapporti con il mercato dell’arte. Le è successo qualche volta di incappare in qualche delinquente, di essere fatto oggetto di qualche truffa?
Me ne sono capitate di tutti i colori. Una volta ho fatto mandare dieci quadri a Buenos Aires per una mostra: non sono più tornati indietro ne quadri ne soldi. Un’altra volta a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, se ne sono persi non so più quanti.
E non ha più almeno le foto di quei quadri?
Ci saranno, ma a che cosa servono? Dei primi che si sono persi non è rimasto niente. In principio mia moglie non aveva tempo di occuparsi delle mie cose perché aveva la scuola e le figlie piccole, e doveva badare anche alla casa: faceva quello che poteva. Dopo, quando le figlie sono cresciute e sono andate via dalla mia casa, lei si è potuta occupare dei miei quadri.
Quindi diverse disavventure.
Una sera è venuto qui un tale con l’aria di persona perbene e voleva scegliere un quadro da regalare alla sorella, diceva lui; e ha scelto bene, davvero un bel quadro. Poi ha detto: “Questi quadri sono così belli che quasi ne compro uno anche per me”, e ne ha scelto un altro. Arrivati a questo punto, era l’ora di pagare, tira fuori il libretto degli assegni. Era venerdì sera e gli ho detto: “Io non La conosco; non ha con se un documento?” “Ma no, guardi, sono qui senza documenti!” “Ma è venuto in macchina, avrà con se la patente almeno.” “No, perché sono qui con l’autista.” Allora io e mia moglie ci siamo insospettiti. Quello ha capito che noi dubitavamo e allora ha giocato a fare il signore: “Io lascio qui i quadri e l’assegno, quando voi avrete incassato l’assegno, mi manderete i quadri”. A questo punto abbiamo accettato. Era venerdì sera e fino a lunedì non c’era niente da fare. Lui ci ha dato un indirizzo, un numero di telefono per avvertirlo quando avessimo incassato. Dunque il lunedì mia moglie va in banca, nessuno le chiede niente perché di solito quando va in banca è perché sa che si tratta di assegni buoni: ha lasciato lì quell’assegno e si è messa a telefonare a quel signore: avrà telefonato trenta volte; nessuno risponde; a un certo punto chiede informazioni alla centralinista del telefono. “Signora,” le viene risposto “quello era il numero di una casa che è stata abbattuta”. Quindi era un telefono che non c’era più. Telefona alla banca e le dicono: “Signora, guardi che quello è un assegno che viene da un libretto rubato, e lo abbiamo mandato in protesto”.
E quadri falsi, falsi Radice, se n’è visti arrivare?
Ci sono in giro parecchi quadri falsi miei. Un paio di volte al mese arriva qui qualcuno a farmi fare l’autenticazione.
Finora quanti ne ha riscontrati?
Parecchi; ma non li ho contati. Non so neanche quanti ce ne possano essere esattamente in giro. Una volta è arrivato qui uno che aveva un disegno ed era felice di averlo. Era un disegno perfetto. Io l’ho guardato e ho detto: “Ma come fa ad averlo Lei, se questo disegno ce l’ho io?”. Era stato ricopiato tale e quale dalla copertina di un catalogo, della stessa misura; non hanno fatto la fatica di rimpicciolirlo o ingrandirlo, copiato tale e quale, ricalcato.
Il quadro falso è come il termometro della fama e del valore di un artista: più falsi si fanno, più l’artista è quotato, no?
In genere è un buon segno. Ma molti artisti che sono assai quotati e quindi falsificati, in fin dei conti valgono poco o niente.
Sapere che ci sono dei falsi Radice in giro, Le dà fastidio?
Certo, sì, fastidio. Ma ci penso poco o niente.
Chi ama di più il danaro, è quello che lo falsifica. Si potrebbe dire lo stesso del falsario di quadri?
I falsari non amano l’arte, amano i soldi. Qualcuno però è stato geniale anche nell’arte della falsificazione.
Basterebbe, forse, apporre al quadro la propria firma invece di quella dell’autore dell’originale.
No, bisogna fare la copia un po’ più piccola o più grande dell’originale. Occorre rispettare certe percentuali. È obbligatorio, per legge. Adesso non so, ma trenta, trentacinque anni fa i collezionisti inglesi avevano sempre due o tre pittori in Italia che copiavano i nostri capolavori in maniera quasi perfetta. Io ne ho visto uno agli Uffizi, a Firenze; c’era da rimanere a bocca aperta. Allora ho domandato a quel pittore: “E glielo pagano bene?” “Sì, me lo pagano benissimo. Per questo qui, per esempio, prenderò un milione di lire: ci ho lavorato un mese.” Un milione di lire aveva il suo valore nel 1950.
Diceva poco fa che l’arte astratta nasce in seguito al futurismo e al cubismo.
Mi sono spiegato male. In Italia nasce dal futurismo; altrove, dal cubismo. Le “iridescenze” di Balla sono contemporanee agli acquerelli astratti di Kandinskij. Ma in Italia la filiazione dell’astrattismo è dal futurismo.
E Kandinskij e Mondrian come sono arrivati all’arte astratta?
Mondrian era amico di Theo Van Doesburg, e Doesburg era architetto e pittore. Discutendo insieme. Lo stesso vale per Kandinskij e Gropius. Kandinskij era laureato in legge, ed era di famiglia molto ricca, tanto che ha potuto girare per mezza Europa ed ha viaggiato anche in tutta l’Africa. Prima di essere chiamato al Bauhaus da Gropius, faceva della pittura postimpressionista. Il pittore Mondrian fu influenzato dall’architetto Van Doesburg, mentre l’architetto Gropius ha influenzato il pittore Kandinskij. La matrice dell’arte astratta è sempre l’incontro con l’architettura, cioè l’incontro fra un pittore e un architetto. Come è capitato a me e a Terragni. Io non le sapevo queste cose quando lavoravo con Terragni. Anche Kandinskij non sapeva niente del suo collega pittore Mondrian, tanto meno Mondrian di Kandinskij. Io poi, in quegli anni, lavoravo con Terragni, anzi per Terragni, molto tempo prima dell’episodio della Casa del Fascio.
Cioè lavorava a fare disegni architettonici per Terragni?
Si, eravamo molto amici. In certe occasioni gli davo una mano.
Quando Lei è venuto a conoscenza del lavoro di Mondrian e Kandinskij?
Non ricordo più.
Diversi anni dopo?
No, no; ma non saprei dirlo. Negli anni Trenta avevo anche lo studio a Milano, quindi ero sempre alla Galleria del Milione. Era naturale che si parlasse di arte e soprattutto di arte contemporanea europea. Tutte le sere, verso le sei, andavo al Milione: erano li tutti i giovani che uscivano da Brera, quindi era facile parlare con Tizio o Caio, insegnante o non insegnante, di arte e di artisti. La Galleria del Milione era precisamente di fronte all’ingresso dell’Accademia di Brera.
Era facile allora venire a contatto con le esperienze artistiche d’Oltralpe?
Sì, certo, anche adesso è facilissimo. E si può dire che i nostri critici si occupano più della pittura estera che di quella italiana. Sbagliando, secondo me. In Italia siamo esterofili, insomma.
Da che cosa nasce questa esterofilia, secondo Lei?
Dal nostro eccessivo provincialismo, purtroppo. Io credo che il provincialismo sia un bene ma anche un male: uno dei mali è l’esterofilia. Un bene, quando il provincialismo è segno di modestia. E se uno è modesto e umile, meglio per lui. Il primo di tutti i mali è la superbia, poi ci sono l’invidia e l’avarizia.
Lei è stato sempre modesto e umile?
Io, passando dalla pittura figurativa alla pittura astratta, ho guadagnato di meno. Questo passaggio è stato finanziariamente oneroso per me.
Vuol dire che avrebbe fatto meglio a continuare col figurativo, dal punto di vista dei guadagni?
Si, avrei guadagnato di più. Il doppio, il triplo. Mentre nei primi tempi l’astrattismo rendeva zero, zero assoluto.
E Lei, continuando a fare il figurativo, dove si sarebbe collocato? Nella corrente del Novecento?
No, non ero novecentista. Si, somigliavo un po’ anche al Novecento, ma insomma io non capisco cosa sia e cosa significhi Novecento. Novecento vuol dire tutto un periodo che non so definire.
Un periodo ricco di esperienze diverse, le più disparate.
Ecco, si. Un artista era impressionista, un altro veniva dal futurismo – come Carrà, per esempio – e quindi sapeva comporre abbastanza bene. Il Novecento è un miscuglio di esperienze: si adopera questo termine, oggi, in senso spregiativo; ma è una maniera sbagliata.
Forse per ragioni ideologiche, perché era compromesso col regime fascista.
Be’, De Chirico non è mai stato fascista, ed era considerato novecentista. Sironi, sì, era amico personale di Mussolini, ma poi ha capito che il fascismo non andava bene.
E Lei?
Io mi ritengo soltanto cristiano. Probabilmente allora ero fascista anch’io; ma questo per me non aveva e non ha nessuna importanza.
E i suoi rapporti con il regime, quando si trovò a collaborare con Terragni per la realizzazione della Casa del Fascio, quali furono?
Era obbligatorio iscriversi al partito fascista. Io ero amico di Terragni ed ero amico anche del suo braccio destro, cioè l’architetto Luigi Zuccoli, che allora era ancora perito edile. Zuccoli era in un certo senso allievo di Terragni; ma, senza Zuccoli, Terragni non sarebbe stato Terragni: non perché Zuccoli lo aiutasse nelle sue invenzioni, ma perché gli obbediva fedelmente. Zuccoli era più giovane di tre o quattro anni, e stimava moltissimo Terragni, quasi lo venerava.
Come mai fu accettato a Como un progetto come quello della Casa del Fascio? Mi riferisco anche alle sue decorazioni astratte, sicuramente né monumentali né retoriche, cioè non in linea con le idee del regime.
Il fratello di Terragni, Attilio, era allora il podestà di Como, come Le ho già detto. Il podestà era amico del federale della zona di Como.
Altrimenti sarebbe stato difficile realizzarlo, quel progetto?
Terragni aveva contro tutti gli ingegneri di Como. Oggi nella provincia di Como ci sono un centinaio di architetti, mentre allora ce n’erano soltanto due. Non è che nel frattempo la popolazione sia aumentata in proporzione: oggi la città ha centomila abitanti, allora ne aveva sessantamila.
In quel periodo chi erano i personaggi più in vista a Como, nel campo dell’architettura, oltre a Terragni?
Nessuno.
Terragni era di Meda. Come era approdato a Como?
Terragni era figlio dell’arte. Suo padre era costruttore, non era architetto perché ai suoi tempi non esisteva la laurea in architettura, ma possedeva qualcosa di analogo al titolo di perito edile; costruiva case disegnate da lui stesso. Quindi Terragni era nato, per così dire, in mezzo alla calcina e alle impalcature. Ha avuto la disgrazia di perdere la mamma quando era ancora giovane, giovanissimo. Lei era morta istantaneamente, di emorragia cerebrale. Dello stesso male è morto anche lui, a quarant’anni. Suo padre si era trasferito a Como quale sede di lavoro e aveva comperato una casa in centro, quella che ancora oggi è della famiglia Terragni, con sù la lapide per ricordo. C’è ancora lo studio del fratello di Terragni e dei figli di questo, un architetto e un ingegnere, che continuano ancora la tradizione di famiglia.
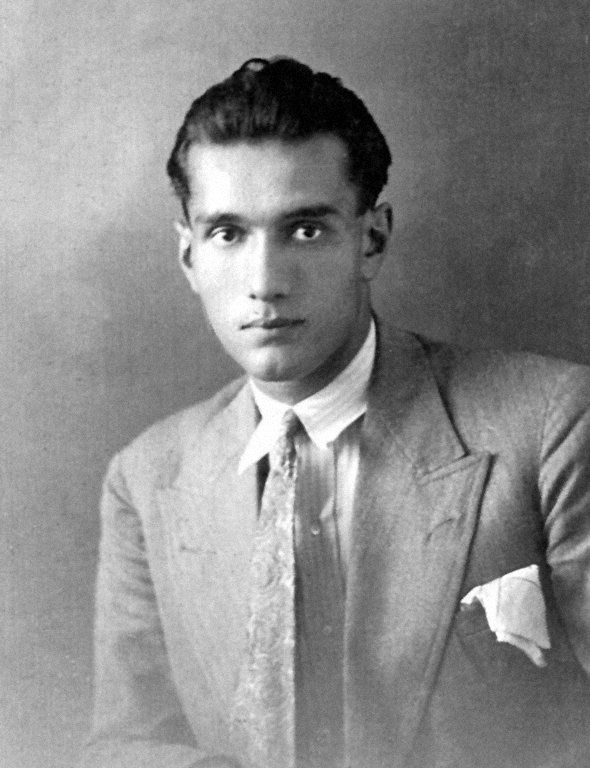
Che tipo era Terragni?
Aveva un carattere forte; era però di animo buono e onesto. Agli amici sembrava un po’ strano, per il suo anticonformismo. Ma non si dava affatto arie. Sapeva di essere meglio di altri – non dico qui a Como, la cosa fa perfino ridere; Terragni a Como, oltretutto, non è riconosciuto veramente nemmeno oggi – e lo diceva apertamente: “Siamo in tre o quattro in tutta Italia”. E faceva i nomi dei tre o quattro architetti che per lui erano i migliori in campo nazionale. Ricordo in particolare il nome del milanese Figini, che era suo compagno di scuola e coetaneo. Terragni, tra l’altro, dipingeva; e lo faceva abbastanza bene: faceva dei paesaggi, dei ritratti. Disegnava anche bene: i suoi disegni di architettura, i bozzetti, sono stupendi, fatti così, a mano libera.
La morte di Terragni com’è avvenuta?
Era andato in guerra in Russia, purtroppo. Era in artiglieria pesante campale, che non era un’artiglieria di prima linea ma di seconda, ed era addetto al comando di gruppo; il gruppo corrispondeva al battaglione della fanteria. Naturalmente i suoi amici e colleghi che erano in prima linea lo trattavano da imboscato, cosa da ridere perché la distanza tra prima e seconda linea era di soli trecento metri. Comunque lui era al riparo dalla prima linea, e allora chiese di andare in prima linea, con le batterie. Lì ha fatto il suo dovere. Dopo un mese o due, è cominciata la ritirata, quindi è dovuto scappare. Quando è tornato in Italia era trasfigurato: aveva visto e vissuto esperienze tremende. Lui poi era convinto della vittoria, credeva che la guerra si potesse vincere. Era un po’ strano in tempi normali, come Le ho detto, figuriamoci al ritorno dalla Russia. I suoi amici si sono spaventati a vederlo così sconvolto. Per me che lo conoscevo bene, però, non era così alterato. Anche suo fratello Attilio, che ormai non era più podestà, era rimasto turbato a vederlo in quelle condizioni: era andato in guerra a Rodi e lì aveva conosciuto l’inventore dell’elettroshock, il professor Cerletti di Pavia, e così gli ha fatto fare una cura intensa, otto o nove sedute. Tutte le volte Terragni perdeva i sensi. Quindici giorni dopo l’ultima seduta, è morto. Era in casa da solo e stava preparandosi la colazione, si è sentito male, ha telefonato alla fidanzata per avvertirla ed è uscito per andare da lei, che abitava a trecento metri di distanza, lasciando tutte le luci aperte e il gas acceso sotto un pentolino e le porte spalancate. La fidanzata che lo aspettava dal balcone, lo ha visto arrivare, gli è andata subito incontro per le scale e ha visto che cadeva battendo la testa. Terragni è caduto sul pianerottolo del primo piano ed è rimasto lì morto. Non si è saputo se è morto perché era caduto o se è caduto perché era morto. Il medico che è accorso, ha constatato che Terragni aveva una macchia nella zona del cervelletto, dovuta a sangue raggrumato. Probabilmente era stata un’emorragia, ma non si è mai potuto stabilire se era stata causata dal colpo preso nella caduta.

E Sant’Elia, l’architetto futurista Antonio Sant’Elia? Ha avuto modo di conoscerlo?
Mai personalmente. Io ero più giovane di lui di dieci anni. Non ho mai potuto conoscerlo perché io vivevo in un ambiente di pittura e non ero ancora in grado di capire che l’architettura, la scultura e la pittura sono vicine tra di loro. Quando lui è partito per la guerra, nel ’15, io avevo diciassette anni; e quando anch’io sono andato sotto le armi, con la classe del 1900, la guerra era ormai finita e Sant’Elia era morto, nel’ 16, al fronte. I suoi disegni, li ho potuti vedere in casa di sua sorella che li possedeva, e della quale ero diventato buon conoscente. Anzi alla sorella di Sant’Elia ho dato dei consigli preziosi, devo dire, raccomandandole di non regalare i disegni del fratello a destra e a manca, di conservarli gelosamente, perché costituivano un patrimonio artistico importantissimo. Parlando col mio amico Rho, gli ho suggerito di proporre al sindaco di Como, di cui Rho era molto amico, l’acquisto di tutti i disegni di Sant’Elia. Grazie a questo interessamento, il Comune di Como ha comprato i disegni e li ha collocati a Villa Olmo, dove c’è una sala dedicata a Sant’Elia. Ho sempre stimato grande come architetto Sant’Elia. Peccato che non abbia potuto realizzare nessun progetto. I suoi disegni sono molto belli, davvero stupendi. E poi Sant’Elia ha anticipato i tempi: ha visto che cosa si sarebbe potuto fare con il cemento armato, precedendo tutti gli altri architetti del mondo di vent’anni come minimo. Pochi cosiddetti storici dell’arte sanno questo.

E Manlio Rho, che tipo era?
Era un uomo un po’ timido, perché non aveva neanche il coraggio di andar fuori di Como. Non viaggiava, aveva paura di allontanarsi dalla città: una specie di incubo, di fobia. Prevedeva forse la sua fine prematura. Come pittore era uno dei cinque o sei migliori d’Italia del suo tempo. Anche lui era, in parte, figlio dell’arte perché il suo nonno paterno era stato un bravo pittore, purtroppo poco conosciuto. L’atmosfera provinciale è favorevole agli artisti che passano la vita “studiando” con passione e serietà come Rho, ma nuoce alla cosiddetta carriera. Di Rho si tornerà a parlare non per vendere i pochi quadri rimasti in famiglia, ma per dimostrare ciò che era in realtà. Si vedeva che era sempre preoccupato per la sua salute, anzi gli amici lo prendevano in giro per questo, perché dicevano: “Eh! Tu ne hai sempre una!” Invece il poveretto aveva ragione, infatti è morto a cinquantasei anni.
Di che cosa è morto?
Di emorragia cerebrale, come la sua mamma. È rimasto qualche giorno in coma senza mai riprendere conoscenza. Pensi che noi ci eravamo trovati insieme al cinematografo l’ultima sera. E alla mattina dopo mi hanno comunicato: “Manlio Rho è moribondo”. Eravamo usciti dal cinematografo insieme, e stava benissimo. Come carattere, anche lui era un po’ strano. Si occupava con passione della storia di Como. Era quello che conosceva meglio di tutti la città, tutte le varie notizie. Era anche una persona gentile, generosa, di animo buono. Però non è stato fortunato, ecco.

Del gruppo dell’astrattismo comasco hanno fatto parte anche Carla Badiali e Aldo Galli; poi ancora Carla Prina.
Galli è venuto verso il ’40; la Badiali sarà venuta verso il ’36, non ricordo bene. La Badiali era allieva di Rho, prima al Setificio di Como dove Rho insegnava disegno per tessuti, e poi nel suo studio, dove prendeva lezioni di pittura. Così ha imparato a dipingere sul serio e non come si impara a scuola. È stata allieva di Rho un paio di anni o tre. Io sovente andavo a trovare Rho in studio, verso le sei, le sette di sera, e lì c’era sempre la Badiali. Aldo Galli impressiona di più degli altri perché era proprio un operaio; dopo le elementari era andato alle scuole serali di disegno. Era rimasto orfano giovanissimo, faceva lo stuccatore, l’imbianchino, quello che capitava. Rho l’ha chiamato in studio per fare delle sculture di gesso: cioè non le doveva fare Galli, le doveva fare Rho e Galli doveva tradurle in gesso, appunto perché era uno stuccatore. Galli era un ragazzo intelligente. Frequentando lo studio di Rho domandava: “Cos’è questo? Cos’è quest’altro?” Ha visto dei libri che riguardavano la pittura e li ha chiesti in prestito. Dopo, Rho si è lamentato: “Perché cosa perde tempo? Cosa gliene importa?” Insomma mai avrebbe creduto che Galli sarebbe diventato pittore. Però Galli frequentava una scuola serale di disegno, come Le ho detto, e così ha imparato a fare qualcosa. Ma non ha mai saputo copiare dal vero. A lungo andare poi si è dedicato al disegno per stoffe. Come disegnatore è stato assunto dalla Badiali, che dirigeva appunto il proprio studio di disegni per tessuti. Probabilmente era stato raccomandato da Rho. È stato alcuni anni nello studio della Badiali, e lì doveva sgobbare per guadagnarsi da vivere, Lei capisce. Poi si è messo a dipingere. Ma prima di dipingere si è dedicato alla scultura, e ha fatto in legno i suoi capolavori. Quei tre o quattro pezzi di scultura astratta che ha fatto allora, sono ancora le sue opere migliori. Dopo si è dedicato alla pittura perché la scultura richiedeva soldi. Costa la scultura: lo scalpello elettrico, tanto per cominciare, e una gran quantità di altri attrezzi, senza parlare dell’eventuale fusione. E poi lo scultore, se deve fare una statua, lavora magari sei mesi, un anno; e come fa a vivere nel frattempo? Insomma deve avere dei mezzi propri, altrimenti fatica a vivere. Un po’ più tardi si aggregò al nostro gruppo anche Carla Prina. Diplomatasi in pittura all’Accademia di Brera, cominciò a frequentare lo studio di Rho e divenne ben presto una validissima astratti sta anche lei. Dopo qualche anno sposò l’architetto Alberto Sartoris, che ha il merito di aver sostenuto criticamente, per primo, in Italia e all’estero, il gruppo degli astrattisti comaschi.

A questo punto mi piacerebbe che Lei esprimesse un giudizio critico personale sull’arte di questi suoi compagni di strada.
Rho, se fosse vivo, sarebbe uno dei migliori pittori astrattisti italiani; la Badiali viene subito dopo Rho, mentre Galli è più importante come scultore; la Prina, infine, è anche lei un’astrattista di prim’ordine. Tutto qui il mio giudizio, che può essere sbagliatissimo, s’intende.
D’accordo, è un giudizio personale, ma a me è quello che interessa particolarmente: appunto che cosa Lei pensa del lavoro di questi suoi amici, visto che vengono messi insieme, con Lei in testa, nel cosiddetto Gruppo Como.
Gruppo che poi non c’è stato!
Vuol dire che è stato ricostruito a posteriori?
Precisamente. Erano tutti amici miei, e ad un certo punto hanno cominciato a parlare del Gruppo Como. Io non l’ho mai fondato deliberatamente. Intendiamoci: l’ho fondato io realmente in quanto io sono stato il primo a Como a fare l’astrattismo, e gli altri erano amici miei, tutto sommato si viveva insieme. Ma non c’è mai stato niente di ufficiale.
Non avete mai elaborato un manifesto?
No. Quindi il Gruppo Como in un certo senso non è mai esistito, per così dire, burocraticamente. L’architetto Sartoris ha poi scritto più volte che il Gruppo Como l’ha fondato lui, e criticamente e moralmente è vero, perchè lui in quegli anni ha scritto degli articoli importanti favorevoli al nostro gruppo e all’arte astratta, quando l’astrattismo veniva ignorato o addirittura disprezzato dalla maggior parte dei critici ufficiali, come, ad esempio, Ojetti e Soffici.
Lei ha avuto modo di conoscerli personalmente questi critici?
Ojetti non amava l’arte successiva all’impressionismo, e quindi passava completamente sotto silenzio anche l’astrattismo. Con Soffici ho avuto invece una vera e propria polemica. Lui aveva scritto un articolo contro ogni forma di pittura non figurativa, pubblicato sulla Gazzetta del Popolo di Roma del 14 luglio 1942, ed io gli risposi su Libro e Moschetto di Milano, con una lunga nota pubblicata il 5 settembre dello stesso anno.

Lei ha conosciuto anche Marinetti?
Oh, figurarsi! Sì, sì, l’ho conosciuto molto bene. Anzi Marinetti, quando è venuto via da Milano, verso la fine del fascismo, nel ’43, ha portato qui tutti i suoi documenti. È venuta la moglie per ordine suo a portar qui delle valigie piene di documenti.
Qui dove? In casa sua?
Si. Eravamo a tavola ed è arrivata la signora Marinetti con queste valigie. Ha detto: “Radice, mi aiuti, me le tenga qui, mio marito sta molto male, sta morendo”. Io ho detto: “Va bene, le metta lì”, e così è stato. Marinetti poi è morto a Bellagio l’anno dopo. I suoi funerali sono stati fatti a Milano ed io ci sono voluto andare. C’erano pochissime persone al seguito, davvero molto poche, perché già allora serpeggiava la paura, tutto cominciava ad essere molto incerto, e Marinetti era troppo compromesso con il fascismo. Gli artisti presenti al funerale eravamo solo due: io e l’architetto Pietro Lingeri. Ci siamo trovati lì: “Cum’è, ta see chi anca tì?” “Eh, già, cos’u de fa!” Tutto lì, niente di speciale. C’era la moglie di Marinetti, l’ho salutata, poi c’erano altri sette o otto milanesi che non conoscevo, uno o due altri li conoscevo, erano futuristi, non ricordo più chi fossero, li ho salutati, poi siamo andati al Monumentale, ed è stato sepolto lì Marinetti. Povero Marinetti! Ha buttato via tutto quello che aveva per gli altri, e poi quando è morto non ha visto quasi nessuno al suo funerale. Lui ha avuto dei torti ma ha avuto anche dei meriti. Adesso lascia in eredità qualcosa delle sue iniziative: l’amore delle novità, per esempio, è in tutti gli artisti, perché l’arte non progredisce ma neanche si ripete. Marinetti aveva insegnato questo amore per le novità.

E le valigie che Le aveva affidato la moglie di Marinetti, che fine hanno fatto?
Le ha fatte ritirare lei stessa dopo qualche tempo. Erano lì, forse sigillate, nessuno le ha aperte, le sono state restituite come le aveva portate.
I suoi rapporti con Marinetti quali erano stati?
I nostri rapporti sono semplicissimi da dire: ho conosciuto e frequentato Marinetti quando ho esposto insieme con i futuristi alla Biennale di Venezia, dapprima da solo nel ’40, e nella successiva insieme con Rho: tutt’e due le volte nel reparto che chiamavano “Il lazzaretto”. Era chiamato così dai nostri nemici, dai nemici del futurismo insomma. In fondo avevano ragione di chiamarlo “Il lazzaretto” perché Marinetti accettava tutti, non so con quale criterio, e c’erano dei pittori che non sapevano fare neanche un quadrato. Questa partecipazione alle Biennali di Venezia del ’40 e del ’42 con i futuristi non ha avuto più seguito, perché poi dalla terza volta, nel ’48, non ho più esposto nella sala dei futuristi. Marinetti, del resto, era morto, ormai, pazienza.

Fra i tanti personaggi da Lei conosciuti c’è anche Margherita Sarfatti?
Ho potuto parlare con lei innumerevoli volte. Aveva la villa a Cavallasca, qui vicino a Como. Ci sono andato da solo un paio di volte, con Terragni parecchie altre volte. Con me la Sarfatti parlava dall’alto perchè detestava la pittura astratta, non la riconosceva come vera pittura. Poi ho avuto qualche discussione con lei, e lei ha capito che io studiavo sul serio, finche è diventata gentile anche con me. Era una donna coltissima, si occupava di arte e di letteratura, oltre che di politica. Conosceva molte lingue, era molto intelligente e affascinante. Ognuno ha i suoi lati buoni e i suoi lati cattivi, non so che dire. Io arrivo a dire perfino che se Mussolini fosse rimasto con la Sarfatti, con cui s’era messo quando viveva ancora a Milano, sarebbe cambiata la storia d’Italia. Intanto la Sarfatti aveva una cultura molto superiore a quella di Mussolini. Mussolini era un maestro di scuola elementare, con una cultura insufficiente: poteva anche essere, non so, un genio, anche un genio analfabeta e avrebbe fatto meglio, oppure poteva avere una grande cultura e si sarebbe comportato meglio; ma a lui mancavano sia il genio sia un’adeguata cultura, è questo il guaio. Invece la cultura ce l’aveva la Sarfatti, per davvero, perché veniva da una famiglia altolocata, aveva studiato a Parigi, era ricca, passava dei mesi in Francia, in Germania, in Inghilterra. Io credo che lei desse dei buoni consigli a Mussolini, ma da quando l’ha piantata Mussolini non ha fatto altro che scempiaggini. Comunque c’è un episodio che Le voglio raccontare. A me lo ha riferito Funi, che era molto amico della Sarfatti. Pensi che la Sarfatti si occupava abbastanza profondamente di pittura e di scultura, non di architettura, e ha conosciuto i massimi pittori italiani del suo tempo, quindi era quasi sempre in familiarità con Carrà, Sironi, Soffici, Casorati, De Chirico, parlava con lo stesso vocabolario di queste personalità dell’arte italiana. Io parlando con Casorati, con Carrà, con De Chirico imparavo delle espressioni verbali particolari che riguardavano, appunto, l’arte, e poi, mentre ero a colloquio con la Sarfatti, lei diceva le medesime espressioni. Allora esclamavo: “Ma io ho già sentito questa frase dal tale!”, e lei: “Ah, ma non è che io la ripeta, è lui che l’ha imparata da me!” mi rispondeva.
Diceva di quell’episodio riferitoLe dal suo amico Funi.
Riguarda un colloquio avuto dalla Sarfatti con Mussolini a Palazzo Venezia. Funi era rimasto fuori dalla sala, ma la porta era semichiusa ed ha sentito tutto. Dopo l’assassinio di Matteotti, Mussolini era in crisi, allora Mussolini ha detto alla Sarfatti: “Ecco, ti faccio vedere le mie dimissioni, che domani presenterò al Re”. E la Sarfatti di rimando: “Sei un castrato!”. Probabilmente Mussolini non si è dimesso anche grazie a quelle parole della Sarfatti. Come vede, la Sarfatti è riuscita in certo qual modo a mutare la storia d’Italia. Cosa da pazzi! In quel momento, naturalmente, ha sbagliato lei, non lui.
Vorrei aprire il discorso sulla fortuna o sfortuna di un artista anche bravo che viene riconosciuto o ignorato, a seconda dei casi, indipendentemente dalla sua volontà e dalla qualità del suo lavoro
Se un artista è bravo, il riconoscimento, anche tardivo, viene. Ci sono pittori che si riconoscono in vita e altri che si riconoscono trenta o quarant’anni dopo la loro morte. Ancora oggi ci sono pittori così, ed è forse una fortuna per loro. Io ritengo, in generale, che più tardi viene riconosciuto un artista, meglio è anche per lui. Non appena viene riconosciuto per qualcosa, se non è proprio vecchio come sono io, si monta la testa e questo lo rovina. Invece se sta in ombra, è meglio. Ci sono dei grandi, grandissimi musicisti che sono stati riconosciuti addirittura alcuni secoli dopo la loro morte: Johann Sebastian Bach è stato riconosciuto come un genio della musica solo da quaranta o cinquanta anni; prima era, sì, ritenuto un bravo compositore, ma non quel genio che è stato definito dopo. Nella pittura voglio fare i nomi di Piero della Francesca e di Paolo Uccello, che si dovrebbero chiamare rispettivamente col solo nome perché sono dei sommi come Raffaello o Michelangelo o Leonardo. Piero e Paolo sono due colossi pari a Raffaello, tanto l’uno che l’altro. Solo che Raffaello è un fenomeno più facile da capire, mentre per capire Piero e Paolo ci sono voluti secoli: sì, erano considerati bravi ma non dei colossi, fino a non molto tempo addietro. Anche nella scultura gli esempi non mancano: Giovanni Pisano è stato ritenuto buono, ma non ottimo, fino a pochi decenni fa. Adesso qualcuno sostiene che Giovanni Pisano è uno dei massimi scultori degli ultimi duemila anni. Tra l’altro, Giovanni Pisano è figlio dell’arte, anche suo padre era scultore: ma mentre Giovanni era nato a Pisa, e per questo veniva detto Pisano, suo padre era pugliese, emigrato a Pisa per il suo lavoro di scultore, ed era uno scultore bravo anche lui. E poi voglio dire una cosa che secondo me è molto importante, ma che nessuno ha mai fatto osservare: secondo me, il fatto che il padre di Giovanni, Nicola, fosse pugliese, ha influito sull’educazione artistica del figlio, perché il padre ha senz’altro visto la scultura greca che c’era in Puglia, e quindi ha parlato al figlio di questa scultura di cui esistevano molti buoni esempi. Sull’influenza che l’arte greca ha avuto su alcuni artisti italiani in modo insospettato, bisognerebbe poter scrivere un libro. Per esempio, su Giorgione. Giorgione ha un capolavoro assoluto che è la Venere Dormiente della Gemäldegalerie di Dresda: si tratta di un nudo femminile, e nella parte inferiore del divano sul quale è coricato c’è un panneggio alto così, e quello lo ha dipinto il giovanissimo Tiziano, che allora era allievo di Giorgione. Quel nudo lì poi lo ha fatto anche Tiziano nella maturità, anzi Tiziano ne ha fatte due o tre di Veneri coricate così, stupende anche quelle, ma non dell’altezza della Venere di Giorgione. Di Giorgione si conoscono in tutto sei o sette quadri sommi, dei quali due o tre dubbi, quindi se ne conoscono pochi. Ma nessuno di essi raggiunge la bellezza della Venereo Come mai? Giorgione risiedeva a Venezia e probabilmente è andato in Grecia. Da Venezia, via mare, si va in Grecia in tre giorni; se il vento è buono, in tre giorni si arriva ad Atene. Secondo me, per fare quella pittura che c’è a Dresda Giorgione è andato prima in Grecia, perché quella pittura lì è uno splendore, si resta esterrefatti a vederla, è perfetta come l’arte greca.
E La Tempesta che c’è alle Gallerie dell’Accademia di Venezia?
No, è indietro, molto indietro, non c’è paragone con la Venere Dormiente di Dresda. La Venere di Giorgione è così diversa da quello che si vedeva prima, da essere considerata il primo capolavoro europeo. È il primo capolavoro assoluto di arte che non sia sacra. Io spero ancora, prima di morire, di andare a Dresda a visitare questa Venere, che finora ho potuto ammirare soltanto attraverso qualche riproduzione a colori. Questa Venere è un capolavoro che potrebbe essere di Raffaello, tanto è perfetta. Se non si pensa che Giorgione si sia recato in Grecia, almeno una volta in vita sua, non si può capire come abbia fatto a dipingere un capolavoro del genere.

Quindi Lei all’occorrenza non disdegna di osservare i capolavori dell’arte servendosi di riproduzioni, di fotografie?
E perché mai dovrei disdegnarlo? Sono contrario allo studio della storia dell’arte fatto con le sole illustrazioni; ma in mancanza d’altro, cosa vuoi fare? Quando avevo una decina di anni, ho fatto una raccolta di cartoline illustrate che mi ero fatte dare dai genitori, dagli zii e dalle zie, e da altri parenti, e quando avevo qualche soldo, magari le compravo. Pensi che quand’ero ragazzo io non avevo mai un soldo in tasca. Fino a diciotto anni non ho quasi mai avuto soldi in tasca. Sì, mio padre aveva anche la possibilità di darmi dei soldi, ma allora non si usava dar la mancia ai ragazzi. Si chiedeva qualche soldo quando si aveva bisogno di qualcosa. Il mio papà mi diceva: “Per i libri, c’è il conto aperto dal libraio, e tu va’ a prendere il libro che ti è necessario”. A me non è mai venuto in mente di comprare un libro che non fosse necessario, che non fosse d’obbligo scolastico. Il mio papà non controllava perché si fidava di me, ma aveva ragione a fidarsi, perché non mi è mai venuto in mente di rubare, né a lui né ad altri. Sono cresciuto in una famiglia nella quale il rubare era un delitto, cosa da delinquenti. L’ingannare era un’altra cosa da delinquenti. Io non ne ho nessun merito, sono cresciuto in questo ambiente di onestà, quindi per me è una cosa naturalissima, più naturale essere così che diversamente. Allora pensi che fino a diciotto anni, non ho mai avuto un soldo in tasca: un soldo, Lei sa cosa vuoi dire un soldo, un cinque centesimi? E mio fratello era lo stesso.
Quali erano allora i vostri divertimenti?
Niente, nessuno. O quasi. Io ho sempre fatto una vita ritirata, di lavoro soprattutto. Mi è sempre piaciuto viaggiare, questo sì: in visita a chiese, a monumenti, a pinacoteche, a musei e a gallerie d’arte dell’Italia e dell’Europa, ma soprattutto dell’Italia che è ricchissima di capolavori d’arte. Poi, quand’ero giovane e avevo del tempo da perdere, mi piaceva andare a vedere le fiere. Mi divertivano molto i giochi e i fenomeni da baraccone. C’erano delle fiere dove si vedevano le pulci ammaestrate, che oggi non si vedono più, per quanto mi risulta.
Oggi le fiere hanno un carattere esclusivamente commerciale.
Invece una volta le fiere erano ricche di attrazioni: ogni venditore si dava da fare come un matto per attirare l’attenzione del pubblico.

Diceva delle pulci ammaestrate.
Le pulci erano ammaestrate a camminare sul braccio dell’ammaestratrice. Questa cavava da una scatoletta le pulci, le attaccava a una leggerissima biga di carta, piccola così, e le pulci si mettevano in moto trascinandosi dietro quella biga. Quando avevano finito il percorso, l’ammaestratrice le lasciava sul suo braccio a rifocillarsi, insomma lasciava che le bevessero il sangue. Le pulci avevano imparato che per rifocillarsi dovevano prima fare quel certo percorso..Con gli animali si fanno un mucchio di esperimenti. A Napoli mi ricordo di aver visto nello studio di un medico, di un neurologo, tanti gatti con le teste piene di spilli: bastava che vedessero un segnale, un certo colore, e subito cambiavano strada, facevano delle cose straordinarie. A me facevano tanta pena, ma il dottore mi diceva che i gatti non soffrivano affatto: io ne dubito. Adesso quel dottore è in America. Come sempre in Italia, quando c’è uno scienziato di valore, va a finire negli Stati Uniti d’America.
Lei ha sempre amato questo aspetto giocoso della vita: le fiere, i mercati, il circo, i baracconi.
Sì, mi ha sempre attirato questo aspetto. Anche i miei amici amavano girare in mezzo alle fiere e ai mercati. Da giovani passavamo delle ore a guardare i vari spettacoli: c’era il mangiafuoco, oppure la donna con tre gambe.
La donna con tre gambe?
Era tutta una finzione, uno scherzo. C’era questa donna con tre gambe invece di due, e tutti noi sapevamo come era in realtà, ma ci divertiva lo scherzo e cominciavamo a dire: “È artificiale!” “No, è naturale!” “Allora fate vedere se è vero che è naturale!” Si pagava sempre di più per vederla spogliarsi. Passava uno, prendeva i soldi, e si arrivava a vedere tutt’e tre le gambe della donna. Con Terragni, fino all’ultimo anno della sua vita, siamo andati sempre alla fiera di Camerlata a comprare le castagne infilate.
Era una specialità particolare
Venivano da Cuneo, a Como si chiamavano “cüni”, in piemontese si chiamavano anche “marunit” e sono a forma di ghirlanda.
Come le facevano?
Prima le tenevano a bagno nel vino e poi, quando erano ben impregnate, le mettevano nel forno ad asciugare. Erano molto buone da mangiare. Si mangiavano di più in febbraio per la festa della Candelora. Chissà se le fanno ancora. Un’altra attrazione era quella del cavadenti: era un’attrazione quasi obbligatoria, in ogni fiera ce n’era uno. Lavoravano in due: il cavadenti vero, con tutte le pinze necessarie, e un altro che intratteneva i clienti e suonava il tamburo all’atto dello strappo. Naturalmente c’era un disco che serviva per attirare i clienti, una musica o una canzone in voga. Quando si formava un cerchio di due, tre file di persone, allora incominciava lo spettacolo: “Avanti, chi vuol cavarsi un dente?” Veniva avanti un uomo, poi una donna, e così via. Bisognava pagare prima, naturalmente. Il cavadenti infilava la pinza nella bocca del paziente: “Ahi!” “È inutile dire ahi!” Nell’attimo in cui il paziente avrebbe strillato, ecco un rullo di tamburo. Poi il cavadenti: “Ecco il suo dente, lo vuole?”, e lo dava per ricordo al proprietario.
Erano bravi quei cavadenti?
Bravissimi.
E quanto costavano?
Ah non ricordo, ma meno dei dentisti di oggi, certamente.
Capitava che togliessero qualche dente buono al posto di uno malandato?
Poteva capitare, certamente. Allora erano litigi seri. Ma quello che incantava lì, nel veder lavorare quei cavadenti, era la rapidità di esecuzione: erano davvero eccezionali. Conoscevano il calendario delle fiere e dei mercati e facevano il giro della Lombardia, un giorno qua, l’altro là.
Poco fa parlavamo delle riproduzioni fotografiche. In generale Lei che cosa pensa dell’arte fotografica? La ritiene in concorrenza con la pittura?
No, assolutamente no. Sono due cose molto diverse. Ho avuto uno zio, Lucio Vitali, fratello della mia mamma, che si occupava di fotografia in modo scientifico, approfondito. Insomma non era il solito dilettante. Da lui ho imparato parecchio. Lo zio emulsionava e rendeva sensibile la carta per la stampa in base alle sue ricerche in questo settore. Era andato a Parigi e aveva conosciuto i fratelli Lumière. Una o due volte all’anno, ritornava da loro per rimanere al corrente di tutti i progressi in campo fotografico.
Lei possiede qualche foto eseguita dallo zio Lucio?
No, non me ne sono rimaste. Ce n’era una fatta da lui alla mia mamma e che era stata poi riprodotta su seta. Però di quell’epoca ho una fotografia eccezionale, fatta da un allievo di mio zio, che poi ha impiantato uno studio fotografico. Era un fotografo straordinario anche lui, si chiamava Piatti, ed ha fotografato la mia mamma, mio fratello maggiore e me, tutt’e tre insieme. Comunque, Le ripeto, anch’io ho imparato molto da questo zio. Per esempio mi raccomandava: “Quando lavi le negative o anche le copie, lasciale tutta la notte in un recipiente con un filo d’acqua corrente, in modo che si possa ricambiare”. Adesso invece lasciano la foto dieci, quindici minuti in acqua, ed è fatta: col risultato che, dopo cinque, sei anni, quella foto non esiste più, è volata via. Quella foto del Piatti è stata fatta quando io avevo tre anni, dunque ottantaquattro anni fa, ed ancora è li, bella e intatta.
La città di Como nella sua vita. Ecco, qual è il suo pensiero da questo punto di vista? Che cosa ha dato a Como e che cosa ne ha avuto?
È difficile per me rispondere a questa domanda, direi impossibile, pur essendo nato e cresciuto e pur avendo vissuto praticamente tutta la vita a Como. Como è una città come tutte le altre della Lombardia. L’unica cosa importante è che Como ha una storia autonoma benché sia lontana in linea d’aria da Milano soltanto quaranta chilometri, e secondo le strade circa cinquanta. Ma questa distanza oggi non ha nessuna importanza, mentre fino a un secolo fa aveva un’importanza enorme perché per andare da Como a Milano occorrevano parecchie ore, all’incirca era come andare adesso a New York in aereo, capisce? L’importanza di Como è storica dal punto di vista dell’arte, perché è stata il centro dei cosiddetti Maestri Comacini. Non che i Maestri Comacini fossero tutti di Como – di Como ce n’erano due su cento, tanto per dire-: erano del lago di Como, di Lugano, di Varese, di Lecco, di Campione, di Monza, di Milano, ed erano tutti architetti. Non che avessero studiato architettura, ma erano qualcosa di più dei capimuratori, perché i capimuratori non sapevano disegnare, mentre loro disegnavano meravigliosamente. Erano quello che oggi sono gli architetti. Hanno determinato uno stile che ha avuto fortuna, lo stile romanico che è nato da queste parti, non si sa dove, dicono forse nella Valle d’Intelvi o nel Canton Ticino. E l’arte romanica è nata prima del Mille, era già viva nel VII e nell’VIII secolo dopo Cristo. I Maestri Comacini vengono menzionati già nell’Editto di Rotari, e avevano l’esclusiva nella fabbricazione delle chiese. Quando si doveva costruire una chiesa in un paese lontano anche centinaia di chilometri, bisognava rivolgersi a loro. Con tutto ciò, Como non esiste nella storia dell’arte, perché è invalsa la tradizione dell’arte toscana, per cui l’arte italiana comincia con Cimabue o con Giotto. La maggior parte degli autori di storia dell’arte sono filotoscani e per loro Como non esiste nemmeno. Ignorano completamente l’arte degli anni intorno al Mille o dei secoli precedenti. Prima di Cimabue o di Giotto, per loro non c’è niente, insomma, oppure ha poca rilevanza. Invece anche prima c’erano dei capolavori di architettura e di scultura.
E per Lei che cosa ha significato Como in rapporto alla sua opera?
Architettonicamente parlando ci sono dei capolavori dell’arte romanica: le chiese di S. Abbondio, S. Fedele, S. Carpoforo, S. Agostino anche se è un po’ rovinata. Certo hanno influito su di me: ci sono cresciuto dentro! È un fatto naturale tutto questo.
L’arte, il paesaggio, l’ambiente.
Hanno influito enormemente.
Lei ama questa città?
Beh! la amo come tutti amano la città in cui hanno passato gran parte della vita.
Molti amano la propria città, altri invece la odiano.
Mah! Io non amo particolarmente Como, ci sono altre città lombarde o venete o toscane, ad esempio, che…
Quali?
Quando sono andato per la prima volta a San Gimignano sono rimasto con la bocca aperta, e non la dimenticherò nemmeno se campassi mille anni: ce l’ho sempre davanti agli occhi. Ecco, l’Italia è piena di capolavori, è un museo, è il museo più grande d’Europa, solo che purtroppo siamo nelle mani di politici che, in campo artistico, sono degli incompetenti. Sono degli estranei all’arte, estranei completamente. Sono sordi e muti nei confronti di tutte le arti, salvo qualche rara eccezione; ma io non ne conosco nessuna, di queste eccezioni..Pensi un po’ a quanti furti di opere d’arte, a quanti atti di vandalismo e a quanta noncuranza nei confronti dell’arte!
E Milano, che cosa ha significato per Lei, soprattutto negli anni più decisivi per la sua arte?
Cosa vuole che Le dica? Milano è al centro dell’Italia settentrionale, della pianura padana. Essendo al centro della pianura padana, è al centro di una regione che appartiene all’Europa centrale, e non all’Europa del Sud. La mentalità di tutta l’Italia settentrionale, compresa la Toscana, è tutta più legata all’Europa non del Nord come la Scandinavia, ma all’Europa centrale. L’Italia del Sud è diversa. Sarà meglio o peggio, non so.
Lei non intende esprimere un giudizio di valore sull’Italia del Sud?
No, constato soltanto questa differenza. In tante cose le differenze sono migliori, in altre peggiori. Al Nord sembra che si lavori di più.
Tornando a Milano.
Dal punto di vista artistico, siccome è l’unico mercato italiano veramente libero, come è quello di Parigi o di Londra, Milano è un centro importantissimo. Ogni nazione ha il suo centro, l’Italia ha Milano.
E Roma, e Venezia, e Firenze?
Sono centri importanti anche per il mercato artistico, ma Milano è al primo posto.
Che cosa intende Lei per mercato libero?
È in mano ai mercanti privati, non è in mano agli enti pubblici.
Oltre all’utilità mercantile, quale altra utilità presentano le gallerie private?
Salvo qualche rara eccezione, nessuna utilità: nelle gallerie non s’impara niente.
Eppure quando Lei frequentava la Galleria del Milione, negli anni Trenta…
I proprietari erano i Ghiringhelli, ed erano miei amici. Però io frequentavo solo Gino Ghiringhelli, gli altri fratelli non si facevano vedere quasi mai: uno era ufficiale della milizia e perciò m’interessava zero, l’altro era l’aiuto del fratello Gino.

Quindi bisogna ridimensionare alquanto questo mito che si viene a creare, in genere, riguardo agli artisti che si frequentano assiduamente presso una galleria: l’incontrarsi, il discutere, è tutto relativo.
In genere sì, è così. Ma negli anni che mi riguardano, in quegli anni dal ’32 al ’33, al ’34, io ci andavo sovente, e – come Le ho detto – parlavo più spesso con Reggiani. Reggiani e Attanasio Soldati hanno incominciato insieme l’astrattismo. Reggiani e Soldati erano nemici fra loro, non so perché, non l’ho mai saputo, forse perché avevano un carattere forte entrambi. Ecco, Reggiani s’era tirato appresso Ghiringhelli e Bogliardi, i quali però, dopo un anno, hanno smesso di dipingere, non di dipingere quadri astratti, ma di dipingere completamente.
Come mai?
In quegli anni la Galleria del Milione era la più avanzata, la più spericolata. Faceva mostre delle quali non vendeva un quadro. E come poteva reggere se Ghiringhelli, che era pittore, e per giunta astrattista, non avesse avuto dietro di sé il padre? Il padre era un imbianchino arricchito, aveva allora settantacinque anni, possedeva una casa a Milano e permetteva che il figlio gli consumasse il patrimonio. Ma ad un certo punto ha detto: “Basta!”, perché non voleva andare a finire i suoi giorni alla Baggina. Sa Lei cos’è la Baggina?
Il Pio Albergo Trivulzio di Milano, una casa di ricovero per anziani.
Precisamente. È la casa di ricovero dei vecchi in miseria, esiste ancora. Anche Fontana diceva spesso: “Se continua così, finirò alla Baggina”, perché non riusciva a vendere un chiodo neppure lui. Fatto sta che Ghiringhelli a un certo punto ha smesso di dipingere per dedicarsi completamente alla Galleria. Era un brav’uomo, pieno di entusiasmo. Peccato, è morto giovane.
Chi eravate a vedervi più spesso al Milione?
Mi vedevo più spesso con Ghiringhelli, Bogliardi, Reggiani – come ho detto -, che era un po’ il capo, e poi con Fontana, Soldati, Licini, Veronesi e Melotti. Ma Melotti era trentino, e perciò veniva di rado a Milano.
Che rapporti c’erano fra di voi?
Di amicizia. Soprattutto con Fontana. La differenza tra Fontana e tutti gli altri suoi coetanei, più o meno colleghi di alta classe, era che Fontana io non l’ho sentito mai parlare male di nessuno, mentre tutti gli altri vivevano parlando male dei propri colleghi. Aveva un carattere dolcissimo, era molto generoso, era superiore a qualsiasi ostilità o gelosia di colleghi, insomma.
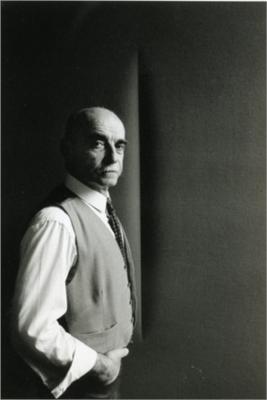
Lei ama il lavoro artistico di Fontana?
Non ho niente da dire sullo spazialismo. Dico solo che se Fontana non avesse fatto come ha fatto, non sarebbe Fontana, capisce? Fontana ha capito che la strada normale per farsi avanti non avrebbe dato nessun risultato pratico. Fontana era un uomo che commetteva sovente stranezze per motivi pubblicitari, con i quali sopravviveva.
Lei sarebbe stato capace di fare un gesto, diciamo pure “pubblicitario”, come Fontana?
No, sono negato assolutamente! Però Fontana ha fatto bene a fare quello che ha fatto, perché ha favorito tutti i suoi colleghi.
In che senso?
Nel senso che ha fatto superare l’ostilità contro l’astrattismo. Se non ci fosse stato Fontana, sarebbe rimasto ancora oggi il muro di silenzio che c’era prima in Italia sull’arte astratta.
Quindi Lei non attribuisce nessun valore artistico ai “buchi” e ai “tagli” di Fontana?
Un valore pubblicitario o propagandistico, e basta.
Neanche come “intenzione” artistica?
Niente, niente. Difatti lo capiscono tutti, no? Però Fontana è stato un artista autentico, non è che facesse solo “buchi” e “tagli”. Faceva anche delle opere importanti, per esempio il progetto per una porta del Duomo di Milano. Aveva partecipato al concorso e lo aveva vinto. Aveva proposto delle sculture molto belle: avevano qualcosa di… Non che fossero barocche, però erano a metà fra il Rinascimento e il Barocco, ed erano molto vivaci e ben fatte. Poi gli hanno preferito il progetto di un altro scultore, non ricordo più chi.
Luciano Minguzzi.
Sì, Minguzzi. Intendiamoci non è che Minguzzi non sia bravo, però non è Fontana, ecco. Forse non erano capolavori nemmeno quelli di Fontana, ma io avrei preferito le sculture di Fontana a quelle di Minguzzi.
Come mai a Fontana è stato preferito Minguzzi?
Perché si chiamava Fontana. Lei sa come si formano le commissioni che devono giudicare un concorso artistico? Si tratta quasi sempre di persone incompetenti, ed è quindi un miracolo che non facciano uno sbaglio dietro l’altro, soprattutto quando si tratta di arte sacra. Le commissioni diocesane sono composte da preti che raramente capiscono qualcosa di arte moderna.
Vorrebbe approfondire questo discorso sull’arte sacra e sulle sue committenze?
Ci sarebbe da parlare per ore. Insomma l’arte sacra è nelle mani di committenti che sono dei preti. Chi più dovrebbe occuparsi di queste cose, ha meno competenza degli altri. Per cui tutto è nelle mani di gente senza alcuna preparazione particolare. I preti si occupano in modo specifico di religione, non di arte, neanche se si tratta di arte sacra. Guardi un po’ gli scempi e le trascuratezze che s’incontrano nella maggior parte delle chiese, in fatto di arte sacra. Vi domina quasi sempre il cattivo gusto. Il motivo è presto detto. Adesso i preti, per la maggior parte, sono figli di contadini. Non è un disonore essere figli di contadini. E quindi, giù il cappello! Però a tavola, nei rapporti con i genitori e gli altri parenti, hanno sempre parlato solo di campagna, di frumento, il tal rendimento, il tal seme, ecc.; non hanno mai sentito parlare di arte. Quando, finiti gli studi di teologia, hanno una parrocchia e devono ordinare, per esempio, un affresco su una certa parete della chiesa, perché c’è un tale ricco che offre l’affresco per farsi dei meriti, allora chi scelgono? Scelgono sempre i peggiori artisti sulla piazza, mestieranti analfabeti che non sanno niente di arte, tanto meno di arte sacra.
Ma non ci sono delle commissioni diocesane?
Si, ma sono composte dagli stessi preti, figli di contadini. Neppure il vescovo è competente. E sa perché? Perché ha mille altre cose a cui pensare, e non si può dedicare certo all’arte moderna. Tale e quale come gli uomini politici, che hanno ben altro a cui pensare. Non hanno tempo per l’arte.
Ma è sempre stato così? L’Italia è piena di chiese bellissime e ricchissime di opere d’arte.
Quello che Le ho detto succede da un secolo a questa parte. Prima non era così. Nei secoli passati i preti che commissionavano la costruzione delle chiese e l’esecuzione delle opere d’arte, erano in buona misura figli di nobili, e occupavano le cariche ecclesiastiche più importanti, mentre gli altri preti figli di contadini venivano mandati nelle campagne più sperdute. I figli dei nobili o dei benestanti erano cresciuti in ben altri ambienti, dove già le opere d’arte venivano commissionate continuamente. Quindi è chiaro che quando poi dovevano commissionare loro delle opere d’arte sacra, le cose andavano di gran lunga meglio. L’ambiente influisce moltissimo. Naturalmente ci si può specializzare anche provenendo da un ambiente modesto. Io sono figlio di un ambiente modesto, modestissimo, ma ricco di una certa cultura.
Ma i preti, per diventare tali devono fare degli studi generali in cui c’è anche la cultura artistica.
Sì, ma nei seminari si studia l’arte come in tutti i licei italiani, cioè non si studia arte ma storia d’arte nei modi e con i limiti che Le ho già detto. L’arte si studia nei musei, nelle pinacoteche.
Lei ha avuto delle committenze di arte sacra?
Sì, io ho eseguito quattro o cinque affreschi, in tutta la mia vita, per delle chiese. Ma non hanno nessuna importanza. La mia pittura non conta niente.
Però siccome parliamo del suo lavoro mi sembra giusto riferire anche queste esperienze, no?
Ho realizzato degli affreschi nella chiesa parrocchiale di Carbonate e poi qui, a Como, nella chiesa di S. Vitale, che si trova in fondo a viale Lecco, là dove comincia la strada che sale a Brunate.
Via Tommaso Grossi.
Li c’è un affresco che raffigura S. Antonio e S. Rita. Nella stessa via Tommaso Grossi c’è un pensionato femminile per persone anziane dove ho affrescato il soffitto della chiesa.
E il suo passare dall’arte astratta all’arte religiosa che ha sempre qualcosa di figurativo, come lo spiega?
Non spiego niente io! Non devo spiegare niente! Intanto anche l’arte astratta ha qualche cosa di figurativo, perchè istintivamente io stesso, come tutte le persone che guardano un quadro, sono portato a intravedere delle forme figurative anche nelle forme più strane. Quindi in qualsiasi pittura in cui si può trovare, per esempio, un cerchio, ecco, quello lì è un occhio, perchè la pupilla è quasi sferica. Si fa un rettangolo accanto ad un altro rettangolo, e quello lì è un braccio del rettangolo principale. Ecco, questo non ha nessuna importanza.

Progetto di Ico Parisi con Gian Paolo Allevi. Mosaici di Mario Radice.
Ma Lei quando dipinge un quadro astratto assume un atteggiamento mentale diverso da quando prepara un bozzetto per un affresco figurativo?
Neanche per sogno. L’atteggiamento è quasi sempre identico. Non c’è nessuna differenza perchè in quel momento penso solo alla composizione e all’armonia delle forme, e poi all’armonia dei colori.
Ecco, Lei dice: non devo spiegare la mia scelta figurativa in luogo dell’astratta, quando mi accade di farla. Però, com’è che è stato prevalente in Lei il discorso astratto rispetto al figurativo?
Quadri astratti ne ho fatti il triplo rispetto ai figurativi. Come mai? È semplicissimo: perchè la pittura figurativa con il realismo e l’impressionismo del secolo scorso e dei primi del nostro secolo era arrivata ad un livello così basso che non era più accettabile. E quindi c’è stata questa ribellione contro il realismo e l’impressionismo. Allora il merito di un artista consisteva nel riprodurre tale e quale ciò che vedeva. Ma questa abilità di tradurre sulla tela ciò che uno vede o le impressioni che prova davanti a ciò che vede, alla lunga non modifica niente. Intendiamoci, l’artista vero deve partire sempre dal reale, però non può fermarsi al reale, e non può fermarsi alle impressioni che il reale gli procura. Tutto quello che vediamo intorno a noi, paesaggi, figure, corpo umano, corpo di qualunque animale, è stato fatto da Dio in maniera armonica, capisce? È sulle proporzioni armoniche della natura che conviene lavorare.
È questo che L’ha spinto a privilegiare la scelta astrattista?
Spiego subito perché mi ha entusiasmato l’astrattismo. Studiando veramente a fondo la storia d’arte, non sui libri ma nei musei e nelle pinacoteche, come ho detto, copiando ora un panneggio ora una mano ora un viso dai più grandi pittori, ho potuto constatare come la pittura, da che mondo è mondo, è stata sempre la stessa, ed è fondata sulla proporzione armonica delle varie forme. Facendo quadri astratti ho potuto approfondire gli elementi compositivi, ho capito che cos’è la composizione così come la sapevano fare nel Trecento o nel Quattrocento.
Vuol dire che la pittura astratta è stata un semplice strumento per capire meglio la pittura tradizionale, classica?
Non solo per capirla meglio, ma anche per ricrearla. Io dico queste cose sapendo di essere nato e cresciuto in Italia, per mia fortuna, perché fuori d’Italia queste cose sono ritenute, con un termine terribile, superate. Come se non ci fossero al mondo cose insuperabili. Le proporzioni armoniche del corpo umano, visto secondo un certo criterio di rigore, sono insuperabili, c’è poco da fare. Di solito le usano anche i pittori figurativi, ma si tratta di un fatto istintivo, privo di un vero e proprio approfondimento.
Ma Lei non si è dedicato solo all’astratto, ha continuato a fare anche il figurativo
Diciamo che il quadro astratto non è mai stato da me eseguito su commissione, mentre il figurativo si, solo su commissione. Se veniva qualcuno a chiedermi una Crocifissione, una Madonna, un ritratto, perché non avrei dovuto farli, visto che sono in grado di farli?
Ma come spiega, in ogni caso, questa doppia valenza nella sua arte?
Insomma (e purtroppo è una cosa triste doverlo dire) io credo di essere l’unico in Italia, e forse in Europa, e forse nel mondo – mi scusi, non è per superbia che dico questo, lo dico proprio con rincrescimento – a sostenere che la pittura astratta è identica a quella figurativa: è una natura morta e basta. Non mi stancherò di ripeterlo: in pittura il tema non ha mai avuto e non avrà mai importanza. È il modo in cui si dipinge che è importante. Le boccette di Morandi, i paesaggi o le marine di Carrà, le periferie delle grandi città di Sironi e le varie differenziazioni sia nella figura che nel paesaggio di De Chirico – e parlo dei quattro più grandi artisti di questo secolo – in sé e per sé non hanno nessuna importanza. È la loro bellezza compositiva che è importante insieme con l’armonia cromatica. Io non ho mai abbandonato il ritratto, non ho mai abbandonato l’arte sacra, ho sempre fatto l’arte figurativa, faccio anche l’arte astratta. Non posso esporre l’arte figurativa insieme all’arte astratta perché altrimenti tutti direbbero che io sono in malafede. Cosa devo fare? Qualche volta la espongo e ne sento di tutti i colori. Ma sostengo sempre che la pittura è una sola, e tra dieci anni tutti lo diranno, non solo io, lo diranno tutti che la pittura è una sola e, grazie al Cielo, l’arte astratta non sarà considerata più una stranezza. Dico “grazie al Cielo” perché questa benedetta arte astratta è considerata come un ismo qualunque, mentre c’è sempre stata, salvo che in questo secolo è diventata arte a pieno titolo. A me non importa nulla degli ismi contemporanei. Siamo sommersi dagli ismi, non si riesce ad andare avanti se non etichettando e raggruppando e intruppando. In arte c’è una confusione di lingue incredibile, mai esistita prima del nostro secolo. La pittura figurativa e la pittura astratta ci saranno sempre, secondo me, sopravviveranno sempre. Adesso in Italia siamo, non so, un paio di centinaia di pittori a fare l’astratto: ne resteranno magari solo tre di noi, ma resteranno, e questo è quello che importa. Il nome importa poco, sono le opere che importano, la gioia e la consolazione che possono dare a chi le guarda. Voglio farLe vedere un lavoro. Ecco, vede quel disegno che ho sul cavalletto? È un disegno che ho fatto dieci, dodici anni fa: è un figurativo ed era destinato a uno degli studi che ho fatto per un affresco in una chiesa, e che ho poi realizzato, qui, in provincia di Como. Siccome il disegno non era ancora finito, l’ho ripreso e ritoccato oggi, domani forse potrò finirlo.
Quindi oggi ha lavorato?
Sì, qualcosa faccio tutti i giorni. Però dipingo pochissimo perché mi stanco presto, faccio la quarta parte di quanto riuscivo a fare trenta o venti anni fa. Non posso far di più perché tutto è calato in me in quell’ora o in quelle due ore al giorno che dedico alla pittura. Adesso, con tutta l’esperienza che ho, risparmio tempo, naturalmente.

Come nasce un’opera d’arte?
L’opera d’arte nasce mentre l’autore è inconsapevole di quello che fa. L’autore tenta di far bene, ma non sa dove va a finire, non sa proprio come andrà a finire questa benedetta opera che ha in testa, che disegna. Fa un disegno, poi un altro, poi li confronta tra loro, poi ne ingrandisce uno, lo migliora. Poi a un certo punto lo dichiara finito. Ma è un mistero, per lui, questo procedere, perché non sa mai come andrà a finire.
La pittura astratta, o meglio non figurativa, ha registrato nel suo lavoro artistico delle fasi, dei periodi particolari? Il discorso potrebbe partire dal momento in cui Lei preparava i bozzetti per le pitture e i pannelli della Casa del Fascio
Si, ci sono state delle fasi.
Vogliamo ripercorrerle
Nei primi disegni astratti prevale l’angolo retto: a partire dal ’33.
E questa fase quant’è durata
Non ci sono periodi delimitati. Anche nelle fasi successive non è che venga abolito l’angolo retto. Non bisogna mai scambiare l’arte con la scienza. Ripeto: solo la scienza è condannata a progredire. Dopo gli angoli retti sono venuti gli altri angoli, non retti. Poi sono venute le curve: sono stato il primo, forse nel mondo, a usare le curve nel disegno astratto. Sono stato uno dei primi a riferirmi a delle costruzioni complesse e apparentemente assurde: che poi sono diventate tutt’a un tratto le migliori, forse, che io abbia fatto. Io ho cercato di comporre in tutti i modi possibili e immaginabili, cioè di trovare delle forme armoniose fra loro, tutte quante istintive.
Lei è solito contrassegnare le sue composizioni con delle sigle. Questa dicitura ad esempio: “Struttura piramidale R.S. e dinamica dei crolli” che cosa vuol dire?
“R.S.” vuol dire “Ritratto Segreto”. Il “Ritratto Segreto” nasce così: alla Biennale di Venezia, come le ho raccontato, ho esposto due volte con i futuristi, perché come astrattista venivo completamente ignorato da qualsiasi giuria. Invece Marinetti, noi astrattisti, ci accoglieva: il primo anno ero da solo; il secondo anno, nella Biennale successiva, ho detto a Marinetti di invitare anche Manlio Rho; poi un’altra volta Marinetti ha invitato degli altri, adesso non ricordo più chi. Poi sono passato agli inviti regolari, fatti cioè dal presidente della commissione, e finalmente sono diventato uno di quelli che promuovevano l’invito, perché ho fatto parte della commissione inviti. Così è successo anche alla Triennale di Milano, dove sono entrato come espositore e ho finito col diventare uno dei membri del consiglio d’amministrazione. Alla Triennale di Milano negli anni successivi ho fatto parte per tre anni della commissione esecutiva e per altri tre anni del consiglio d’amministrazione.
Fermiamoci per un momento anche su questa esperienza. Ricorda qualcosa di particolarmente interessante?
Qualche amicizia, in particolare. Per esempio, quella con Eugenio Montale, considerato uno dei massimi poeti italiani di questo secolo, che allora faceva parte anche lui del consiglio d’amministrazione della Triennale. Stavamo delle ore, tre pomeriggi alla settimana, a parlare tra di noi, fitto fitto, di arte e di letteratura, mentre gli altri consiglieri discutevano su quali artisti invitare. Una volta ho domandato a Montale: “Chi è il massimo poeta del secolo passato?”, e lui mi ha risposto: “Leopardi è il primo; il secondo è Carlo Porta”. “Ma Carlo Porta ha scritto in dialetto milanese!” ho replicato io. E Montale: “Non esistono dialetti, ogni dialetto è una lingua vera e propria!” Ho imparato così qualcosa anche da Montale.

Per le poesie di Montale Lei ha eseguito dei disegni, mi pare.
Sì, ho eseguito dei disegni per alcune incisioni a secco e per alcune serigrafie: rispettivamente, una cartella con tre poesie inedite e un volume a stampa con poesie nell’originale italiano e nella traduzione in francese. L’editrice delle incisioni è stata la Galleria Corsini di Intra, sul lago Maggiore, mentre il libro è stato stampato dalla Nuova Foglio di Pollenza, in provincia di Macerata. Ma ho preparato anche altri lavori del genere. Per esempio, per La Pergola di Macerata ho eseguito delle litografie che illustravano le poesie del poeta siciliano Vann’Antò.
Dicevamo, dunque, della sigla “R.S.””.
La sigla è stata inventata da Marinetti durante una Biennale di Venezia inaugurata come sempre dal re. Mentre il re passava a visitare le varie sale, giunse nella sezione curata da Marinetti. Davanti a un mio quadro che era piuttosto grande, il re si fermò a domandare: “Cosa rappresenta quel quadro lì?” Io avevo avuto da fare col re in altre occasioni, durante altre mostre; forse anche lui si ricordava di me. Il re era di statura molto bassa, mentre io ero alto un metro e ottanta centimetri. Ho capito che dovevo rispondere alla sua domanda, di cui non avevo afferrato bene il senso, e mi sono chinato per sentirlo un po’ meglio. Nel frattempo ha risposto Marinetti per conto mio: “È un ritratto segreto!”. Marinetti, non sapendo cosa dire, se l’è cavata così: lui aveva sempre la parola pronta, era fatto in questo modo.
Quindi questa sigla è rimasta per molti quadri analoghi?
Sì, per molti quadri che hanno una struttura simile.
E “Crolli”, “Dinamica dei crolli”?
Quando sono tornato dalla guerra, ero molto impressionato da quello che avevo visto, e a un certo punto ho cominciato anche a dipingere quelle impressioni: ho fatto pochi “Crolli”, tutte “cose” che crollavano addosso a degli uomini piccoli, che venivano schiacciati. Ne ho fatti in tutto tre o quattro.
“C.F.” vuoi dire “Casa del Fascio, suppongo.
Precisamente, e si riferisce ai disegni dei bozzetti eseguiti per la Casa del Fascio di Terragni.

Ce ne sono tante altre, di sigle: per esempio, “A.N.”, “B.L.”. Sono delle sigle segrete?
Le metto, poi rimangono lì. Ma non sono segrete, spesso non mi ricordo più nemmeno io il loro significato. Servono solo per distinguere un quadro dall’altro. La sigla è come un numero.
Allora, ripercorrendo le varie fasi, prima sono venuti gli angoli retti, poi gli incastri ortogonali, poi la curva e lo sviluppo della curva, poi la composizione piramidale dei “Ritratti Segreti”, poi la “Progressione”. Questo per quanto riguarda il fatto compositivo. Per il colore invece?
Lungo gli anni ho dato anche sempre maggiore importanza al colore. Nei quadri degli ultimi anni il colore ha una chiarezza maggiore. Qualunque pittura da che mondo è mondo, anzi a cominciare dalla pittura delle Grotte di Altamira, è fatta di una composizione formale che può essere dipinta anche con un colore solo, e la stessa composizione formale può essere fatta con due, tre, dieci, cinquanta colori che giocano fra loro, non per allegria ma perché viene in mente così l’opera a poco a poco. L’opera non nasce di colpo come nascevano i quadri impressionisti, fatti così: paesaggio ore 14, 16, 17, vento di Nord-Ovest, 13 marzo 1845. Gli impressionisti facevano la “fotografia” del tempo con la direzione del vento. Che importanza ha? A questo punto erano arrivati quei pazzi degli impressionisti! Forse aveva ragione De Chirico quando diceva che il periodo impressionista – che è francese, non italiano – è il periodo peggiore di duemila anni di pittura. Gli impressionisti erano arrivati a questo punto: voler “fotografare” con la pittura. Dico questo non per disprezzo verso la fotografia, ma perché la pittura non era mai stata così. La pittura non dev’essere un’interpretazione fotografica della realtà, ma un “canto”. Io non so adoperare nessun’altra parola che questa: un “canto”, e basta.
“Canto” per Lei è una parolachiave.
Il “canto” che può rivelarsi con qualsiasi linguaggio – musicale, pittorico, poetico. – è il mezzo con cui l’artista esprime la sua arte. Quando uno vuoi esprimere la pienezza del suo animo che cosa fa? Canta!
In quali ore della giornata preferisce lavorare? Di mattina, al pomeriggio, di notte?
Non lo so. Qualunque ora va bene. Il mio studio è illuminato in modo da poterci lavorare a qualunque ora del giorno o della notte, con la stessa luce.
Lei non apre mai le finestre? Non fa entrare la luce naturale? Preferisce lavorare con la luce artificiale?
No, no, adopero anche la luce del sole. Ma il sistema di illuminazione che c’è nello studio ricrea la luce solare, tale e quale.
Se guardiamo questo suo quadro, per esempio, vediamo che si tratta, si, di figurativo, ma è un figurativo molto ordinato, molto composto, quasi schematico. Voglio dire che il passaggio dalla composizione astratta a quella figurativa è percettibile ma non dissonante, cioè si avverte sempre la stessa mano.
Ma non direi schematico. In confronto ai quadri figurativi precedenti l’astrattismo, avrà forse più ordine. L’unica cosa, forse, è che assomiglia sempre di più alla pittura del Trecento o del Quattrocento, cioè ha lo stesso rigore compositivo. È una pittura così: potrei chiamarla post-astratta.
Come è arrivato a questo tipo di composizione?
Per uno che impara a comporre, una volta che ha imparato la composizione, diventa istintivo far delle cose più ordinate.
Però continua a comporre, anche quando fa il figurativo, seguendo le regole dell’astrattismo.
Per carità, lasci stare le regole. Lei quando scrive una lettera o una poesia pensa alla grammatica e alla sintassi?
Certamente no.
E allora? Così faccio io. Cosa ne so? lo ho approfondito la composizione, adesso ho dimenticato tutto, non so più niente. Disegno e basta.
Insomma, si lascia guidare dal suo istinto.
Certo.
Un istinto, però, già educato, affinato…
Modificata al meglio la nostra capacità di autocritica, non possiamo che migliorare anche il nostro lavoro.
Ogni momento di rottura con una certa tradizione viene assimilato all’avanguardia. La nascita dell’astrattismo è stato un fatto d’avanguardia o no?
Io non credo agli ismi, quindi neanche all’astrattismo se questo viene considerato come un ismo in mezzo ad altre centinaia di ismi consimili. E poi che vuol dire astrattismo? Che vuol dire arte astratta? Astratto si oppone a concreto, e non c’è niente di più concreto di un quadro cosiddetto astratto. Poi la stessa parola “avanguardia” è sbagliata, perché quella parola lì è di carattere militare, e con l’arte non c’entra nulla. L’artista – il poeta, il musicista, il pittore, lo scultore, l’architetto – non è in guerra, non pensa a combattere contro il prossimo, non fa male a nessuno. Se una poesia, un brano musicale, un quadro, una statua, un edificio produce del male, o induce al male, non è arte, è anti-arte.
Ma se vogliamo attribuire alla parola “avanguardia” non tanto un significato militare quanto un significato esplorativo, fuor di metafora: un significato linguistico (un gruppo che va più avanti degli altri e si spinge non tanto nel campo del nemico quanto in un territorio linguistico sconosciuto per scoprire qualcosa di nuovo, di mai visto prima), le cose cambiano, no?
Se permette, rispondo così: qualunque opera d’arte è una novità, altrimenti non è arte. Però quest’opera d’arte nasce contro la volontà dell’autore: nasce non si sa perché. Voglio insistere sul concetto dell’arte come “canto” che consola. Se un autore si prepara spiritualmente e anche tecnicamente, quando scrive, compone, dipinge, modella o disegna, che cosa fa? “Canta!” “Canta”, e basta! E a cosa serve questo “canto”? Unicamente a consolare qualcuno. Altrimenti è sbagliato chiamare arte tutto questo.

Ma quando Lei ha iniziato a fare dell’arte astratta e perciò ha deciso di abbandonare il figurativo così come lo aveva fatto fino a quel momento (salvo poi a rifarlo in tutt’altra maniera, cioè in una maniera post-astrattista, come ha già detto Lei stesso), non era quella una presa di posizione tipicamente d’avanguardia? Non cercava di esplorare un terreno praticamente sconosciuto?
Non era esplorazione del nuovo, perché – come Le ho detto – l’arte astratta c’è sempre stata, ed io sapevo che c’era sempre stata.
Ma l’arte astratta delle decorazioni abbiamo detto che era un fatto artigianale più che artistico, ripetitivo e puramente ornamentale.
L’astrattismo è stato il passaggio da qualcosa di artigianale a qualcosa di artistico, con tutte le conseguenze che questo passaggio ha comportato: tutto lì. Ma una novità nell’astrattismo c’è davvero.
Quale?
L’aver dato importanza ai rapporti non misurabili con i numeri razionali, rapporti misteriosi e che interessano il mondo vegetale, animale e umano. È – ripeto -la “divina proporzione” di Piero della Francesca e di Luca Pacioli, la sezione aurea dei matematici.
Vuol dire che l’arte astratta è venuta quando si è cominciato a ragionare su questi rapporti dimensionali?
Intendiamoci: questi rapporti misteriosissimi erano senz’altro conosciuti anche prima della loro messa in evidenza, pensi all’arte greca del periodo aureo. Ma è stata una grande conquista dell’intelligenza umana l’aver capito che nella natura vivente esistono questi rapporti. Come si fa a dimostrare, per esempio, che un uomo è bello e un altro è brutto nelle proporzioni? Una persona curiosa misura i vari rapporti e trova sempre lo stesso numero: è questa la cosa straordinaria, cioè che non c’è niente di sproporzionato in un corpo umano normale. Cosa abbiamo fatto noi astrattisti, quei due o tre che ci siamo occupati a fondo di questo problema? Ci siamo resi conto dell’enorme importanza che hanno i rapporti dimensionali anche nella composizione artistica. Intanto queste proporzioni non si studiano per scoprire il bello. Noi riteniamo belle alcune cose, poi le misuriamo e salta fuori questo benedetto numero costante, la sezione aurea. Uno non si mette lì con questo numero e fa delle cose belle, no: fa delle cose belle e poi salta fuori il numero, dopo averle misurate.
Vuol dire che tutto questo è innato? Che ogni artista lavora così inconsciamente, istintivamente?
Ah certo!
Ma c’è anche un’estetica del brutto!
Per me no. Sarebbe come dire che c’è una bontà nell’assassinio. Io non capisco cosa voglia dire estetica del brutto! Parlare di estetica del brutto equivale a parlare di bellezza del brutto: che senso ha?
Può essere una scelta artistica di rottura con certi schemi mentali ed estetici.
Purtroppo!
Anche Leonardo ha fatto degli studi caricaturali.
Si, ma li ha fatti quando si occupava di indagini che noi adesso chiamiamo scientifiche, mentre allora la parola scienza non esisteva neanche. Leonardo è un precursore della scienza che è nata con Galileo, e quindi non aveva la minima concezione di quello che noi oggi chiamiamo scienza. Leonardo non è stato un vero e proprio scienziato, ma un precursore della scienza moderna.
Quindi Lei contesta che un artista possa scegliere qualcosa che non sia bello come soggetto del suo lavoro?
I pittori che amano il brutto non mirano a far del bene al prossimo, vogliono farsi un nome e basta, fanno come quell’Erostrato che per restare nella storia ha incendiato un tempio.
Non si può dire che non ci sia riuscito! Ma se un artista prende a soggetto il brutto per una forma di protesta contro i mali della società, per denunciare la malvagità dell’uomo o per esprimere la sua tragedia esistenziale, per Lei la sua arte non è esteticamente legittima?
Sarà legittima ma a me non interessa. Prendiamo gli espressionisti tedeschi: me ne sono interessato poco, per la verità; ma li conosco abbastanza. Ci sarebbe da vergognarsi a imparare da loro. Noi italiani non abbiamo bisogno di imparare niente da nessuno. Noi italiani siamo sicurissimamente in testa all’Europa nella pittura, nella scultura e nell’architettura. Poichè l’Europa è in testa al mondo, l’Italia è in testa al mondo: c’è poco da fare! Andare a imparare dai tedeschi!. Vien da ridere. Hanno avuto anche loro dei pittori bravi, giù il cappello!, magari migliori di tanti nostri; ma non hanno mai avuto i colossi che abbiamo avuto noi. Nel mondo si potrebbe fare, insomma, una graduatoria: siamo in testa noi italiani, subito dopo vengono i Paesi Bassi, poi la Spagna; dietro alla Spagna viene la Francia, poi la Gran Bretagna e il resto d’Europa.
Ma Lei non ha mai avuto dubbi estetici nella sua vita? L’arte l’ha sempre vissuta come fatto rasserenante, tendente al bello, anzi espressione totale del bello?
La mia vita è stata tutt’altro che serena. Mio fratello maggiore, a trent’anni, è morto fra le mie braccia. Anche mia madre e mio padre sono morti tra le mie braccia. Ho perso da giovane i miei più grandi amici, Cattaneo e Terragni. Più tardi, Rho. Quindi anch’io ho vissuto le mie tragedie.

Lei però parla dell’arte con un atteggiamento di assoluta serenità, direi con un atteggiamento classico, mentre tutta l’arte moderna si definisce come arte del dubbio, del rifiuto, dell’angoscia, della perdita di un centro metafisico, dello smarrimento dello stesso io dell’artista, e così via. Lei come pensa di accordarsi con questo carattere dominante che la critica, pressoché unanimemente, attribuisce a tutta l’arte del nostro secolo?
La critica d’arte nasce sovente da persone negate alla comprensione dell’arte. Mi interessa quello che pensa Picasso, o De Chirico, o Morandi, o Carrà, o Sironi, o Casorati; non mi interessa niente quello che dice il massimo critico: non lo leggo nemmeno, perché dopo aver letto tre pagine devo smettere. I critici scrivono bene e basta, ma raramente capiscono qualcosa. Tutta questa critica che gira sui giornali e nelle riviste, che senso ha? Chi si ricorda di questi critici dopo che sono morti?
Diciamo, però, che è sempre possibile dare un ‘interpretazione di una certa epoca, anche dal punto di vista artistico.
Certo, ma ci deve pensare lo storico dell’arte, non il critico. E lo storico dell’arte come minimo può interpretare qualcosa di un dato periodo cento anni dopo che tutto è finito, cento anni dopo l’avvenimento in questione.
Quindi oggi non è possibile dare un senso complessivo all’arte del nostro tempo?
No, assolutamente.
Se è così, in che modo è possibile esprimere un giudizio di valore su un quadro contemporaneo?
È facile ravvisare se un’opera d’arte è bella. È una cosa semplicissima, lo sa fare anche un analfabeta, un ignorante.
Come si spiega allora che quando voi del Gruppo Como esponevate l’arte astratta, c’erano dei visitatori che la schernivano, quando addirittura non ci sputavano sopra? Quella gente non era in grado di capirvi o che altro?
È più facile che capisca il bello dell’arte un analfabeta, un ignorante, anziché uno che già possiede delle idee sull’arte che spesso sono sbagliate. Un uomo o una donna analfabeta, ignorante, che di arte conosce zero, se magari vede un quadro e gli si domanda: “Ti piace quel quadro?”, può rispondere: “Che cos’è un quadro? Com’è fatto?” E quando glielo hai spiegato, se il quadro è bello, ti dice: “Sì, mi piace, questo quadro è bello!”
Quindi anche la gente che non sa nulla di arte, ha bisogno di un minimo di conoscenze, di delucidazioni.
Ma questo vale sia per l’arte moderna che per l’arte classica. Io ricordo una mia zia che era innamorata della pittura; naturalmente per lei la pittura bella era la pittura che aveva sempre visto, e cioè la pittura degli impressionisti della fine del secolo scorso e dell’inizio del nostro. Questa mia zia un giorno va in viaggio a Roma e si ferma un’ora col marito a guardare la Cappella Sistina. Quand’è tornata, mi viene a dire: “Io non sapevo che la Cappella Sistina fosse così brutta. È bruttissima!”. Non era ignorante questa mia zia, aveva fatto non so se il liceo o qualcosa di analogo, poi ha smesso, si è sposata, e basta. Io sono rimasto esterrefatto, non ho aperto bocca e ho capito benissimo che cosa voleva dire, perché lei era arrivata a capire, come attualità, solo la pittura impressionista, cioè il paesaggio visto quasi fotograficamente e riprodotto a pennellate larghe. Gente così va alla Cappella Sistina e rimane sconvolta nel vedere tutte quelle figure piene di muscoli. È abituata al paesaggio, alla natura morta, al vaso di fiori e quando vede tutti quei muscoli ci rimane male. Uno che canta o ascolta delle canzonette qualsiasi e poi esce da queste canzoni e ascolta un brano, per esempio, di Stravinskij, come fa a capirlo? Stravinskij è tutto “stonato”!
In genere, però, succede il contrario: si accetta più facilmente la pittura classica o tradizionale e si respinge l’arte moderna.
Istintivamente si è portati al bello. Sempre. Però appena il bello diventa un po’ più complesso o un po’ diverso dal bello che si ha in mente, sorgono tutte le difficoltà di questo mondo. È molto difficile trovare nella gente, nella grande massa, una persona che apprezzi l’arte contemporanea. Molti, vedendo un quadro del grande De Chirico o del grande Picasso, non fanno che dire: “Ma io quello lì non lo metterei neanche nel bagno!” È un’espressione che si sente dire troppo spesso. La stessa cosa non direbbero di un Raffaello, pur non avendo conoscenza nemmeno di Raffaello, perché conoscere Raffaello nella sua grandezza è un’impresa anche quella! Però Raffaello ha un potere magico, cioè è uno dei pochi artisti in tutto il mondo che, a tanti secoli dalla sua morte, piace ancora a tutti, ed è sempre piaciuto. È una cosa curiosa. Le sue pitture sono un vero miracolo, un mistero. Raffaello è insuperabile, è il Bach della pittura.
Mi diceva che Lei canta spesso nella sua mente.
Sì, adesso sì, perché non ho più voce e allora canto mentalmente. Ma ai tempi cantavo bene anch’io e facevo tante volte i cori anche con le figlie, i generi, i nipoti, quando eravamo tutti qui per le feste, a Natale, a Pasqua.
E che cosa cantavate?
Canti della montagna o della guerra. Io facevo il controcanto, nell’altro tono. Qualche volta, quando andavamo a fare qualche gita con gli amici, cantavamo anche in automobile.
Le piace la compagnia, l’allegria?
Quando è una compagnia giusta, di parenti o di amici, sì. Si sta insieme, si chiacchiera del più e del meno, si canta, si beve un buon bicchiere di vino.
Le piace bere del vino?
Si, però ne bevo molto poco, normalmente ne bevo un quarto di litro a ogni pasto, quindi due quarti al giorno. Sono abituato così, non bevo mai acqua a tavola, la bevo alla mattina e alla sera, durante la notte, ma non durante i pasti. Se invece vado in Germania bevo birra, cosa posso fare?
Non Le piace la birra?
Si, ma preferisco cento volte il vino. E a Londra non bevo neanche la birra, perché lì è cattiva. Il vino poi è spesso imbevibile. Per un buon vino bisogna spendere parecchio.
Comunque, il miglior vino è quello che si beve con gli amici.
Ah si! Certamente! Gli artisti vivono quasi tutti isolati, se non lo fossero sarebbe molto meglio per tutti, per la nazione perfino.
Lei è contrario all’isolamento?
Certo. È una pazzia.
Ma che differenza farebbe fra isolamento e solitudine?
La solitudine dell’artista è impossibile, con qualcuno l’artista parla certamente. Questo, in senso assoluto. Se uno si isola completamente, va al manicomio.
Questo è l’isolamento, però io penso che la solitudine dell’artista possa e debba essere una necessità.
Solitudine per qualche giorno, qualche settimana, quando l’artista è totalmente immerso in un lavoro, sì.
Non è uno stato di necessità continua?
Per me no. Basta sapersi concentrare su quello che si vuol fare. È meglio stare con gli amici. L’artista non è altro che un uomo che fa delle cose per amore del prossimo. La parola “prossimo” è chiara anche agli analfabeti. Il prossimo è il vicino. Io non amo un tale che abita nel Nicaragua oppure a New York, che non ho mai visto, o uno che ho visto una sola volta nella mia vita per cinque minuti o magari per mezz’ora, un’ora. Gli amici veri sono quelli che vedi vicino sovente.
Che valore attribuisce, in particolare, all’amicizia?
Un valore enorme, benché la vera amicizia sia rara. Un valore enorme, appunto, perché è rara. Un valore enorme perché il vero amico parla sempre bene dell’altro e non ammette che davanti a lui se ne parli male.
Lei non ha mai avuto nemici?
Sono pieno di nemici, purtroppo. Come si fa a non averne? Non si può non avere nemici, ce li hanno tutti.
Vuol dire che i nemici sono quasi necessari?
Non necessari; inevitabili.
Perché?
Perché nessuno di noi è perfetto e allora chiunque può sbagliare nei giudizi. Siccome qualche giudizio si deve dare, perché bisogna ben dire se una cosa è bella o brutta, uno si fa dei nemici. D’altra parte, a volte bisogna avere relazioni anche con i propri nemici, per necessità professionali magari.
Sa essere diplomatico?
No, non sono affatto diplomatico io, sono proprio negato per la diplomazia, negato istintivamente. La diplomazia la considero un accorgimento magari necessario in certi momenti, ma io non la so usare, non vi sono abituato.
Come si difende dai nemici?
Non mi difendo.
Li ignora?
No, non li ignoro affatto. Non solo non li ignoro, ma siccome mi capita anche di pregare il Padreterno, lo prego anche per i miei nemici, perchè questo è il comandamento del cristianesimo.
Darebbe dei nomi ai suoi nemici?
Ma io non ho nemici dichiarati; nessuno mi ha mai attaccato esplicitamente.
E ai suoi più grandi amici darebbe dei nomi?
I miei più grandi amici sono stati Terragni, Cattaneo e Rho.
E non ne ha avuti altri?
Si, certamente, ma un po’ meno importanti. Parecchi sono già morti, perché i miei coetanei se fossero vivi avrebbero dagli ottanta ai novant’anni. Ne avevo qui a Como e anche a Milano, ma a Milano adesso vado molto di rado. Qualche amico, comunque, è vivo ancora, e ogni tanto ci vediamo.
Vogliamo ricordarne qualcuno?
Benché di rado, continuo a vedere l’architetto Sartoris, che vive a Cossonay-Ville, in Svizzera. Fino a qualche mese fa, ogni tanto mi incontravo con l’architetto Zuccoli, che è morto nella primavera di questo 1985. Ricordo con piacere tutti gli architetti che ho conosciuto negli anni Trenta, durante il sodalizio artistico con Terragni: Piero Lingeri, Luigi Figini, Gino Pollini e Luciano Baldessari, oltre a Zuccoli e a Sartoris. Erano tutti delle persone di grande rilievo, soprattutto Sartoris, Figini e Baldessari. Terragni diceva sovente che Figini era uno dei primi architetti italiani. Per me lo era anche Baldessari.

Quando ha conosciuto Baldessari?
Nel ’27, quando lui ricevette l’incarico di allestire il reparto dedicato all’industria della seta in occasione dell’esposizione organizzata a Como per commemorare Alessandro Volta. Io ho esposto allora per la prima volta un quadro, che naturalmente era figurativo. Baldessari aveva fatto un disegno per la sala delle mostre e me ne ha regalato il bozzetto in occasione delle mie nozze d’oro: ce l’ho ancora. Baldessari era di Rovereto Trentino, di famiglia poverissima; portò a termine gli studi con molti sacrifici. All’università aveva conosciuto il figlio di Enrico Musa, Mario, ed era diventato suo amico. È stato grazie a questa amicizia che ha potuto avere l’incarico della mostra a Como. Aveva anche lui un carattere difficile, ma era un grande architetto e un artista autentico.
E Lingeri?
Era di Tremezzo, sul lago di Como, aveva studiato a Brera ed era diventato professore di disegno architettonico. Allora non c’era il titolo universitario di architetto. Lingeri aveva sempre progettato case e quando fu resa obbligatoria la laurea per esercitare la professione di architetto, fu l’unico in tutta la Lombardia a essere riconosciuto ufficialmente architetto senza esami di laurea, perché era in grado di costruire qualunque cosa, anche un grattacielo.
Quando ha conosciuto Lingeri?
Quando è stato fondato il gruppo “Quadrante”, nel ’32. Il gruppo è stato fondato da questi amici: Terragni, Lingeri, Piero Bottoni, io e qualche altro. Di Como eravamo solo Terragni, Lingeri ed io. La rivista Quadrante, invece, è stata fondata nel ’33.
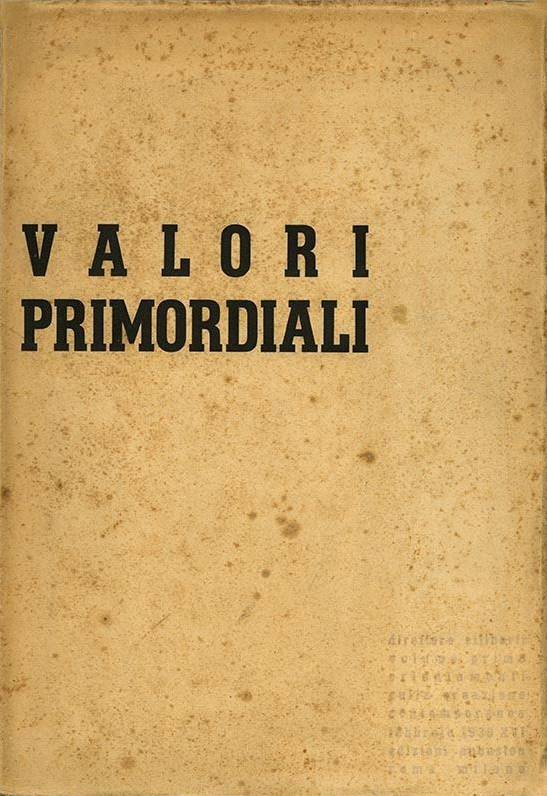
Vorrei fermarmi un momento sul tema delle riviste d’arte alla cui fondazione Lei ha partecipato: nel ’33 – appunto – Quadrante e nel ’38 Valori Primordiali. Quali scopi vi ripromettevate voi fondatori?
Eravamo ogni volta dei gruppi di amici o conoscenti che ci ripromettevamo di fare una rivista un po’ migliore delle altre. Tutto qui. Ogni nascita di rivista è un fatto isolato, soprattutto se si tratta di una rivista d’arte. Dura un anno, due, tre, quando non sei mesi. Oltre i cinque anni non dura nessuna. Si mettono insieme quattro o cinque artisti e fondano una rivista. A Milano, a Roma, ancora oggi ne nasce sempre qualcuna. Finché ci sono i soldi, si va avanti.
Ma l’esperienza del gruppo e della rivista Quadrante, come pure della rivista Valori Primordiali, è servita, per Lei, a qualcosa?
Tutto serve, soprattutto quando si è giovani, pieni di entusiasmo e senza invidia per nessun collega. Ma per l’arte astratta Quadrante è servita ben poco: per esempio, uno dei suoi direttori, Bontempelli, detestava l’astrattismo. Valori Primordiali è stata, diciamo così, l’atto di presenza dell’astrattismo in mezzo a tutte le altre espressioni d’arte di quegli anni, che erano fortemente tradizionali.

A promuovere il gruppo e poi la rivista Valori Primordiali eravate insieme Lei, Terragni e Ciliberti.
Ho ancora un ricordo vivissimo di Franco Ciliberti. Insegnava filosofia al liceo classico di Como. Era uno degli uomini più intelligenti che io abbia conosciuto in tutta la mia lunga vita. Ciliberti aveva anche una memoria straordinaria, era una specie di Pico della Mirandola. Con un’intelligenza e una memoria simile vinceva in qualsiasi discussione, perciò era temuto un po’ da tutti. Oltre a Valori Primordiali promosse la fondazione di altre due o tre riviste, non ricordo bene: tutte riviste di arte e di cultura. Era sposato con Ponina Tallone, a sua volta figlia di Cesare, che era un pittore molto bravo soprattutto come ritrattista.
C’è stato un periodo della sua vita – come Lei stesso ha già ricordato – in cui ha fatto anche l’architetto d’interni.
Sì, ho progettato l’arredamento di alcuni negozi a Como insieme con l’architetto Zuccoli, per esempio la Libreria Noseda. Con Zuccoli ho progettato anche delle tombe per il Cimitero Maggiore di Como.
Seguivate particolari criteri?
Sì, i criteri della proporzione. Non c’è niente di strano nel progettare negozi. Un mercante ha bisogno di rifare il negozio, i due o tre locali del negozio e quelli interni, e allora a chi si rivolge? Si rivolge a un architetto. Zuccoli aveva lo studio di architettura e quindi.
Vi pagavano bene?
Non mi ricordo più. Probabilmente malissimo. Ma io mi arrangiavo con le lezioni private. E anche mia moglie dava lezioni private di matematica. Ne abbiamo già parlato. Mia moglie ed io vivevamo senza pretese. Ancor oggi facciamo una vita semplicissima. Saranno trent’anni che non andiamo più né al cinematografo né al teatro. Io non entro in un caffè da non so più quanti anni. Non spendiamo quasi niente, viviamo di pochissimo. Sa qual è la nostra spesa più grossa? Il taxi, perché non abbiamo l’automobile.
Non avete mai avuto un’auto?
No. Quand’eravamo in grado di guidarla, non avevamo i soldi per comprarla. Adesso che potremmo permettercela, non siamo in grado di guidarla. Ho, invece, avuto una moto; ma è durata tre mesi. Una volta con questa moto mi è capitato un incidente: ero io a guidare, e stavo pure trasportando mia moglie, quando sono andato a sbattere contro un carretto di angurie. Non è stata colpa mia, ma dopo quel capitombolo ho capito che non ero adatto a guidare, e allora mi sono detto: “Adesso, basta!”.
Perché non si è ritenuto adatto a guidare? L’incidente non era avvenuto per colpa sua.
Perché io sono quasi sempre distratto: vedo una cosa che mi piace, allora mi volto, così, e dimentico tutto il resto. Insomma, se qualcosa sono riuscito a fare con la pittura, l’ho fatto non pensando ad altro che a quello. E questo dai trentatre anni in avanti.
Questo significa che l’arte, il pensiero o l’attuazione dell’arte, L’ha assorbito interamente?
Si, senza nessun’altra preoccupazione di mezzo. Ho passato la vita a studiare. Io ho lì una montagna di libri. È naturale che quel poco che sono è dovuto allo studio che ho fatto. Ho passato la vita a studiare e a osservare le opere dei grandi. Dai trenta ai quarant’anni andavo a Brera, a vedere quei capolavori, tre, quattro volte all’anno. Un custode di Brera un giorno mi ha detto: “Lei è sempre qui, cosa ci fa?” “Niente,” ho risposto “vengo a vedere gli stessi quadri”. E così è stato per tante altre gallerie. Nella mia vita non ho avuto altro pensiero che non fosse quello dell’arte. Non sono mai stato un dilettante perché non ho mai pensato ad altro che a finire di dipingere un quadro. Anche adesso che ho ottanta sette anni, mi occupo solo di pittura. Non mi occupo ne di politica ne di finanza. In casa, in famiglia, fa tutto mia moglie; ha cominciato a occuparsi lei di tutto fin da quando è dovuta rimanere a casa per accudire alla nostra figlia più piccola, come Le ho già raccontato. Se dovesse mancarmi lei, non potrei più vivere.
Diceva poco fa che Lei da anni non mette più piede in un caffè.
Da trent’anni non bevo più un caffè, né un tè, né una cioccolata, niente. E questo, da quando sono stato operato a entrambi gli occhi.
Che operazione ha subito?
Ho sofferto di glaucoma, e sono stato operato prima all’uno e poi all’altro occhio, alla distanza di quindici giorni.
Quando è successo?
Nel 1957.
Dopo, ha continuato a vederci bene? Per un artista visivo la vista è un bene essenziale, naturalmente.
Sì, ancor oggi vedo bene; solo che sono diventato un po’ miope e mi devo far aiutare dalle lenti.
Questo non Le impedisce minimamente di lavorare.
Assolutamente no. Leggo ancora senza occhiali. Devo solo avere una buona illuminazione.
Lei diceva di aver provato nella sua vita il senso della morte quando Le sono venuti a mancare il fratello, la madre, il padre e gli amici suoi più cari. Qual è stato il suo atteggiamento di fronte a questo evento?
A vent’anni non ho mai pensato alla morte, neanche quando ero in pericolo, neanche quando ero in guerra. Ho incominciato a pensarci dopo i quarant’anni. Più è passato il tempo, più ci ho pensato. Non è che si viva pensando continuamente alla morte, ogni tanto viene in mente questo “fenomeno”. Però io credo nella vita eterna e quindi vivo abbastanza serenamente. Mi spaventa il fatto che la morte non sia mai allegra, sia sempre dolorosa. L’unica consolazione è che, nonostante i dispiaceri, la vita vissuta è sempre bella. I vecchi imparano ogni giorno qualche cosa di nuovo e quindi imparano anche perché si deve morire. Non si può continuare a vivere in eterno una vita che è legata al corpo, il quale degenera di minuto in minuto. A un certo punto il corpo non regge più. E la vita è sempre la stessa che continua.
Però rincresce un po’ pensare che, magari fra dieci, vent’anni, sarà scoperta qualche sostanza in grado di allungare la vita per moltissimi anni ancora.
Ma a me non importa niente di cinquanta, di cento, di mille anni in più! A me interessa solo l’eternità.
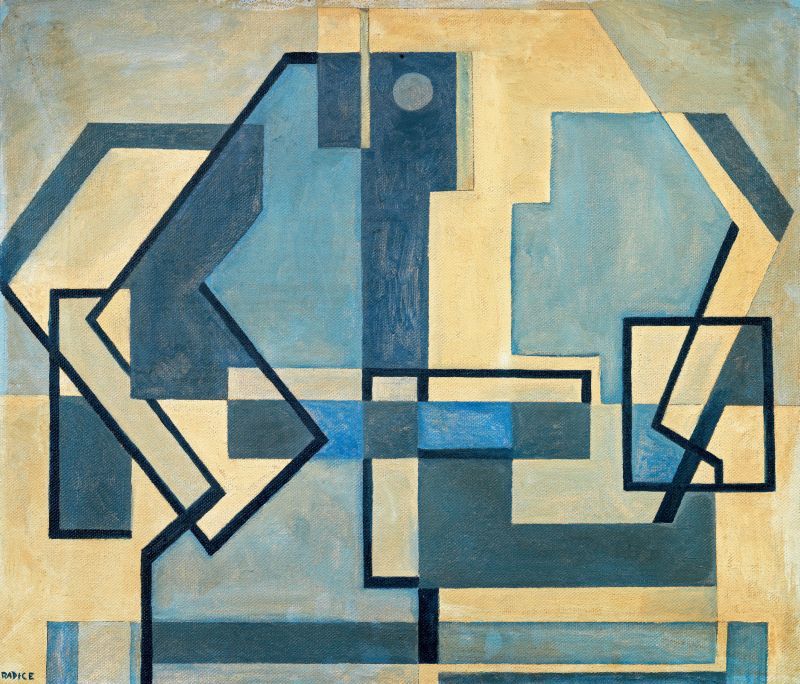
Per Lei che cos’è la vecchiaia?
La vecchiaia è il principio della fine. Da quando nasce l’uomo continua a crescere fino a una certa età, come una pianta, un animale qualunque, cioè la sua vitalità aumenta e migliora e arriva a un certo culmine: ma questa è sempre una mentalità materialistica, per così dire, non so chiamarla diversamente. Intorno ai trenta, trentacinque anni l’uomo è forte come un cavallo, animale che dicono nobile, poi comincia il declino. Adesso qualche scienziato dice che l’animale più intelligente che si conosca è il cavallo, più intelligente del gatto, del delfino e del cane. Il cane è sempre indietro al gatto, è più affezionato all’uomo, ma l’affezione non corrisponde all’intelligenza.
Lei ama gli animali, ne ha avuti in casa?
Sì, li rispetto, più che altro, come tutte le creature di Dio. Una volta in casa abbiamo avuto un gatto. Era molto buono, non sporcava, faceva le feste a tutti, era straordinario. Un giorno è andato fuori ed è tornato con un occhio tutto graffiato e purulento. Avevamo le figlie piccole e temevamo per la loro salute, allora abbiamo chiamato il veterinario, e quello ha detto: “Bisognerebbe fargli delle iniezioni di penicillina”. Gliele ha fatte mia moglie, che lo prendeva in grembo; e lui ci stava, fermo, come se capisse. Gli ha fatto una scatola di flaconi di penicillina, e non è stata mai graffiata. Però non è riuscita a salvarlo. Siccome peggiorava abbiamo nuovamente chiamato il veterinario, che gli ha fatto una iniezione definitiva: ci ha fatto molta impressione veder morire quel gatto; si è tirato via così. Dopo abbiamo detto: “Basta, non prenderemo più bestie in casa”.
Come l’avevate chiamato, quel gatto?
Ah, niente! Un gatto! Era proprio trattato da gatto e basta.
Era un gatto senza nome.
Un bel soriano grigio. Nello stesso periodo tenevo in casa una vasca con i pesciolini rossi. Il gatto infilava dentro la zampa e me li faceva saltar fuori.
Lei prova più simpatia per il gatto o per il cane?
Mi sono simpatici tutt’e due. Quand’ero ragazzo giocavo spesso con il cane di mio nonno, a Carbonate: mi seguiva dovunque andassi, io lo carezzavo, gli parlavo, facevo così, è importante per le bestie. Però alle bestie non si può insegnare niente di spirituale. A un cane si può insegnare a cercar tartufi, a trovare un ladro; ma si tratta sempre di qualcosa di materiale e di meccanico. Non si può insegnare alle bestie una parola, qualche cosa di più del fatto materiale. Un animale può arrivare con la sua intelligenza a fare certi mestieri che abbiamo già visto, però non può mai arrivare a capire nozioni filosofiche.
Gli animali hanno, quindi, un certo grado d’intelligenza.
Certamente. Se permette una piccola parentesi, sono intelligentissime le zanzare, per esempio. Io per motivi particolari ho dovuto stare un po’ di tempo in paesi dove imperava la zanzara. In Italia, sul Tirreno, nella Toscana al confine con il Lazio ho lottato contro le zanzare. Ero all’albergo, naturalmente, e ho domandato al cameriere: “Ma perché non impedite alle zanzare di entrare nelle camere?” E quello: “Come si fa a impedirglielo? Si mettono lì in trenta o quaranta vicino alla porta, appena uno entra, entrano tutte!”. Lei non sapeva questo particolare dell’intelligenza delle zanzare?
No, immaginavo qualcosa del genere per le mosche, che trovo fastidiosissime.
Ascolti, ascolti bene. Mi mettevo a letto e subito cominciava la lotta con le zanzare. Un giorno, due, tre, quattro: poi non ne posso più e allora do una mancia al cameriere per aiutarmi a vincerle. “C’è un sistema” mi dice il cameriere. Da notare che in quell’albergo tutte le finestre avevano la rete. Io ero al secondo piano e potevo dormire con la finestra aperta, tanto attraverso la rete le zanzare non passavano. Le zanzare entravano solo dalla porta. Allora il cameriere mi ha spiegato: “Lei prenda una salvietta e l’appallottoli per bene: siccome, quando si accende la luce, vanno a rifugiarsi sul soffitto, gliela butti addosso”. Doveva essere una specie di sfera morbida che trascinasse le zanzare nella caduta, anche contro la loro volontà. Loro sapevano che fine avrebbero fatto. Lanciavo il panno appallottolato, ne trascinavo trenta, quaranta, cinquanta nella discesa: cadevano e morivano schiacciate, e questo per due o tre volte, ma non riuscivo mai a eliminarle tutte. Le superstiti si rifugiavano in un angolo del soffitto, tra il soffitto e la parete, e bastavano a impedirmi di dormire. Sa perché si rifugiavano in quell’angolo? Perchè in quell’angolo il proiettile arrivava, sì, ma ne lasciava scoperto qualche centimetro: le zanzare capivano che l’angolo era una salvezza, e si posavano solo in quel piccolo spazio. Erano intelligenti. E poi in questa lotta ne restava magari una sola viva. Io mi dicevo: “Adesso sono in pace”. Invece che mi succede? Arriva la zanzara e si posa qua, sulla punta del naso, poi si posa su questo orecchio, poi su quest’altro. Perchè si posa lì? Perché non si può menare uno schiaffo o un pugno sul proprio naso o sulle proprie orecchie. Quindi le zanzare sapevano che con la mano potevano essere colpite, ma non su certe parti del corpo umano. Se si fossero appoggiate sulla fronte, le si poteva ammazzare; mentre sulla punta del naso e sulle orecchie, no. Non c’è che dire, anche le zanzare sono intelligenti. Figurarsi poi un cavallo, un gatto o un cane: sono intelligenti. Che cosa manca all’animale? Non l’intelligenza, certamente.
Dicevamo che l’uomo a trenta, trentacinque anni è forte come un cavallo.
Sì, salvo che al cavallo manca qualcosa come alla zanzara.
Mentre all’uomo?
All’uomo non manca, per esempio, il dono della ricerca. L’uomo cerca, si domanda: “Cosa sono venuto al mondo a fare? Sono venuto al mondo per un caso qualsiasi, come un animale qualunque?” C’è un bel salto perfino tra il primate e l’uomo.
Tornando al senso della vecchiaia, vorrei domandarLe: quando s’incomincia a essere vecchi? Forse quando si smette di crescere?
No, quando si smette di essere sciocchi. La saggezza è uguale alla vecchiaia.
Ma ci sono anche dei vecchi balordi.
Come ci sono dei giovani saggi. Ma in media, per legge di natura, la saggezza viene con la vecchiaia, purtroppo è così. Solo adesso io comincio a capire che è giusto sia così; che è normale, regolare. Se avessi capito a diciotto anni quello che capisco adesso, forse non avrei nemmeno incominciato a dipingere, tanto non si guadagna niente, si soffre e basta. Il mestiere dell’artista è un mestiere che dà sofferenza.
Ma per Lei che l’ha praticata per tutta la vita, a che cosa è servita l’arte? Che cosa Le ha dato? Che cosa Le ha tolto?
Mi ha dato tanta sofferenza, come ho detto; ma, devo dire, anche tanta gioia. Che cosa mi ha tolto? Non saprei. Non mi ha fatto arricchire materialmente, questo sì; però mi ha dato tanta ricchezza interiore, tanta consolazione spirituale. Adesso ho consapevolezza di questo: e cioè che si è sempre deboli e imperfetti. A venti, a trenta, a quarant’anni non ci si bada granché, perché la salute è buona, si resiste a tutte le intemperie, si affronta qualsiasi sforzo e quindi uno si crede perfetto. Ma non è così: perfetto non c’è nessuno. In fondo la vecchiaia è un grosso mistero. La vita è tutta un mistero; ma la vecchiaia, che è l’ultimo stadio della vita, è il mistero più profondo.
Quale virtù apprezza di più nelle persone?
La bontà, perché è certamente la virtù che rende più facile e piacevole vivere.
E il difetto che Le dispiace di più?
L’ipocrisia; preferisco una critica aspra e cattiva a un falso complimento.
Sul finire di queste nostre conversazioni, vorrei farLe una domanda davvero “radicale”.
Dica pure.
Chi è Mario Radice?
È un uomo con molti difetti come tutti gli altri, ma che cerca ancora di rimediarvi.
E come artista?
Come artista è facile giudicare un altro, ma è difficilissimo giudicare se stesso. Io, per natura, non sono mai contento di quello che faccio e sono severissimo verso me stesso. Ma fortunatamente ho anche la speranza di aver fatto tutto quello che era in mio potere per “cantare” sempre meglio.

